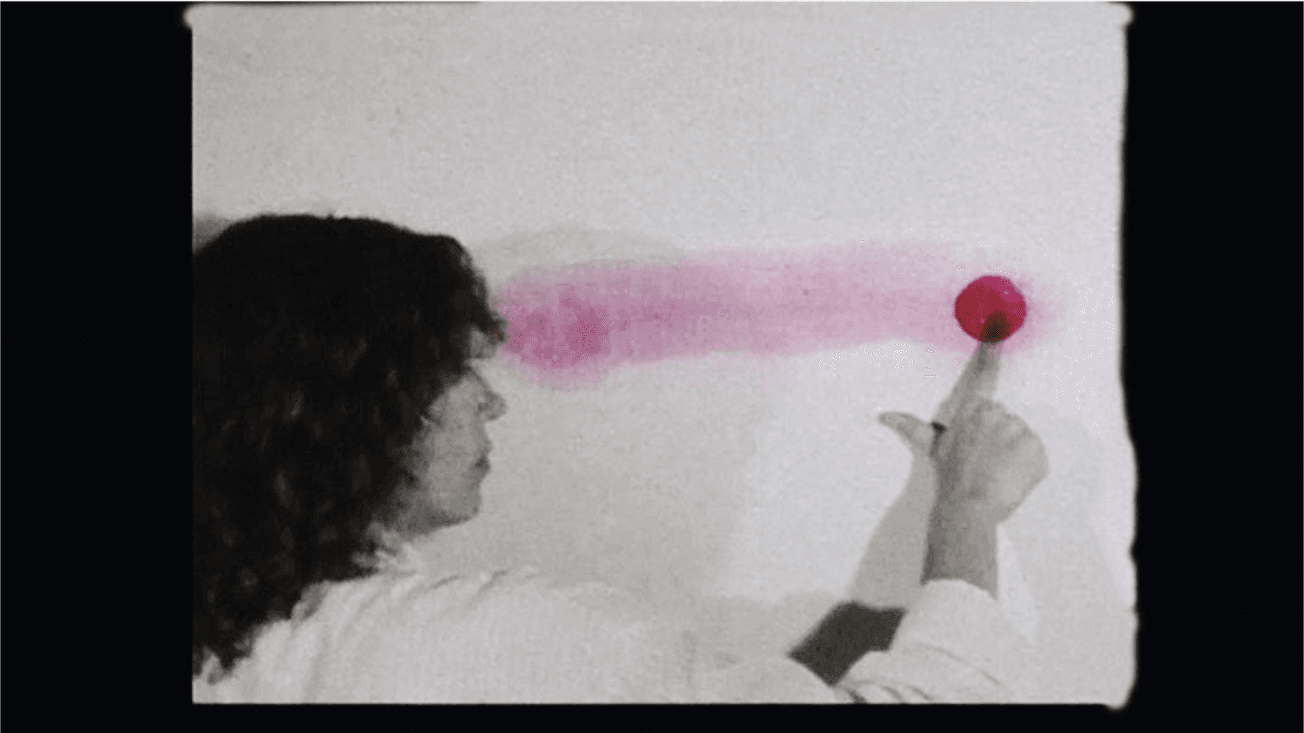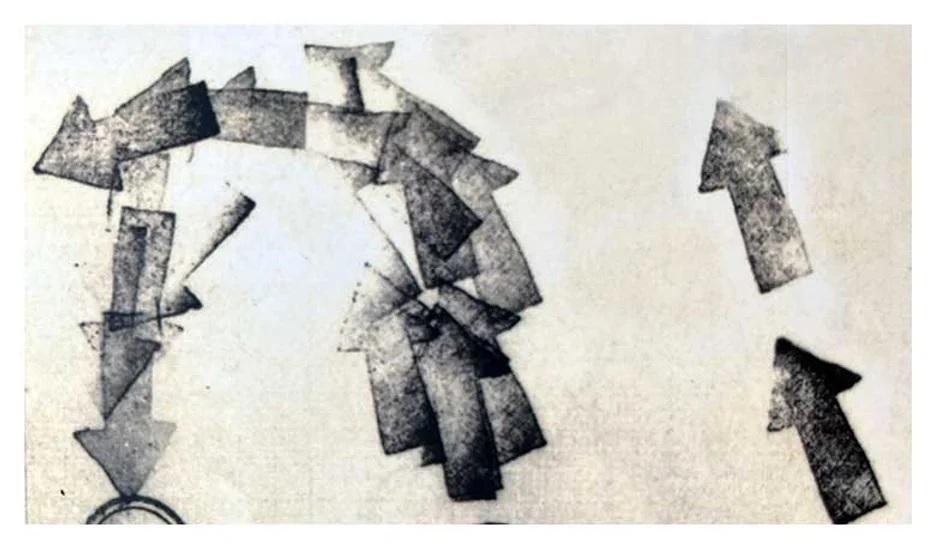La prima crisi veramente globale?
di Raffaele Sciortino_
La crisi finanziaria con epicentro negli States procede per ondate successive che ne approfondiscono e ampliano la portata. Crisi dei subprime, poi restrizione del credito tra banche, a seguire caduta generalizzata dei prezzi immobiliari [prima volta dalla II guerra mondiale] con forti perdite nei bilanci delle istituzioni finanziarie e… probabilmente recessione reale. Mozzafiato gli interventi statali diretti e i salvataggi sponsorizzati nella patria del «liberismo»: dopo la statalizzazione di Fannie e Freddie, il salvataggio della Merryl Linch da parte di Bank of America e quello della Aig da parte della Federal Reserve, infine il fallimento di Washington Mutual, la più grande cassa di risparmio statunitense, acquisita poi da JP Morgan e l’assorbimento di Wachovia da parte di Citigroup. Ma la carta straccia è anche, e pesantemente, nei bilanci delle banche europee: di qui la prima tranche, in questi giorni, di nazionalizzazioni e salvataggi dall’Inghilterra alla Germania passando per Bruxelles. «E’ solo l’inizio – afferma un analista londinese – vedremo banche nazionalizzate, assorbite da altri gruppi e per qualcuna ci sarà anche il default».
Le misure una tantum fin qui usate per correre in soccorso degli istituti finanziari però non bastano più. Così, il Tesoro Usa ha tentato il colpaccio con un piano complessivo da 700 miliardi di dollari [pari più o meno al Pnl di Taiwan, ventunesima economia mondiale]. Ma nonostante l’allarme rosso delle borse, le rassicurazioni dei leader del Congresso nonostante i forti malumori dei peones, l’intervento diretto di Bush con un appello alla nazione, l’avallo dei due candidati presidenziali – il piano per ora non è passato. A dimostrazione che la crisi inizia ad avere ripercussioni anche politiche.
Il Piano Paulson. Si tratta di un maxi-fondo pubblico che assorbendo i crediti «tossici» inesigibili degli istituti di credito, punta a stoppare la discesa dei prezzi e a sbloccare l’arresto del credito [credit crunch] che si sta trasferendo all’economia reale. E’ un piano che salva, sistematicamente, le società responsabili del disastro finanziario senza offrire nulla alla gente comune oberata di debiti [dai mutui alle carte di credito]. I lobbisti finanziari, aiutati dalle manovre dei repubblicani, avevano ottenuto che il salvagente pubblico valesse per ogni tipo di credito compresi quelli detenuti dai fondi pensione e speculativi, i derivati, ecc.! L’intenzione è di nazionalizzare carta straccia a spese del contribuente senza neanche uno straccio di interventismo a favore di Mean Street [l’uomo della strada]. Non è passata in roima lettura la richiesta democratica di misure legali minime a favore delle famiglie espropriate della prima casa [inoltre i repubblicani avevano ottenuto di eliminare ogni riferimento a fondi per l’edilizia popolare] mentre i vincoli posti agli stipendi dei manager erano cosmetici. Del resto Paulson, che aveva preparato un piano di tre paginette con ancora più discrezionalità per il Tesoro, era stato chiaro: «La protezione fondamentale del contribuente la darà la stabilità del mercato che si garantisce in questo modo». Il pubblico però aveva da subito reagito male al ricatto posto da Bush su un piano che salva solo i ricchi. Così, nonostante l’assegno in bianco iniziale fosse divenuto un corposo progetto di legge, alla Camera hanno per ora votato contro un buon numero sia di democratici che di repubblicani. «Per i primi, il piano era troppo sbilanciato verso le «major» di Wall Street. Per i secondi, il piano, basato sulle finanze pubbliche, era in odore di «socialismo». Wall Street risponde in caduta libera.
Basterebbe? Fin da subito si era posta una domanda: è sufficiente? E quali le conseguenze? Un primo problema è trovare tutti quei soldi: il debito pubblico complessivo salirebbe ulteriormente anche rispetto all’ancora corposo Pil statunitense [il deficit statale federale sarà quest’anno, con tutti i salvataggi operati, al 10 per cento del Pil a un livello visto solo con la Seconda guerra mondiale] mentre quello complessivo è già a cifre stratosferiche. Sarà necessario finanziarlo con crediti da fuori [nessun politico per ora parla di aumentare le tasse] appesantendo il debito estero. «Qualcuno pensa anche che l’onere di riparazione di un sistema finanziario disastrato potrebbe mettere a serio rischio lo status del dollaro come moneta di riserva mondiale», scrive l’Economist.
Inoltre, i settori a rischio non sono oramai solo più quelli legati ai mutui subprime ma – ancora l’Economist – l’insieme dell’industria finanziaria: «lo stesso fenomeno che osserviamo con le case lo stiamo vedendo nei prestiti per l’acquisto auto, le carte di credito e le borse di studio». In effetti, è oramai in moto una dinamica che conduce tutti gli istituti finanziari a vendere per ridurre l’indebitamento [deleveraging: ridurre il rapporto pazzesco tra titoli e assets reali] spingendo così ancor più in basso il valore dei beni in una spirale difficilmente arrestabile. Potrebbe quindi già essere troppo tardi per evitare conseguenze più pesanti.
Il quesito di fondo è quello che inizia a farsi strada: questo piano o uno simile potrà essere all’immediato necessario, ma sarà davvero efficace? Su questo liberisti del Financial Times [come il guru Martin Wolf ] e dell’Economist così come liberal democratici del New York Times [come Paul Krugman] sono in fondo d’accordo nelle critiche: il Tesoro e la Fed stanno affrontando la crisi come se si trattasse di un problema di liquidità da immettere nel circuito per arrestare la spirale al ribasso dei prezzi, ricreare fiducia e poi rivendere i titoli acquistati in un mercato stabilizzato. Ma il problema è a questo punto sempre più di insolvenza di quel «sistema bancario ombra» fatto di prodotti finanziari derivati figlio della deregulation e delle bolle speculative degli ultimi decenni [si parla di cifre astronomiche pari o superiori al prodotto lordo mondiale]. «Quando lo stock di debito lordo è enorme e le condizioni economiche difficili, c’è alta probabilità di numerose bancarotte. La gente teme l’insolvenza di massa, i prestatori smettono di dare in prestito e gli indebitati di spendere. Il risultato può essere la deflazione da debito». Il mercato interbancario già lo segnala col rialzo dei tassi, il mercato monetario è sotto tensione. Tutto ciò non si risolve con iniezioni continue di liquidità ma ricapitalizzando il sistema, come propone anche il direttore del Fmi Strauss-Kahn: «Al cuore del problema c’è il fatto che il sistema finanziario ha troppo poco capitale» per reimmetterlo nel circuito reale traendone profitto. Già ma ricapitalizzare significa innanzitutto raccogliere quote enormi: da chi, a quali condizioni [si accetteranno i cinesi nei consigli di amministrazione?]], con quale prospettiva? Significa comunque operare un trasferimento colossale di ricchezza che il Fmi e Wall Street hanno potuto imporre nei decenni passati nel Sud del mondo ma difficilmente ora hanno il potere di riproporre in quelle forme alla popolazione in Occidente e all’Asia. Significa, inoltre, ripristinare le basi complessive del ciclo del valore e creare nuove condizioni della domanda globale per rimettere in moto l’accumulazione. Insomma, l’impressione che si trae dal dibattito negli States, al momento, è che non si coglie la profondità della crisi di un intero modello di crescita drogata dal debito quasi si potesse, dopo la tempesta, riprendere tutto tranquillamente come prima. Mentre il modello americano ha sempre meno appeal, mancano idee propulsive come anche il confronto Obama-McCain sta evidenziando. Chi può permettersi di parlare esplicitamente di declino della potenza statunitense senza essere punito dagli elettori? L’obbligo tutto americano del «pensare positivo»- fa notare lucidamente la vetero-cons Barbara Spinelli – impedisce di guardare con coraggio nel baratro che si sta aprendo.
L’equazione globale di potenza. La crisi in corso è dunque strutturale non solo perché ha colpito il centro del sistema mondiale ma anche perché sta investendo, con conseguenze ancora incerte, il ciclo mondiale di riproduzione del valore degli ultimi trent’anni e dunque l’equilibrio globale di potenza che su di esso si è costruito. In questo siamo veramente all’[inizio della] fine di un’era. La fuoriuscita dalla crisi economica degli anni Settanta e la risposta capitalistica al formidabile ciclo di lotte dell’operaio massa e dei popoli coloured si erano concretizzati dagli anni Ottanta in poi in una ristrutturazione del mercato mondiale: Dal rapprochement tra Usa e Cina, al corso denghista del «socialismo di mercato», fino alla globalizzazione neoliberista, era sembrato che gli Usa potessero svolgere il ruolo di egemone fornitore della stabilità sistemica, a maggior ragione dopo il crollo dell’Urss e lo stabilirsi del «momento unipolare». In realtà, questo corso ha via via mostrato la sua fragilità dimostrandosi incapace di replicare i successi del ciclo fordista precedente. Da un lato ha infatti accentuato la finanziarizzazione rapace dell’economia Usa e gli squilibri globali sintetizzati nel doppio deficit commerciale e dei pagamenti; dall’altro ha permesso il decollo e l’affermazione della Cina come nuovo «opificio del mondo» ma legandola a doppio filo al mercato interno e al finanziamento, con i propri surplus commerciali, dell’indebitamento crescente degli Stati Uniti. I nodi di quella che fin qui è stata la tenuta di Chimerica [come la chiama lo storico di Harvard Niall Ferguson ] e del mercato mondiale iniziano però a venire al pettine. Sia sul versante del contratto sociale tra finanza e cittadino-consumatore negli Usa [ma sempre più in tutto l’Occidente] che ha sostituito con la privatizzazione individualistica del welfare il vecchio compromesso keynesiano-fordista facendo della domanda da indebitamento crescente della gente comune [debt peonage] la base sempre più ristretta della piramide finanziaria [e che ora rischia di frantumarsi]. Sia per il rischio di trascinare, o comunque influenzare pesantemente, l’intero sviluppo asiatico nei vortici della crisi alla faccia dei teorici del decoupling crescita asiatica/crisi Usa. Sia, infine, per la crisi irreversibile del Washington Consensus e della forma neoliberista della globalizzazione [che non vuol dire affatto possibilità, dato l’intreccio globale della produzione e della finanza, di tornare indietro a uno sviluppo incentrato e diretto dallo stato-nazione!].
Novità e continuità. La novità sta dunque nell’incrinarsi evidente del controllo Usa sul ciclo di riproduzione del capitale globale, in particolare di fronte all’emergere dell’Asia. La capacità di Washington di risucchiare via predominio del dollaro e della finanza oltreché via guerra il valore accumulato dai centri capitalistici emergenti nelle ex-periferie, principalmente in Asia Orientale, garantendo al contempo la stabilità del sistema è palesemente in difficoltà. L’esperienza della crisi asiatica del 1997-8 ha rappresentato per quei paesi una soglia cruciale palesando l’arroganza di Usa e Fmi a fronte dell’incapacità di porre ordine negli squilibri globali, anzi usandoli per accaparrarsi i pezzi migliori delle economie asiatiche. A dieci anni dalla crisi gli effetti della reazione asiatica sono evidentissimi: fine dell’indebitamento col Fmi [ridotto oramai a istituzione fantasma], ripresa economica incentrata sulla crescita cinese, rapporti inter-asiatici meno asimmetrici di quelli con l’Occidente, e su tutto primi passi verso la costruzione di un mercato asiatico più integrato facente perno sulla Cina. E’ su questo complesso emergente, oltreché su un America Latina che cerca di integrarsi e su una Russia in ripresa [ma addirittura le petrolmonarchie palesano qualche velleità autonoma], che gli States non riescono più a scaricare la crisi come prima. Al tempo stesso, la continuità nell’attuale fase sta in una struttura della divisione internazionale del lavoro che resta incentrata sullo stretto legame Usa-Cina. Un’equazione destinata nel [medio]-lungo periodo a dissolversi, ma che a breve resta una necessità anche per la dirigenza cinese. Il paradosso dell’attuale situazione sta nel fatto che il rafforzamento cinese nei confronti di Washington è condizionato dalla prosecuzione della cooperazione economica con gli Stati Uniti. Una cooperazione a cui è costretto ancor più l’establishment statunitense con la crisi in corso e il bisogno urgente di fondi [due miliardi di $ al giorno; la Cina da sola sta prestando agli Usa per il 2008 l’equivalente di due volte e mezzo il Piano Marshall per l’Europa del 1947]. In questo quadro, tendenzialmente sempre più incerto – c’è chi su Foreign Affairs parla oramai di fase a-polare – gli altri attori di media potenza della politica globale si fanno avanti giocando, come la Russia, sulle debolezze statunitensi senza al momento potere né volere intraprendere un corso di piena e dispiegata rottura. La loro azione, di per sé non centrale, potrebbe però precipitare situazioni di crisi [v. Georgia] proprio in relazione alla fragilità crescente degli equilibri globali.
E’ altrove che è più opportuno guardare per abbozzare una risposta a cosa possa oggi significare un’economia altra possibile, come produzione e riproduzione dei commons a scala finalmente globale. Il movimento no global, nella sua dinamica profonda, ha iniziato a porre la questione senza poterla però radicare nel profondo della società [e, rispetto all’Asia, dovendosi fermare a Bombay] . La crisi finanziaria, se dovesse approfondirsi, dislocherà quella domanda immettendola di forza nella vita pratica di tutti e preparando il dispiegarsi di conflitti sul terreno del debito, della rendita nelle sue molteplici forme, della finanziarizzazione come sintesi capitalistica dell’espropriazione della vita nella sussunzione reale.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.