
Confluenza – Per il bisogno di confluire tra terre emerse
Perché Confluenza?
Forse è tardi per realizzare una confluenza umana che si opponga all’avanzare del mostruoso processo di espropriazione di territori, beni comuni e diritti, in corso da decenni. Ma meglio tardi che mai: al punto in cui siamo, non unire le forze contro l’aggressione neoliberista per riuscire a imporre le nostre decisioni, miranti a una reale transizione socioecologica, può significare semplicemente la fine dell’umanità e delle altre forme di vita. Perciò le persone che hanno scritto questo documento lanciano un appello per la confluenza delle energie di tutti coloro che hanno a cuore i loro territori.
Il processo estrattivista di cui parliamo mercifica ogni cosa: acqua, suolo, fuoco (energia) e aria (vedi mercato delle emissioni di CO2). Divora risorse, emette rifiuti e spesso mercifica anche quelli. Espelle nocività che contaminano i territori e fanno ammalare e morire le persone.
È intensivo, perché sfrutta al massimo le capacità produttive di un territorio; è estensivo, perché quando finisce di spremere valore da un’area la abbandona e ne assalta un’altra. Estromette anche i piccoli attori privati, favorendo cartelli e monopoli. Si appropria di beni pubblici e li privatizza, o li distrugge per produrre profitti privati. Riduce in miseria i poveri, in povertà le classi medie, accumulando e accaparrando ricchezza. In qualunque sua operazione, se i costi superano gli utili, fa in modo di socializzare i primi e privatizzare i secondi. Fa coincidere con il mercato il mondo intero, lo spazio e il tempo: estrae valore dal tempo libero e persino dal volontariato, trasformato in terzo settore. Non distingue tra legalità e malaffare e tende a corrompere le istituzioni, porsi al di sopra delle leggi nazionali, per esempio con i trattati di libero mercato. Agli Stati chiede di lasciargli mano libera e di reprimere il dissenso.

Nel cercare di combattere il capitalismo nel suo stadio attuale e soprattutto di prevedere le sue prossime mosse, che è uno degli obiettivi cui dovrebbe tendere il confluire dei movimenti, dobbiamo anche essere consapevoli che l’ingordigia del sistema non è sempre razionale. È una bulimia cieca, meccanica. Oggi è certamente orientata ad approvvigionarsi di quelle risorse (per esempio le terre rare) richieste dallo sviluppo delle tecnologie digitali (anche belliche) e a estrarle spasmodicamente sia in altri continenti, sia in Europa (per esempio con il progetto di miniere di cobalto in Val di Viù e Val d’Ala). Invece, nonostante le dichiarazioni, i piani e i summit internazionali, quest’ultima non è affatto intenzionata a operare una reale transizione energetica/ecologica, perché questa implicherebbe in primo luogo una riduzione drastica dei consumi e delle attività: cioè, la fine della crescita, ossia la fine del sistema stesso. Quindi la transizione messa in scena dall’alto è una mistificazione in cui si prosegue lo sfruttamento delle fonti fossili, comprese quelle per cui l’estrazione e la raffinazione sono più inquinanti (per esempio il petrolio e il gas di scisto, estratti con il fracking), mentre in parallelo si introducono impianti eolici e fotovoltaici rigorosamente di dimensioni enormi, di cui enormi sono anche i guadagni. E non è tutto, si fanno rientrare assurdamente nelle fonti energetiche rinnovabili anche i rifiuti e le biomasse legnose.
In sostanza, anche se non operare una reale transizione energetica conduce al disastro, al sistema non interessa, perché è assolutamente incapace sia di invertire la rotta sia di decelerare e di immaginare soluzioni che non si basino sullo sfruttamento e sul sacrificio ambientale e umano. Stiamo quindi passando dal “capitalismo dei disastri”, così definito da Naomi Klein nel 2007, al capitalismo del Disastro. Questo è evidente anche dalla mastodontica contraddizione tra la transizione ecologica e l’esplicito rischio di scatenare una terza guerra mondiale, magari nucleare. L’Unione Europea, nata come comunità economica idealmente paritaria e solidale, involutasi con i trattati e la creazione dell’Eurozona in associazione di mercati basata sulla concorrenza e sulla subordinazione di alcuni Paesi a favore di altri, ha finito per degradarsi a servile propaggine degli USA. Così oggi l’UE si riarma e butta la pace alle ortiche, mentre schizofrenicamente approva la Nature Restoration Law che prevede il ripristino degli ecosistemi.
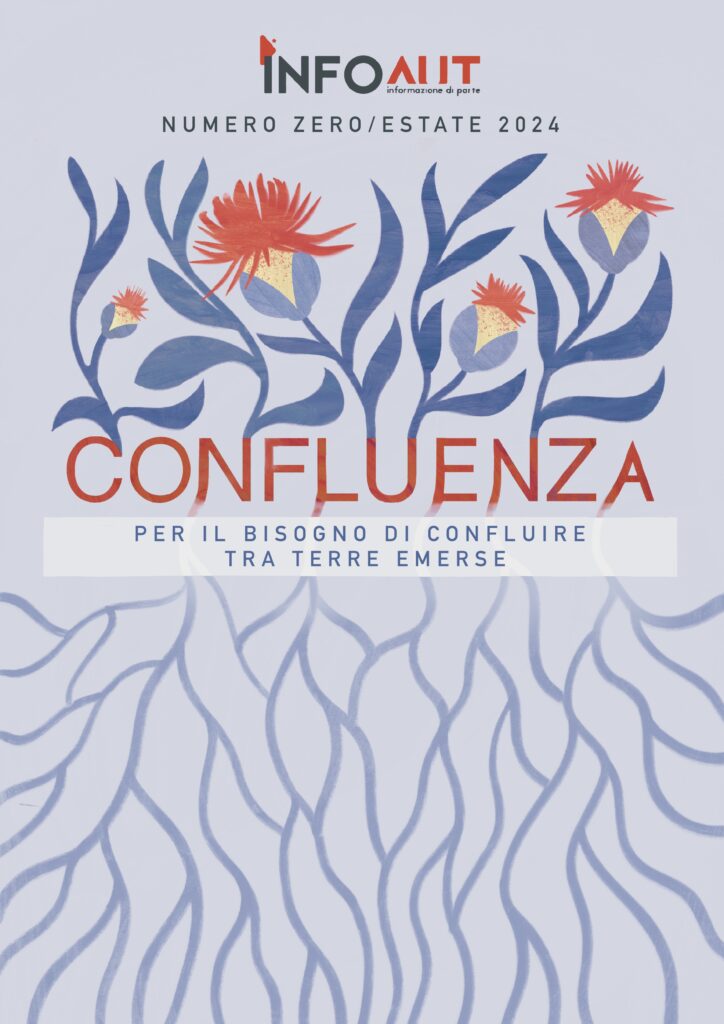
Il “capitalismo dei disastri” ha seminato e coltivato per oltre settant’anni situazioni di shock sociopolitico in cui attuare programmi di spoliazione di risorse e di diritti, attraverso colpi di stato e guerre, dall’Iran all’Ucraina. Nel Terzo Millennio ha anche spremuto profitto dalle calamità naturali: alluvioni, uragani, tsunami, terremoti, come visto per esempio, relativamente in piccolo, nel caso del sisma dell’Aquila. Estesa la propria azione sull’intero pianeta attraverso la globalizzazione, il neoliberismo nella sua attuale fase ha iniziato a spostare o cancellare la linea tra le due aree geografiche della società contemporanea: “la zona dell’essere, dove i diritti vengono rispettati e dove la violenza è un’eccezione, e la zona del non-essere, dove la violenza è la regola”1. Una linea che correva per lo più tra il nord e il sud del mondo, tra i luoghi in cui il neoliberismo ha anche la faccia di neocolonialismo e i luoghi in cui del neocolonialismo si godono i frutti.
Con il genocidio in corso in Palestina ad opera di Israele, il capitalismo svela la sua essenza profonda di forza bruta, antitetica all’umanità e alla vita stessa. Ciò che accade in Palestina oggi è la manifestazione più cruenta di un sistema di dominio e sfruttamento che, su scale indubbiamente diverse e su diverse intensità, vive chi si trova ad essere in basso nella gerarchia sociale. Il tentativo di liberarsi da queste catene, come insegna l’esempio della resistenza palestinese, è però un dovere e un compito essenziale oggi.
Prove tecniche di ampliamento della zona del non-essere sono state fatte negli ultimi anni in aree circoscritte, per esempio in Francia nel Poitou, dove una parte della popolazione si oppone alla costruzione di grandi invasi, e in Italia in Valsusa, dove molti cittadini lottano contro il TAV. Negli ultimi tempi il confine del non-essere sta circoscrivendo anche le periferie delle nostre città, come a Bologna, dove l’opposizione del Comitato Besta alla demolizione di una scuola e di un parco pubblici sta venendo repressa con violenza crescente. In questo caso, come in molti altri, gioca un ruolo importante, di nuovo, l’UE con la sua politica di distribuzione di fondi: quelli del PNRR (in parte a debito), REACT, PON METRO, PIU e via siglando. Tipicamente, il PNRR risponde a un’emergenza perpetuandola: vale a dire che, nato a seguito della crisi pandemica, spinge la politica a produrre progetti come se si trattasse di ordinanze: senza condivisione con i cittadini, in barba a quella democrazia partecipata che l’Unione Europea stessa dice di voler promuovere. In Italia appuriamo che ciò avviene senza nemmeno condividere i vari passaggi con i consigli comunali, e quindi anche in spregio della democrazia rappresentativa. Inoltre saltano tutti i controlli ambientali, paesaggistici ecc. Si è creata, in sostanza, anche nei Paesi europei, quella situazione di deregulation emergenziale che caratterizza appunto la shock economy.
Milioni di fondi europei vengono così distribuiti dagli enti pubblici a soggetti privati per progetti distruttivi mentre, con la scusa che “non ci sono i soldi”, si comprime sempre di più la spesa pubblica, già bloccata da misure di derivazione europea, come il pareggio di bilancio e il conseguente patto di stabilità, che obbligano lo Stato e gli Enti locali a fare tagli ai servizi essenziali. Tagli che appaiono ancora più stridenti a fronte dei fondi destinati ad alimentare la guerra in Ucraina. I soldi, in sostanza, possono essere prodotti illimitatamente, ma solo per gli obiettivi scelti dai grandi decisori.
In Italia alla deregulation emergenziale potrebbe sommarsi una deregulation territoriale, a seguito dell’introduzione dell’autonomia differenziata che consentirà alla Regioni più libertà nella gestione dei territori, anche sotto il profilo ambientale. Ma già ora sindaci, gli assessori, i governanti a ogni livello, decidono come se l’elezione conferisse loro totale carta bianca (e carta bianca diventano infatti i loro programmi elettorali): ai cittadini non è consentito chiedere e ottenere modifiche ai progetti e tantomeno dire “no”. L’opzione zero non è mai consentita. Niente è più stigmatizzato e demonizzato del “no”. La maggiore età dei cittadini è riconosciuta soltanto nel momento in cui depongono una scheda nelle urne; per il resto del tempo sono considerati bambini capricciosi o soggetti incapaci di intendere e di volere. Vengono di fatto interdetti ed esclusi dalla partecipazione politica. Chiaramente, non può esserci reale democrazia quando al popolo non è consentito orientare nessuna decisione, grande o piccola, e parteciparvi.

Di fronte a questa situazione, crediamo sia giunto il momento di rivendicare con la massima forza la legittimità del nostro no.
Noi siamo quelli del no.
Del no al genocidio in Palestina, che si consuma con la complicità del nostro governo e dell’Unione Europea. Del no all’invio di armi all’Ucraina, anticostituzionale. Del no alla partecipazione dell’Italia a tutte le guerre presenti e future.
Del no alla guerra tra poveri e tra oppressi, alla discriminazione etnica, sessuale, generazionale.
Del no alla finta transizione ecologica decisa al di sopra delle nostre teste.
Del no alla devastazione dei nostri territori con mille progetti di opere e infrastrutture inutili e nocive.
Il sistema vuole che i nostri territori siano Zone da Sacrificare, per noi sono Zone da Difendere.
Vogliamo provare a bloccare il flusso di risorse che deteriora i territori e le persone.
Vogliamo provare a creare un flusso di persone, che si uniscano e da gocce diventino fiume e facciano salire la marea che sommergerà il sistema attuale.
Vogliamo provarci, perché non abbiamo altra scelta.
Naviga nei capitoli:

Il Cortocircuito estrattivista: come l’estrazione di valore si articola sul territorio piemontese
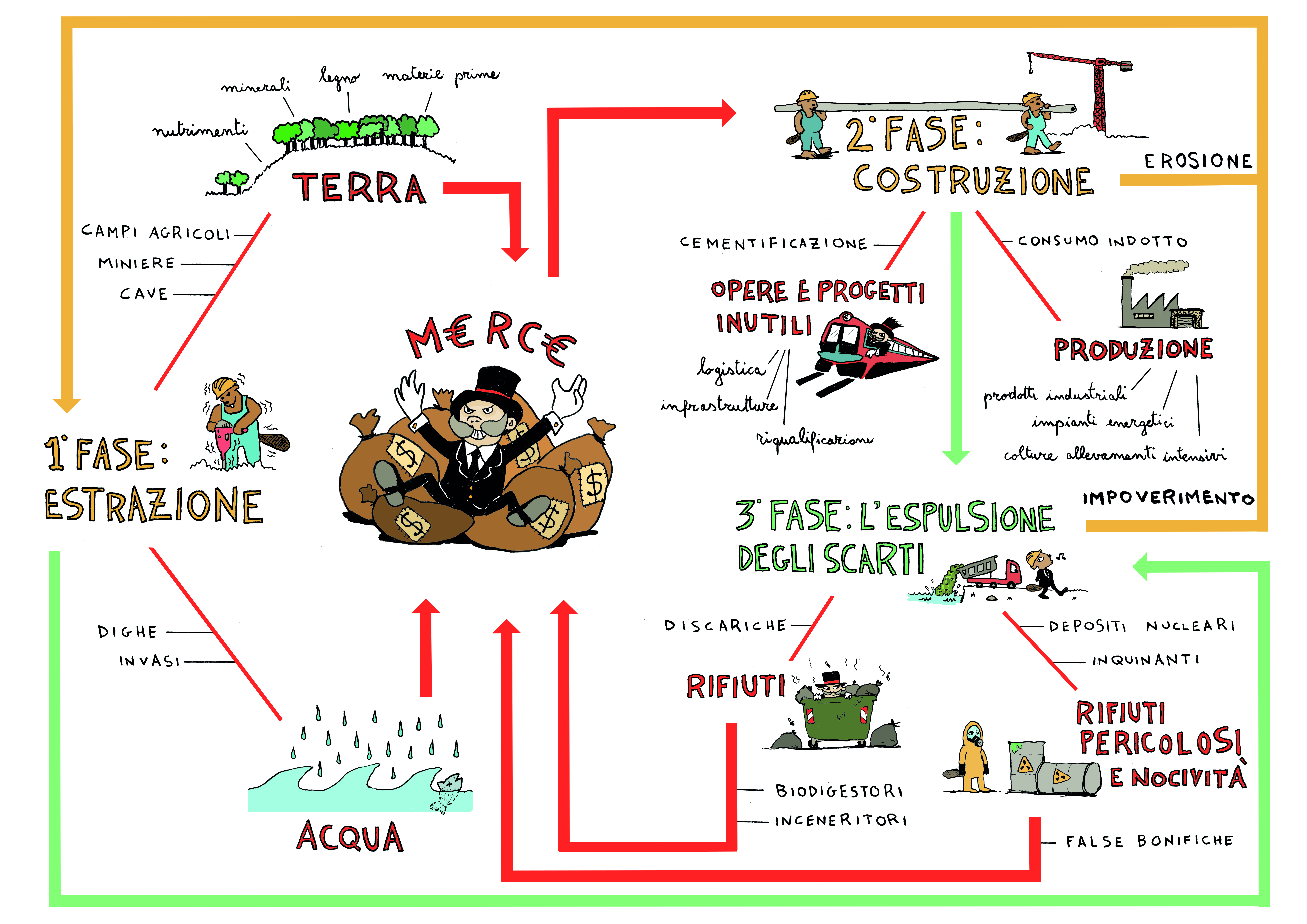
IL CORTOCIRCUITO ESTRATTIVISTA E LE SUE FASI
Con questo schema abbiamo tentato di descrivere i vari passaggi, in una relazione di concausa, che compongono il ciclo estrattivista che ridefiniamo “cortocircuito estrattivista”.
Vi rientrano tutte le opere e tutti gli impianti produttivi e di smaltimento che vengono imposti dall’alto e che non rispecchiano i reali bisogni di chi abita il territorio. Non si intende mettere a critica la costruzione di un’infrastruttura di per sé, ma piuttosto valutare la sua utilità, il suo impatto e le sue conseguenze ambientali, sociali ecc., nonché considerare il tema della decisionalità. Esistono infatti priorità e necessità per i territori (la loro messa in sicurezza, la cura, la manutenzione, la valorizzazione di ciò che c’è, ossia interventi utili a migliorare la vita di tutti e tutte) che dovrebbero essere determinate dalla popolazione coinvolta ma che vengono volutamente ignorate dai decisori.
Il ciclo estrattivista è un vortice in cui si susseguono diverse fasi che comportano la devastazione e l’alterazione irreparabile dei territori: ciò avviene in quanto l’intervento sul territorio ha come fine prelevare risorse, dunque valore, trasformarle in merce per poi venderle sul mercato. Al suo passaggio questo vortice lascia dietro di sé vuoti culturali, sociali, economici e ambientali.
I grandi progetti, linfa vitale per il sistema di produzione e consumo così come lo conosciamo, vengono imposti dall’alto come presupposto affinché questo sistema mortifero si riproduca. Questo sistema non è sostenibile né rinnovabile, anche quando viene supportato da una falsa retorica green. Questa è la rappresentazione plastica di un cortocircuito: il sistema capitalista nei vari passaggi accumula sì capitale, ma mina le basi stesse per la sua sopravvivenza appropriandosi delle risorse e impoverendo i territori.
Di seguito illustriamo le fasi del cortocircuito estrattivista, a partire dall’analisi su numerose specificità del territorio piemontese in termini di progetti, opere e possibili interventi futuri del capitale. Nei primi mesi del progetto Confluenza siamo infatti entrati in contatto e siamo venuti a conoscenza di molte realtà che si battono per la difesa dei loro territori e che lottano contro progetti e opere devastanti. Questa conoscenza ci ha permesso di elaborare questi primi dati e di formulare l’ipotesi del “cortocircuito estrattivista”.
Naviga tra le fasi:
PRIMA FASE : L’ESTRAZIONE
La prima fase è quella che riguarda l’estrazione di risorse materiali come l’acqua e il suolo, quest’ultimo inteso come terra, minerali e materie prime, ma anche come area boschiva o terreno fertile. Queste “risorse primarie” vengono ricavate attraverso processi estrattivi che implicano la costruzione di mega-invasi o dighe con cui trattenere l’acqua, lo scavo di miniere o cave per ricavare terre e minerali rari, ma anche la trasformazione del suolo in campi agricoli o in zone da cui prelevare legname.

L’acqua: bene primario conteso tra vita e mercato
Approcciarsi al tema dell’acqua nel mondo occidentale del XXI secolo crea a tratti un senso di disorientamento. Da un lato, il (buon)senso comune riconosce istintivamente l’essenzialità dell’acqua per la vita, dall’altro però la percezione è che sia data per scontata la sua illimitata disponibilità nel nostro quotidiano. Eppure, i rischi di una futura carenza di acqua si possono intuitivamente comprendere anche su un piano effettivo, se consideriamo che meno del 3% di tutta l’acqua presente sul nostro pianeta è acqua dolce, i cui due terzi si trovano nei ghiacciai. Quei ghiacciai che rappresentano l’immagine tangibile della precarietà che ci attende in futuro, dato che negli ultimi 100 anni i ghiacciai alpini si sono pressoché dimezzati e le previsioni scientifiche indicano la loro sparizione sotto i 3.500 mt di altezza nell’arco di 20 o 30 anni.
Come spesso accade però, in una società in cui i bisogni e il consumo delle risorse sono indotti da logiche di mercato, la speculazione senza freni indica l’acqua come risorsa strategica, come il futuro “oro blu”. L’acqua dovrebbe invece essere riconosciuta come bene essenziale universale, a cui tutti hanno accesso, e sulla base del quale non è possibile produrre profitto. Tesi, questa, sostenuta da anni dal Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua di cui il Comitato Acqua Bene Comune Torino fa parte. Il Consiglio comunale di Torino sta discutendo in questi giorni una delibera di iniziativa popolare presentata proprio dal comitato al fine di tutelare un bene tanto prezioso chiedendo al Comune di Torino, socio di maggioranza di Smat (gestore del servizio idrico integrato, S.p.A. a intero capitale pubblico, ma di diritto privato) di agire affinché l’azienda rafforzi il suo carattere pubblico, reinvesta tutti gli utili nella sostituzione della rete idrica, mantenga al suo interno la progettazione delle nuove opere, garantisca la protezione dei punti di captazione e infine applichi una tariffa equa. Occorre ricordare che, al momento attuale, la rete di distribuzione della Città Metropolitana registra perdite pari al 34%. Gli utili di Smat, grazie alla battaglia condotta in passato dal Comitato, oggi devono essere reinvestiti in azienda per l’80%, ma è evidente la persistente tendenza a sottovalutare il problema (vero e proprio dramma!) dello spreco idrico: Smat continua a investire pochissimo nella manutenzione della rete e preferisce (oltre a distribuire un lauto dividendo ai Comuni partecipanti alla S.p.A.) investire in opere che possano creare altra remunerazione ed esternalizzare parte del lavoro al fine di abbassare i costi (con conseguente espropriazione dei saperi interni).

Nonostante la vittoria del referendum del 2011 che, abrogando le norme che indirizzavano la gestione del servizio idrico verso la privatizzazione, ha sancito il principio che l’acqua non è una merce e che su di essa non si fanno profitti, nei nostri politici invece rimane più viva che mai la concezione che essa debba assumere status di merce: il servizio idrico non è considerato all’oggi un servizio essenziale per la popolazione, ma mezzo per recuperare denaro attraverso il profitto ottenuto. Con la conseguenza paradossale che, oltre al mancato reinvestimento di tutti gli utili da parte di SMAT al fine di ridurre gli sprechi dell’infrastruttura, secondo quanto stabilito da Arera2, il gestore può anche pretendere il rimborso per il mancato consumo, cioè il rimborso per i mancati utili pianificati dall’azienda, dai cittadini virtuosi che si impegnano a consumare meno acqua! Ma non ci possiamo più permettere, anche alla luce del cambiamento climatico in atto, di gestire l’acqua come una merce. Inoltre, il cambiamento climatico assume oggi un ruolo paradossale: se, da un lato, è evidente che non venga preso sul serio, dall’altro viene sbandierato per imporre opere devastanti erette a salvaguardia dell’insostenibile sistema economico contemporaneo, secondo il paradigma dell’estrazione di valore ad ogni costo, anche dall’acqua.
Ed ecco dunque spiegata la nuova tendenza “idrica” nel nostro Paese: la pianificazione di dighe e invasi montani. Indipendentemente dalla motivazione portata a supporto della necessità di queste opere (irrigazione per campi agricoli, produzione energetica, innevamento artificiale, creazione di valore aggiunto turistico o altro), il risultato è sempre lo stesso, ossia totale disinteresse per gli impatti ambientali, economici e sociali di questi progetti. In un’epoca in cui ormai si assiste all’inesorabile carenza di neve, è assurdo pensare di poter derivare acqua da torrenti o laghi alpini al fine di sovvenzionare un’attività destinata a morte certa, quella sciistica. Sarebbe senz’altro più sensato mirare al superamento della dicotomia tra necessità di tutelare l’ambiente e necessità di mantenere in piedi un’economia che generi reddito, al fine di concentrarsi sulla conservazione ambientale e su uno sviluppo sostenibile che renda attuabile una nuova economia montana in relazione alla crisi eco-climatica.
Un ulteriore argomento utilizzato per propagandare la necessità di queste opere riguarda i rischi relativi a mancate produzioni agricole e all’autosufficienza energetica. Se il record di scarsità di precipitazioni del 2022 ha contribuito a far nascere come funghi nuove ipotesi progettuali di grandi invasi e dighe, come sta avvenendo in val di Viù e in valle Soana, vi sono altresì progetti più datati a cui l’emergenza idrica degli ultimissimi anni sembra aver dato nuova linfa. È il caso ad esempio del tanto discusso invaso di Serra degli Ulivi, nel cuneese, che andrebbe a interessare un’area poco antropizzata tra i comuni di Pianfei, Chiusa di Pesio e Villanova Mondovì. Una proposta avanzata già nel 2008 dal consorzio irriguo Canale Brobbio-Pesio, che all’epoca in realtà non faceva leva sul cambiamento climatico, ma nasceva esplicitamente per rispondere al bisogno crescente di acqua da parte di un settore portante dell’economia cuneese, quello dell’allevamento e dell’agricoltura intensivi. Il progetto, del costo iniziale di 120 milioni di euro (ovviamente lievitato nel tempo), dopo alcune modifiche effettuate negli anni, a oggi nella sostanza prevederebbe lo sfruttamento delle acque dei due torrenti Pesio ed Ellero tramite una ventina di chilometri di condotte interrate, e la costruzione di una diga in cemento armato alta 60 metri e lunga 260 (mascherata di erba, operazione degna del più acrobatico dei greenwashing!) con la conseguente sommersione di 70 ettari di territorio sotto oltre 10 milioni di metri cubi di acqua.
Altro progetto faraonico “di vecchia data” è quello relativo alla diga sul torrente Sessera, affluente del Sesia in provincia di Biella: progetto avversato fin dal 2009 dal comitato Custodiamo la Val Sessera perché ritenuto inutile, costoso e pregno di conseguenze dannose per l’habitat circostante, nonché privo di logica su un piano di costi e benefici (a oggi il costo dell’intera opera è stimato intorno ai 500 milioni di euro con risultati irrigui scarsi se non irrilevanti). Per la realizzazione di questo megabacino artificiale il Consorzio per la Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese (la cui società partecipata “in house” STECI Srl ha tra l’altro curato altri progetti di invaso quali quello sopra citato della Serra degli Ulivi) non è mai riuscito a trovare i soldi: poiché sono trascorsi 10 anni dall’approvazione del progetto in sede di VIA, il provvedimento di autorizzazione dovrebbe essere necessariamente rinnovato. Le criticità sollevate dal comitato Custodiamo la Val Sessera sono cristalline. Innanzitutto, il consorzio ha in passato realizzato altre tre dighe nel biellese (Ostola, Ingagna e Ravasanella), caratterizzate da costi elevati, cresciuti esponenzialmente rispetto ai preventivi iniziali e con scarsi risultati irrigui. Vi è inoltre da sottolineare il compenso che i consorzi di bonifica ottengono per le opere proposte e realizzate (dal 13 al 16% del costo complessivo, meccanismo molto generoso che ha certamente favorito l’avanzamento di proposte costruttive). Opere che, diventando proprietà del Demanio, sono finanziate interamente dallo Stato. Dal punto di vista ambientale, poi, la diga (circa 100 metri l’altezza e 7,1 i Mmc) oltre agli impatti idromorfologici ed ecologici sul torrente Sessera a valle dell’invaso, comporterebbe la sommersione di circa 44 ettari di aree boscate nel SIC/ZPS Val Sessera (un Sito di Interesse Comunitario / Zone Speciali di Conservazione) solo per l’invaso; altri ettari di foreste andrebbero poi distrutti per i lavori a esso connesso. L’aspetto cantieristico inoltre impatterebbe fortemente sul territorio in quanto ovviamente non riguarderebbe solo la diga in sé ma anche la costruzione di strade di accesso e di una teleferica di cantiere, un tratto di tombinatura del torrente e decine di chilometri di condotta forzata che andrebbero ad alimentare altri due invasi e centrali elettriche. Una devastazione territoriale che metterebbe in pericolo l’habitat di specie animali e vegetali rare, e stravolgerebbe la vita e le attività degli abitanti a monte e a valle. In questo caso, la giustificazione addotta per legittimare il progetto è stata l’estrema necessità di acqua per la coltura del riso nella piana biellese e vercellese, nonostante questa sia una narrazione non veritiera, visti i diversi elementi che la smentiscono. Infatti, le risorse idriche a disposizione per questa coltura sono ad oggi sostanzialmente sufficienti.
Questa gestione delle risorse cavalca il falso e pericoloso bivio di un’anacronistica contrapposizione tra natura e fabbisogno umano, una idroesigenza senza limiti che non si pone il problema della salvaguardia della naturalità del reticolo fluviale e delle acque profonde quali elementi determinanti per la futura disponibilità della risorsa acqua.
Il suolo: una preda immobile. Perfetta per il cacciatore neoliberista del Terzo Millennio
Sovente il suolo è esso stesso, immediatamente, merce, sotto forma di minerali ma anche di materiali, come ghiaia e sabbia, utilizzati per opere che impermeabilizzeranno altro suolo, come edifici, strade, autostrade, TAV, dighe, invasi…

Un esempio è la cava di gesso nel Monferrato, un’opera dalle gravi conseguenze ambientali a causa delle emissioni inquinanti, della produzione dei rifiuti, della rumorosità che provocherebbe un cantiere di questo genere. Il progetto è voluto da Knauf, società tedesca che possiede ben 80 siti in 90 Paesi. Ma pensiamo anche alle cave di Valledora, un pezzetto di Piemonte a cavallo tra le province di Vercelli e Biella. Terra di frutteti fino a qualche decennio fa, sotto il suo suolo fertile conservava i giacimenti di ghiaia e sabbia purissime dell’antico letto del fiume Dora, poi spostatosi più a ovest. Le prime attività di estrazione di tali materiali furono limitate a qualche cava di piccole dimensioni, ma una quindicina di anni fa arrivarono da queste parti grandi aziende del Milanese, interessate a uno sfruttamento intensivo di quei depositi di materiali per l’edilizia e per grandi opere a due passi da lì, come il rifacimento dell’autostrada Torino-Milano, la costruzione della ferrovia ad alta velocità, ecc. I coltivatori dei comuni di Cavaglià e Alice Castello cedettero volentieri le loro terre, pagate anche quattro volte il prezzo di mercato da chi sapeva che con le quantità esorbitanti di materie estratte avrebbe guadagnato molto di più. Così Valledora diventò un paesaggio extraterrestre, con profondissime voragini larghe centinaia di metri ciascuna. Una volta esaurita l’estrazione, le immense buche scavate nella terra piemontese della Valledora diventarono discariche, pur con tutti i crismi di legge e approvate dalle amministrazioni, ma spesso con rifiuti urbani e speciali affiancati, e sovente viziate da gravi irregolarità nella realizzazione. Per esempio quella chiamata Alice 2, dove i teli che avrebbero dovuto garantire l’impermeabilizzazione del fondo furono posati male, provocando il percolamento dei liquami e l’inquinamento della falda. Sulla rimessa a valore delle cave trasformate in discariche torneremo più avanti nella parte dedicata ai rifiuti.
È merce anche ciò che sul suolo cresce: non solo i prodotti dell’agricoltura intensiva (che impatta sulla vitalità del suolo stesso e sulla qualità dell’acqua e dell’aria) e il legno da costruzione della silvicoltura industriale, ma anche, per quanto anacronistico, quello da ardere. Nella lingua del Terzo Millennio la legna è chiamata “biomassa legnosa” ed è classificata come “fonte energetica rinnovabile” da un’Unione Europea al servizio delle lobbies, benché per riprodurla occorrano parecchi decenni, per di più con tutte le incognite del cambiamento climatico. Di legno sono affamate le centrali a biomasse e i produttori di pellet, il cui business è in forte espansione per l’aumento del prezzo del gas, collegato alla guerra in Ucraina e ad altre questioni geopolitiche. Inchieste giornalistiche hanno scoperto connessioni tra gli abbattimenti di alberi e l’insaziabilità delle centrali a biomasse, anche con trasporti di migliaia di tonnellate di legno da nord a sud: un nuovo grande affare per le ecomafie. Anche per questo, probabilmente, si stanno abbattendo a raffica alberi ovunque, dai parchi naturali ai viali cittadini.
Una volta trasformate in merci, le “risorse” sono pronte per essere vendute ed utilizzate, innescando così la seconda fase del ciclo.
SECONDA FASE: LA COSTRUZIONE
Nella seconda fase le “risorse naturali primarie” vengono incanalate all’interno di due processi principali che stanno alla base del livello successivo di usurpazione dei territori: la costruzione di opere inutili e la produzione di merci superflue.
Le materie estratte nella prima fase costituiscono la base per la costruzione di opere e progetti che solitamente hanno come comune denominatore l’utilizzo del cemento. La cementificazione, processo che presuppone la presenza di spazi da conquistare, comporta un attacco alla fertilità dei suoli, la loro impermeabilizzazione e una conseguente diminuzione della biodiversità a scapito dei viventi umani e non umani.
Attraverso la cementificazione vengono realizzate opere che riguardano principalmente tre ambiti (ma siamo certi che lo schema si potrebbe ulteriormente articolare): le infrastrutture, la logistica e la riqualificazione urbana.
Le infrastrutture, settore chiave per l’utilizzo del cemento e di materie prime rielaborate
Vi rientrano le mega-opere che fungono da interconnessione tra diversi poli della produzione, come strade, ponti, ferrovie: dal TAV, al Ponte sullo Stretto, ma anche opere minori e più periferiche, non per questo non irreversibili o prive di impatto; ne sono un esempio, nei pressi di Torino, la strada che si vorrebbe realizzare sulla Collina Morenica di Reano o la tangenziale est di Chieri.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si articola in 6 misure di cui 4 prevedono investimenti rilevanti – 62 miliardi di euro – nei settori delle infrastrutture e della mobilità sostenibile.
Si scrive sostenibilità, si legge alta velocità.
La Valle di Susa ci insegna bene quanto il discorso della transizione ecologica sia utile per condire i progetti di devastazione ambientale, conferendogli una parvenza green. Una delle argomentazioni classiche dei sostenitori della linea Torino-Lione è stata quella del beneficio ecologico: spostando le merci trasportate dalla gomma al ferro, dal camion al treno, si riduce l’inquinamento. A una condizione: bucare la montagna. Una “piccola” clausola che non tiene conto di: emissioni di CO2 e inquinanti, accaparramento delle risorse idriche, produzione di scarti materiali e – ovviamente – salute pubblica. Dati alla mano, durante i dieci anni dall’inizio dello scavo del tunnel di base di 57,5 km si registrerà l’emissione di circa 10 milioni di tonnellate di CO2, secondo le previsioni di TELT (società italo-francese incaricata della costruzione dell’opera). Nel frattempo il TAV Torino-Lione ha già causato l’estinzione di una popolazione della specie protetta – dalle stesse leggi europee – del lepidottero Zerynthia polyxena, nonché l’inquinamento delle falde sotterranee, la loro alterazione e la scomparsa di numerose sorgenti. Inoltre, intere porzioni del territorio vengono sottratte alla popolazione e rese inaccessibili, come accade oggi ai terreni di Susa oggetto di esproprio, o alle zone interamente privatizzate o addirittura militarizzate, come i cantieri di San Didero, Chiomonte-Giaglione e Salbertrand. Danni che diventano profitti e che aprono la strada a infiltrazioni mafiose che riguardano anche un colosso delle infrastrutture stradali, ossia Sitaf. L’indagine Echidna ha infatti scoperchiato il vaso di pandora dei rapporti tra politica, criminalità organizzata e imprenditori in Piemonte nel segno del cemento.
Molte di queste dinamiche si sono verificate anche con il progetto decennale della Tangenziale Est, nei dintorni di Torino, tra Santena e Chieri, rimasto sinora in bilico per l’effettiva fattibilità sulla base del rapporto costi economici e danni ambientali. Nel 2022 il Consiglio regionale ha approvato due ordini del giorno per chiedere di riprendere in mano il progetto, e alcuni consiglieri regionali appena rieletti hanno dichiarato che il progetto s’ha da fare: è per questo che occorre continuare a parlarne. Il suolo è in questi casi oggetto di speculazione, conseguenza e obiettivo dei processi di cementificazione nel disinteresse più totale della salvaguardia del territorio. Perché preferire una strada già esistente a una nuova costruzione che permette di trarne profitto grazie a una narrazione che ne magnifica la (non veritiera) utilità?

Un caso simile è quello che coinvolge la collina morenica di Rivoli-Avigliana, oggetto di cementificazione e devastazione ambientale per fare spazio a una strada di evidente inutilità, all’interno di un bosco a prevalenza castagneto, in uno degli habitat europei più protetti e a rischio. Nello specifico, il Comune di Reano ha presentato un progetto per il Bando PNRR per la “Messa in sicurezza e consolidamento della carreggiata della strada vicinale dell’Avena e della strada comunale Reano-Rivoli” per un importo di € 520.000. Dalla descrizione sembrerebbe poco più che un intervento di miglioramento della viabilità, ma nel concreto il “consolidamento” prevede l’allargamento e la cementificazione delle due strade bianche – prive di asfalto, dunque permeabili – per la realizzazione di una circonvallazione. Nel 2021 è nato il Coordinamento per la salvaguardia e la valorizzazione della collina morenica Rivoli-Avigliana, che si batte affinché tal area sia riconosciuta come Zona di Salvaguardia, e opera per definire iniziative, azioni e buone pratiche utili a tutelare la collina, migliorarne l’assetto boschivo e idrogeologico, e promuoverne la conoscenza e la fruizione da parte dei cittadini che vivono nelle sue vicinanze.
Un altro esempio è quello del progetto di strada nel Vallone di Sea, nelle valli di Lanzo. Si vorrebbe realizzare un nuovo percorso volto al raggiungimento dell’alpeggio di proprietà del comune di Groscavallo, denominato Alpeggio “Gias Balma Massiet” e situato a circa 1500 metri s.l.m, eliminando l’attuale sentiero che potrebbe essere oggetto di interventi di manutenzione. Ciò in una zona a forte rischio idrogeologico. La strada servirebbe solo a raggiungere uno spazio montano semiabbandonato all’oggi. In provincia di Cuneo inoltre sono state costruite autostrade (Asti-Cuneo) ma anche piste da skiroll a Chiusa di Pesio (un’altra è in progetto a Entracque) che asfaltano strisce di prato larghe 4 metri.
E infine, per tornare in provincia di Torino, a Settimo Torinese, tra via Po e via Ariosto, si stende un grande prato, area di proprietà privata, edificabile e interessata da un Piano Edilizio Convenzionato (PEC), ma attualmente a uso agricolo. Un progetto vecchio di 20 anni prevede che per il prato passi una strada, una sorta di tangenziale interna che collegherebbe corso Piemonte alla strada statale e allo svincolo di Settimo centro/via Castiglione. Strada non più necessaria perché, a distanza di 20 anni dalla sua progettazione, i flussi veicolari sono cambiati e per accedere alla Statale per Chivasso da Settimo si può imboccare alla rotonda del cimitero la strada per Brandizzo arrivando allo svincolo di Cascina Isola/Mezzi Po.
La logistica, settore nevralgico nello spostamento delle merci, legata a doppio filo con l’industria dei trasporti
Gli enormi poli della logistica comportano l’accaparramento di vastissime distese di terra per costruirvi sopra magazzini dalle dimensioni equivalenti a interi villaggi. Ettari di terreno vengono così resi impermeabili, biologicamente morti, utilizzati come sale d’attesa delle merci che, in un secondo momento, spostate da treni o camion, percorreranno le arterie dell’interscambio che, spesso, si diramano al posto di terre fertili e ricche di biodiversità, con conseguente inquinamento.

Il settore logistico, impegnato nello spostare merce inutile e causa di sfruttamento sul lavoro, prende forma specialmente attraverso i magazzini (presenti a Torrazza Piemonte, a Novara, Alessandria) di Amazon, un colosso che con i suoi 7 centri si muove ancora alla conquista del Piemonte. Avanza dunque il land grabbing nostrano da parte della logistica, in particolare nell’area tra Novara, Pernate e Galliate, dove un mega polo chiamato senza pudore “Ecologistica” vorrebbe mangiarsi un milione di metri quadri, che si sommano a quelli già divorati da altri poli esistenti. Contrasta il progetto il Comitato per Pernate.
La riqualificazione urbana, processo che investe le nostre città e che trasforma l’assetto dell’ecosistema
Nel caso della città di Torino, cittadelle dello sport, supermercati, nuovi ospedali (per evitare di ristrutturare quelli già esistenti) e altre strutture vengono costruite negli ultimi angoli disponibili di verde urbano. Le aree verdi rappresentano l’ultima frontiera da colonizzare, innescando un processo di privatizzazione e rendendo inaccessibili e invivibili gli spazi urbani.
A Torino il Comune ha tentato di avviare la rottamazione degli alberi urbani, applicando al verde cittadino l’obsolescenza programmata dei prodotti industriali per far crescere all’infinito il loro consumo. L’idea è che i tecnici dichiarino il “fine ciclo vita” di interi viali e che le imprese li abbattano in un colpo solo, sostituendoli con alberi di specie più piccola e longevità più breve. L’esperimento si è fermato a metà, con la distruzione dell’alberata di corso Umbria, perché il Comitato Salviamo gli Alberi di corso Belgio si è opposto al progetto del Comune con un presidio h24 durato 4 mesi, iniziative pubbliche e interazioni con due docenti universitari di Sociologia (il prof. Vittorio Martone e il prof. Dario Padovan) e gli studenti, nonché con un ricorso al Tribunale ordinario. In primo grado l’ordinanza del Giudice ha riconosciuto la lesione del diritto alla salute che l’abbattimento dell’intero viale avrebbe arrecato, in termini di perdita di servizi ecosistemici, in particolare dell’ombreggiatura e del suo effetto sulla temperatura. Il Giudice ha condannato il Comune a pagare le spese legali, ma purtroppo ha soltanto dilazionato i tagli in 5 anni. Non soddisfatto il Comune di Torino ha impugnato il provvedimento, con l’ottuso obiettivo di realizzare il progetto originario, con tutta l’arroganza di un’amministrazione sorda alle rivendicazioni dei cittadini. Si dovrà quindi ancora lottare per spazzar via il concetto che un’alberata possa essere “sostituita” come un arredo urbano, mercificando l’ultimo dei beni pubblici, il verde cittadino. La rottamazione degli alberi va comunque di moda anche a Bussoleno, ove si vogliono abbattere i platani lungo la Dora e si è formato un Comitato a loro difesa, e a Cuneo, ove parecchi cedri dovrebbero lasciare il posto a parcheggi.
Quindi il suolo sta venendo mercificato anche in quanto area e cubatura. Pure quello delle aree verdi pubbliche: parchi e giardini, luoghi pluridimensionali, i cui assi si estendono nella memoria, negli affetti, nell’identità degli abitanti umani e non umani (e che per questi ultimi sono anche fonte di nutrimento e riparo) diventano in tal modo mero spazio geometrico, da svendere o da occupare con attività redditizie per soggetti privati. Così a Torino il progetto virtuoso di collocare la Biblioteca pubblica centrale nell’area ex-Westinghouse-Nebiolo in via Borsellino è stato accantonato in favore della realizzazione di un centro congressi e di un albergo e, a seguito di intese tra il sindaco Fassino e il fondatore di Esselunga Caprotti (oggetto di un processo per turbativa d’asta chiuso con la prescrizione), è dilagato sull’adiacente parco Artiglieri da Montagna, prevedendone la distruzione per insediarvi l’ennesimo supermercato della zona. Contro tale devastazione si batte il Comitato EsseNon, formato da studenti universitari e da abitanti della zona. La prima manifestazione nel gennaio 2022 è stata repressa con violenza dalla polizia. In seguito il Comitato ha presentato petizioni in Comune e in Circoscrizione e ha studiato il Piano Esecutivo Convenzionato depositando puntuali osservazioni. Né l’Amministrazione precedente né quella in carica, però, hanno mostrato di voler recedere dal progetto, trincerandosi dietro la solita barriera delle “compensazioni”, che riguardano soltanto le emissioni di CO2 e non tutti gli altri servizi ecosistemici del verde urbano. Nel caso dell’ex Westinghouse, il Comune ha pure generosamente posto a proprio carico la bonifica del sito.

Ma perché accollarsi costi di bonifica, quando si può usare suolo vergine? Di tale risparmio di fondi pubblici si vanta il Sindaco Lo Russo per giustificare la scelta di un settore del parco della Pellerina (il più grande di Torino) per costruirvi il nuovo ospedale Maria Vittoria, dimenticando i programmi elettorali del suo partito, nonché i piani della Città di arrestare il consumo di suolo. Al progetto si oppongono il Comitato Difesa del Parco della Pellerina, già mobilitatosi in passato contro altre speculazioni in loco, e il Comitato Salviamo la Pellerina, nato proprio per contrastare questa, l’ennesima. Quest’ultimo Comitato ha proposto di insediare l’ospedale nel sito abbandonato della famigerata Thyssen-Krupp, di fronte alla Pellerina, dopo la bonifica integrale a carico dei proprietari privati: il Consiglio comunale ha bocciato la delibera d’iniziativa popolare, approfittandone per deliberare invece una semplice tombatura del sito della Thyssen-Krupp, su cui installare un parco su soletta… a compensazione della cementificazione della Pellerina! Sullo stesso tema è stata respinta dalla Commissione esaminatrice anche una prima istanza di referendum propositivo comunale (forma di partecipazione prevista nello Statuto della Città di Torino ma mai praticata). Si attende l’esito di una seconda proposta di referendum, sull’inedificabilità di tutte le aree verdi urbane.
Gran parte di questi progetti germinano perché fertilizzati da fondi europei (del PNRR e altri) che, imponendo tempi stretti per le varie fasi, di fatto incoraggiano gli Enti locali a saltare non soltanto l’informazione e la partecipazione della popolazione, ma anche controlli, pareri e autorizzazioni preliminari degli Enti preposti. Così è avvenuto a Torino anche per trasformazioni che riguardano i parchi di maggior valore naturalistico: neanche questi sfuggono alla logica estrattivista, che non riconosce al verde pubblico nessuna utilità o valore se non genera profitto. Eppure questi parchi sono anche beni paesaggistici, per legge soggetti a tutela prima che a valorizzazione (che non sarebbe comunque da intendersi come sfruttamento economico, tantomeno da parte di soggetti privati).
Invece il parco del Meisino e il parco della Confluenza, delicati corridoi ecologici lungo le sponde fluviali, ricchi di avifauna selvatica e che includono aree protette (e aree contigue il cui uso è pure soggetto a restrizioni normative) stanno biecamente venendo caricati di funzioni del tutto estranee alla loro naturalità. Contro la realizzazione di una Cittadella dello Sport da 11,5 milioni di euro, con collocazione di piste da ciclocross e pumptrack in un parco che include una ZPS (Zona a Protezione Speciale) soggetta alla tutela della Rete Natura2000, ove abitano 205 specie di uccelli, lotta il Comitato Salviamo il Meisino. Il Comune dichiara che lì si farà anche educazione ambientale, ma intanto prevede che si insegni ai ragazzi a sparare con carabine laser in attività di biathlon. L’Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese ha lamentato a giugno 2024 di non essere stato preventivamente consultato né per questo progetto, né per la collocazione del Todays Festival al Parco della Confluenza, sulla sponda opposta del Po (l’evento dovrebbe tenersi dal 23 agosto al 2 settembre). È questa la più recente delle speculazioni torinesi sul verde pubblico, con l’apporto delle fondazioni bancarie, negli ultimi anni moltiplicatesi a un ritmo tale che per contrastarle è sorta ad aprile 2022 la rete di Comitati “Resistenza Verde”.
Un ultimo esempio che vogliamo menzionare è quello relativo al Pratone Parella, un terreno vergine di circa 11 mila m2 di proprietà del Comune di Torino, sito nell’area ovest della città, che il comitato Salviamo i prati è riuscito a difendere dalla cementificazione. Tale prato era infatti destinato a scomparire in base a due progetti (prima un palazzetto dello sport, poi due grandi strutture per le Universiadi) per i quali il Comune era pronto a cederlo per fare cassa. Parte di un’area più ampia, classificata come Zona Urbana di Trasformazione, che negli ultimi anni era già stata stravolta dalla costruzione di un supermercato con relativo parcheggio e strade di collegamento, il pratone nel Piano Regolatore era considerato un vuoto da riempire, etichettato da una certa stampa come un luogo di degrado e pericoloso (grazie all’incuria e alla mancata manutenzione del Comune nel tempo): un “vuoto urbano” da sfruttare insomma! Un’occasione che veniva a crearsi tramite un meccanismo che pare ormai ben rodato: si trascura un’area verde pubblica, la cittadinanza inizia a non percepirne più la naturalità e l’utilità sociale bensì il degrado, così diventa facile fare accettare un qualsivoglia progetto di “riqualificazione”.
Il comitato Salviamo i prati è invece riuscito nel tempo a invertire questa percezione distorta tramite iniziative atte a fare conoscere la reale bellezza naturale del pratone, organizzandone la cura attraverso la salvaguardia degli alberi esistenti, la messa a dimora di piante utili agli insetti impollinatori, richiedendo sporadici sfalci e pianificando periodiche giornate di raccolta dei rifiuti. Parallelamente, raccogliendo più di 2.000 firme, ha presentato una Proposta di Deliberazione che nel settembre 2022 ha avuto esito positivo, con la quale si è destinata l’area esclusivamente a verde di prossimità, affermandone in tal modo l’inedificabilità assoluta. Recentemente il comitato ha firmato un patto di collaborazione con il Comune, al fine di portare a compimento negli anni a venire quel processo di vera riqualificazione iniziato da qualche tempo, conservando una vasta area prativa, mettendo a dimora alberi autoctoni, posando un arredo urbano essenziale (panchine, cestini, punto acqua), a cui dovrà essere garantita una minima ma costante manutenzione.
Oltre che per la costruzione di opere e progetti di questo tipo, le risorse naturali primarie (acqua e suolo), vengono utilizzate per la produzione di ulteriori merci compresi i prodotti agroindustriali.
Lo sviluppo di colture e allevamenti intensivi, idrovori e deterioranti le qualità del suolo, finalizzati a produrre cibo a basso costo in grandi quantità
Un esempio sul territorio piemontese di progetti di questo tipo è l’allevamento intensivo di maiali di Poirino. Questo prevede l’ampliamento di un vecchio casale per costruire un impianto industriale con grande impatto sul territorio. La struttura complessiva ospiterebbe circa 10.000 suini e consumerebbe 30 milioni di litri di acqua potabile l’anno. L’impatto ambientale di tale investimento riguarda innanzitutto il liquame prodotto, che verrebbe smaltito nei campi dopo essere stato stoccato in vasche circolari in cemento a cielo aperto: due vasche di 8 metri di altezza e 21 di diametro ciascuna. L’ex comitato locale si sta riorganizzando per riprendere la battaglia assieme alle associazioni ambientaliste di Langhe e Roero.

La costruzione di impianti energetici
Centrali idroelettriche che necessitano dell’acqua trattenuta dalle dighe e dai canali, vasti campi di pannelli fotovoltaici e di pale eoliche, a loro volta costruite grazie all’uso di materiali come il cobalto, il rame e le terre rare provenienti da miniere e cave, si nutrono del materiale che viene estratto, il tutto occupando potenziali terreni fertili.
Nei primi mesi del 2024 il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) ha ricevuto 168 richieste di Valutazione d’impatto ambientale (VIA) relative a progetti di parchi eolici e impianti fotovoltaici a terra, per un totale di 8.378 MW, pari al 56% dei 15 GW fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) come obiettivo da raggiungere entro il 2025.
Poco più del 50% dei progetti proposti sono parchi solari a terra, il resto è rappresentato da 513 pale eoliche. Se dovessimo concentrare il nostro sguardo esclusivamente sulla produzione di energia “pulita”, il giudizio sarebbe positivo. Ma non sempre esiste un’equivalenza tra rinnovabile e sostenibile. Le domande presentate per i parchi solari potrebbero consumare tra i 5000 e gli 8000 ettari di terreno, a seconda della disposizione più o meno fitta dei pannelli3.
Le 513 pale eoliche, dal canto loro, sottrarranno altri 200-300 ettari di suolo, senza contare che ognuno dei plinti di fondazione – che ha un diametro di base di 27 metri e un volume di circa 1000 metri cubi (!) – sarà interamente riempito di calcestruzzo armato ed interrato alla profondità di circa 3 metri.
A terra, ma dove?
Nel maggio del 2022, a tre mesi dall’inizio del conflitto russo-ucraino, il governo Draghi emanò un decreto energia (D.L. 50/22) in cui venivano definite le zone idonee alla produzione di energia fotovoltaica:
“le aree dei siti oggetto di bonifica” (c. 8, pt. b);
“le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale” (c. 8, pt. c);
“i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali” (c. 8, pt. c-bis);
“le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere” (c. 8, pt. c-ter, n. 1);
“le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, […], nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento” (c. 8, pt. c-ter, n. 2);
“le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri” (c. 8, pt. c-ter, n. 3);
“le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 [Codice dei beni culturali], né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici” (c. 8, pt. c-quater)”.

Il criterio è geometrico, con aree-cintura attorno o lungo impianti o infrastrutture, le cosiddette solar belt. Le aree agricole rientrano pienamente tra quelle utilizzabili. Il decreto rallenta – ma non si ferma – solo davanti al vincolo paesaggistico. In realtà, non esiste alcuna ragione scientifica o agronomica per dichiarare idonee a esser coperte di pannelli solari le aree agricole attorno ai siti produttivi o lungo le autostrade. Il fatto che si trovino a meno di 500 metri da un capannone non significa che siano aree degradate, di minore qualità o meno importanti di altre. Esiste in tutta Italia una mappa della capacità d’uso dei suoli agricoli che, con criteri scientifici, individua le aree “meno buone” per la produzione agricola (ma sempre importanti dal punto di vista ambientale e della biodiversità), che però nello specifico non è stata usata.
Il dubbio legittimo, sollevato da esperti del settore e dalle associazioni a difesa del bene comune, è che l’ideazione di solar belt sia una sorta di scappatoia per non mettere in campo criteri tecnici e scientifici più rigorosi, così da obbligare gli sviluppatori a usare prima quelle parti di territorio già reso impermeabile da manufatti umani. L’applicazione di tali criteri si scontrerebbe con i maggiori costi dell’operazione perché, dal punto di vista di uno sviluppatore, i greenfield hanno un potenziale enorme: lo sviluppatore non deve preoccuparsi della pulizia, della bonifica di siti contaminati o derivanti da altro uso e non è nemmeno limitato da restrizioni (es: edifici storici sotto vincolo e tutela). Per gli sviluppatori che creano comunità pianificate, questo tipo di terreno è una “tabula rasa” che consente di realizzare piani da zero e di costruire l’intero sviluppo tutto in una volta.
A quanto detto finora dobbiamo aggiungere gli spazi per le infrastrutture accessorie. Il decreto di governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) già stabiliva che “le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti” (art. 30, c. 1) sono parte integrante degli impianti energetici; il decreto energia sottolinea e conferma questa linea, aumentando il consumo di suolo per ogni progetto.
Da non sottovalutare è il ridimensionamento dell’iter per ottenere le VIA (Valutazione d’Impatto Ambientale): l’art. 7 comma 1 stabilisce, infatti, che in caso di VIA nazionale le decisioni saranno prese direttamente dal Consiglio dei Ministri e queste “sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di Via”. Così facendo il parere del C.d.M (organismo politico) si sostituisce in toto a quello di un tecnico – che oltre ad essere un esperto dovrebbe essere anche una figura senza conflitti d’interesse sulla questione in oggetto – e diventa vincolante. Inoltre, nel decreto energia è previsto anche il ridimensionamento di quegli ultimi vincoli che ancora si frapponevano al massiccio consumo di suolo, quali quelli culturali, paesaggistici e monumentali. Con l’art. 10 (c.1, pt.a) il decreto elimina il diritto di voto all’unico rappresentante del ministero della Cultura rimasto in seno alla commissione VIA per i progetti energetici, così come era invece previsto dal comma 2-bis dell’art. 8 del T.U. ambientale (D. Lgs. n. 152/2006). Come se non bastasse, le amministrazioni locali potranno presentare opposizione entro un termine che viene ulteriormente compresso entro i 60 giorni. Ora, sappiamo bene che le nostre amministrazioni locali sono sotto stress per la carenza cronica di personale, la frammentazione amministrativa, i deficit di competenze e di mezzi e sono soffocate da un’enorme mole di lavoro. In soli 60 giorni non è possibile chiedere integrazioni o incontri con le parti, specie se lo stesso personale deve occuparsi della estrema varietà di questioni relative alla vita quotidiana dei Comuni. Se proviamo ad informarci presso le aziende produttrici, nei loro discorsi gli svantaggi di un parco fotovoltaico sono ridotti ai minimi termini, mentre vengono enfatizzati l’impatto positivo sui terreni e il vantaggio economico che un agricoltore avrebbe per sé.
I problemi, invece, non sono per nulla trascurabili.
Nel rapporto “Potential impacts of solar, geothermal and ocean energy on habitats and species protected under the habitats and birds directives”, l’impatto maggiore sulle specie e sugli habitat da parte dei parchi solari su larga scala è dovuto soprattutto all’occupazione diretta del terreno da parte dell’impianto stesso. Questo impatto può variare sensibilmente in base all’efficienza nell’uso del suolo (compresa la distanza e la disposizione dei pannelli), alla grandezza dell’impianto e alla progettazione delle infrastrutture. I siti solari occupano aree relativamente grandi e l’impatto sulla biodiversità – sempre presente – dipenderà soprattutto dal tipo di terreno occupato. Un report della Commissione europea (Lammerant et al., 2020) riporta dati preoccupanti sull’impatto negativo che hanno queste tecnologie sulle comunità ornitologiche stanziali e di passaggio, oltre alla radicale sottrazione di habitat riproduttivo e foraggero per la maggior parte degli animali di ambiente prativo e campestre, a vantaggio di specie più generaliste e opportuniste, con ricadute catastrofiche sulla biodiversità vegetale e microbica del suolo (Bai et al., 2022; Pileri, 2022). Anche i pipistrelli correrebbero serie minacce a seguito della frammentazione e conseguente sparizione del loro habitat (Tinsley et al., 2023).
Secondo Quentin Lambert – ricercatore presso l’Institut méditerranéen de biodiversité et d’ecologie marine et continentale (IMBE), la qualità dei suoli generalmente peggiora nei parchi solari rispetto ad aree con coperture semi-naturali. Infatti, diminuisce la stabilità degli aggregati del suolo che si auto-frantumano e perdono potere colloidale.
Inoltre, la preventiva rimozione della vegetazione nelle zone limitrofe all’impianto innesca un iniziale declino di materia organica che va a ridurre di molto la densità microbiologica dei suoli stessi che, come sappiamo, è l’inizio della sofferenza eco-biologica di questo delicatissimo e non rinnovabile ecosistema. La copertura data dai pannelli riduce la temperatura a terra tra i due e i cinque gradi di giorno, prevalentemente nei mesi più caldi; mentre di notte quella stessa copertura inibisce il rinfrescamento del terreno: quindi sotto i pannelli il gradiente di escursione termica nei suoli peggiora rispetto alle condizioni ottimali di un suolo (Tanner et al., 2020). Lo stesso dicasi per l’umidità, dal momento che i pannelli intercettano la pioggia e variano la distribuzione uniforme dell’acqua piovana sul terreno. Di conseguenza possono ridurre l’acqua trattenuta in terra specialmente nelle regioni più calde e assolate, con la formazione di croste.

Secondo un altro studio, condotto in Italia, a Montalto di Castro (VT), in soli sette anni si può osservare una modifica nella fertilità dei suoli, dovuta alla riduzione della capacità di trattenere l’umidità (Moscatelli et al. 2022). Sotto i pannelli la componente organica collassa e ciò produce una caduta dell’attività microbica ed enzimatica nei suoli, con una riduzione dello stoccaggio di carbonio e con la conseguente diminuzione della biodiversità. Quindi in soli sette anni la copertura dei pannelli fotovoltaici modifica sostanzialmente le proprietà biofisiche e chimiche del suolo e – anche se questa occupazione del suolo è da considerarsi temporanea – secondo gli studi sarà necessario prevedere un investimento economico sostanzioso per poter destinare nuovamente quei terreni alla produzione agricola.
A questi impatti possiamo aggiungerne altri più difficili da calcolare e spesso trascurati, come il fatto che i parchi fotovoltaici siano tutti recintati, creando così una barriera non indifferente che impatta sulla biodiversità riducendo per la fauna selvatica le zone di ricerca di cibo e le zone di riposo. È necessario, inoltre, tener conto della fase di costruzione dell’impianto, con l’apertura di strade o corridoi per raggiungere il cantiere dove saranno attivi i macchinari per la realizzazione di fondamenta, cabine e edifici di servizio, lo scavo di condotti dove far passare i cavi e la deviazione di fossati. Tutte azioni che stravolgono la morfologia del campo. Altrettanto trascurato, ma presente, è il rischio di contaminazione, dal momento che i pannelli vengono puliti con detergenti chimici che si disperdono al suolo. Per non parlare degli impatti sul paesaggio – perché spesso questi parchi fotovoltaici sono progettati in territori a vocazione turistica ed enogastronomica – e/o degli impatti sul regime delle acque.
Questi studi dovrebbero spingerci a usare maggiormente il principio di precauzione riguardo al solare a terra. Il suolo agricolo è una risorsa scarsa e preziosa, e dedicarlo in modo spregiudicato al fotovoltaico è un rischio.
Lo stesso discorso possiamo farlo per quelle aree che potrebbero essere considerate “sacrificabili”. Ci sono colture che richiedono quantità enormi di acqua; in futuro, con il cambiamento climatico dovremo probabilmente sostituirle con altre che necessitano di minore irrigazione. Potremo recuperare così terreni che oggi non sono utilizzati perché considerati poco adatti. Anche l’agrivoltaico – su cui il Governo in carica sta puntando molto (Bonus Agrivoltaico 2024) – pur essendo considerato meno impattante rispetto ai parchi fotovoltaici (solamente perché non sacrifica la produzione agricola ma l’associa a quella energetica) porta con sé svariate criticità. Innanzitutto, anche per l’agrivoltaico sarà necessario procedere con la posa dell’impianto e questo avviene secondo le stesse modalità del fotovoltaico puro che abbiamo elencato sopra. In più, prevedendo altezze che permettano l’uso di macchine agricole tra i “filari di pannelli”, le fondamenta dovranno avere maggiore consistenza e di conseguenza avremo un aumento nell’uso di cemento per la base delle strutture. Infine, con l’introduzione del Decreto Agricoltura che vieta l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici, l’agrivoltaico diventa – oltre all’aumento della estensione degli impianti già esistenti e fatti salvi quelli finanziati nel quadro dell’attuazione del PNRR – un obiettivo primario e una copertura per operazioni speculative che di sostenibile non hanno nulla.
L’alternativa non manca. L’I.S.P.R.A (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) stima che siano disponibili tra i 70 e i 90mila ettari di superfici impermeabili non vincolate, a cui possiamo aggiungere parcheggi, piazzali (circa 65mila ettari) ed infrastrutture (500mila ettari).
Molte di queste aree appartengono al Demanio o ad altri enti pubblici e questo garantirebbe che la produzione energetica non finisca esclusivamente nelle mani dei privati, riproducendo lo schema che già viviamo in relazione alle fonti fossili.
Ciò che fondamentalmente manca è un piano nazionale con criteri omogenei per tutte le Regioni, che stabilisca dove e come installare gli impianti, in modo particolare quelli di grandi dimensioni. Purtroppo, anche il decreto aree idonee (in vigore dal 4 luglio 2024) non risolve le criticità del decreto energia di Draghi, ma se possibile peggiora la situazione. Infatti, la definizione delle aree idonee rimane un compito delegato alle Regioni (art. 1, c. 2, pt. a), cosa che, con l’autonomia differenziata in via di definizione, non è un dato positivo per il consumo di suolo ad uso energetico. Inoltre, il rimando all’art. 22 del decreto legislativo 199/2021 “Procedure autorizzative specifiche per le aree idonee” assesta il colpo di grazia alla VIA. In sintesi, nel momento in cui le Regioni (autorità competenti) secondo criteri non univoci avranno deliberato quali aree siano idonee, il loro parere su tutti i procedimenti di autorizzazione per agri-fotovoltaico ed eolico, incluso il procedimento per richiedere la VIA, ove prevista, sarà obbligatorio ma non vincolante, mentre i termini per le procedure di autorizzazione in aree idonee vengono ridotti di un terzo. Sotto questo ombrello giuridico sono comprese tutte quelle opere “accessorie” di scavo che sono ritenute necessarie per collegare il parco solare alle cabine e/o quelle per raggiungere le cabine di raccolta nazionale. Nell’art. 7 (c.2, pt.b) viene suggerito alle Regioni di considerare idonee le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica. Stiamo parlando di aree che al momento hanno il suolo libero da manufatti e spesso sono in buona salute, ma hanno la sfortuna di essere inserite in un piano regolatore che ne prevede la trasformazione ad altro uso. Per concludere, le solar belt già previste dai precedenti decreti andranno a “fondersi” con le aree idonee approvate da ogni singola Regione come suggerito nel decreto del Governo (art.7 c.2 pt.c). Una quantità considerevole di aree agricole – tutte quelle nel raggio di 500 metri da stabilimenti produttivi e affini – saranno automaticamente idonee anche se non rispettano le linee guida che le Regioni, autorità competenti, si saranno nel frattempo date.
Manca un osservatorio pubblico che monitori i suoli e i paesaggi su cui incidono i campi fotovoltaici e/o agrivoltaici. Al momento, il monitoraggio è richiesto allo sviluppatore, cosicché le due figure del controllato e del controllore coincidono. Manca l’istituzione di momenti ad hoc per il coinvolgimento dei cittadini e di piani di formazione per i tecnici pubblici, e non è previsto un organismo indipendente che consigli e aiuti il governo a decidere, lasciando il campo libero al gioco di lobby di coloro che fanno business con il fotovoltaico. In questo senso un’agenzia pubblica, mediatrice tra uso del suolo e uso per la produzione energetica, sarebbe stata più che auspicabile per evitare l’enorme speculazione sui terreni agricoli che in questi ultimi mesi è diventata evidente. A farne le spese saranno coloro in posizione di debolezza come i piccoli proprietari, i piccoli Comuni, gli agricoltori in maggior sofferenza; mentre finiranno per essere agevolati coloro che hanno tra le mani grandi estensioni di terreno e vedono nella conversione energetica un facile guadagno.
I casi di Pedrosa, Alfiano Natta e Pozzolo Formigaro (AL)
Anche il Piemonte, e soprattutto la provincia di Alessandria, non è rimasto immune alla corsa all’energia solare.
Ad esempio, a Predosa in una porzione agreste della Pianura padana, vitale e produttiva sia in termini biologici sia di resa agricola, si vuole realizzare un progetto agrivoltaico su un’area complessiva di 33 ettari, tra lavori accessori e spazio per i pannelli. Un intervento che rischia di compromettere un intero habitat. Stiamo parlando di un territorio di quasi novanta chilometri quadrati dove grazie al basso grado di urbanizzazione e alla conversione al biologico di un numero sempre crescente di terreni, si è riusciti a conservare e ad ampliare una biodiversità non comune in ambito agricolo, in particolare per quanto riguarda gli uccelli, principali indicatori della salute di un ecosistema. Nei settori sud-orientali dell’altopiano, infatti, vengono tenuti a dimora gli ultimi estesi appezzamenti di prato stabile, inframmezzati da lembi di pascolo e filari alberati di cerro. Un paesaggio ormai raro ai margini di una pianura coltivata in modo intensivo. Il prato e il pascolo hanno consentito a milioni di insetti e a una nutrita comunità di altre forme viventi di proliferare anno dopo anno. Il risultato è stato sorprendente: da vent’anni a questa parte circa 140 specie di uccelli hanno visitato regolarmente questi campi per la nidificazione, la sosta migratoria o per trascorrervi l’inverno. Le ragioni di questo successo, oltre che nella qualità ambientale, risiedono anche nel clima, caratterizzato da estati calde e asciutte, da una costante insolazione e dalla ricca presenza di ortotteri (grilli e cavallette), la principale fonte di alimentazione della ghiandaia marina e di molte altre specie.
Ma su questo piccolo paradiso incombe ora l’ombra della SKI 26 Srl che intende infatti realizzare nel territorio del Comune di Predosa (AL) un progetto di agrivoltaico che dovrebbe sorgere proprio nel cuore della colonia delle ghiandaie marine, compromettendola irrimediabilmente.

Ad Alfiano Natta, invece, a Febbraio 2023 la IBE Srl di Alessandria (di cui si conosce ben poco, se non che è collegata a Enel) ha presentato un progetto per la costruzione di un impianto agrivoltaico grande come 6 campi da calcio. In breve: 40mila metri quadrati di specchi che deturperanno il paesaggio e l’ambiente di una delle più placide e affascinanti vallate monferrine. Il progetto prevede tre aree a pannelli fotovoltaici, posizionati dai 2,50 metri d’altezza in su a Sanico. Si tratta di tre aree di dimensioni diverse, con un unico proprietario che concede in totale 20 ettari di terreno non coltivato in fruizione per 30 anni, riscuotendo un canone annuo di circa 80.000 euro. Questo impianto andrà ad alimentare due centrali di stoccaggio non situate in Alfiano, ma a Penango e a Cagliano. Il Comune si è detto contrario fin da subito e ha fatto istanza per ottenere la VIA dalla Provincia, essendo questa una zona cuscinetto tra il territorio alfianese e la zona dichiarata patrimonio UNESCO, dedicata al turismo e alle coltivazioni agricole. Anche l’ARPA si è detta contraria al progetto per motivi paesaggistici, perché queste sono zone produttive e zone boschive. Ad agosto 2023, però, la Provincia ha annunciato che l’istanza sarebbe stata archiviata, poiché non ci sono obblighi di dichiarazione di impatto ambientale su progetti di impianti sotto i 10 Megawatt. Inoltre, Alfiano è inserito nel SIN di Casale (Sito Interesse Nazionale per l’amianto), soggetto a bonifica e senza vincoli ambientali e, sempre secondo il decreto legislativo 199/2021, è “agevolata la partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell’amianto, con agevolazioni premiali e modalità di partecipazione quanto più possibile ampie”. Il sindaco di Alfiano ha più volte sottolineato come la situazione locale sia differente da quella di Casale Monferrato, trattandosi di abitazioni già bonificate dall’amianto grazie alle agevolazioni e agli aiuti economici passati. Se le istituzioni locali non sono state a guardare, anche i cittadini di quei territori non sono rimasti inerti e hanno costituito il comitato “Tuteliamo il Monferrato” che nei mesi successivi grazie all’opera di opposizione al progetto ha aumentato il numero dei propri sostenitori ed ha acquisito uno status di ente guida e di riferimento a livello provinciale nella denuncia di pericolosità ambientale e paesaggistica dell’agrivoltaico. La quantità di informazioni tecniche, politiche, archeologiche, artistiche e storiche del territorio – acquisite per essere utilizzate come motivazioni di contrasto dei progetti – sono state messe a disposizione di altri gruppi spontanei di cittadini che intendono far conoscere la loro opposizione ai progetti.

Nel mese di ottobre 2023 il Comune ha predisposto, con l’aiuto di specialisti del Politecnico di Torino, due istanze che sono state inviate al TAR. Una di queste richiedeva un provvedimento cautelare (cioè la sospensione del progetto) e l’altra di ricevere dal TAR un giudizio di merito sulla creazione di questo parco agrivoltaico. Nonostante le istanze fossero state redatte molto puntualmente, il TAR ha rigettato quella del provvedimento cautelare. Resta in piedi la richiesta di un giudizio di merito ufficiale, che però avrà tempi a discrezione del TAR e il cui esito ha poche probabilità di essere sfavorevole al progetto, poiché l’orientamento governativo è quello di acquisire l’autonomia energetica. Ciò nonostante, Comune e Comitato intendono avvalersi di tutti gli strumenti consentiti dalla legge per ostacolare il progetto o per contenere i danni.
Un’altra maxi centrale fotovoltaica è in progetto a Pozzolo Formigaro. Il ministero dell’Ambiente ha dato il via alla fase della consultazione per un impianto da ben 68 ettari, l’equivalente di un centinaio di campi da calcio. La struttura dovrebbe sorgere nel punto in cui la bretella autostradale di Novi si immette nella A7.
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza pari a 46,85 MW, nonché di tutte le opere e infrastrutture accessorie (tra cui una nuova stazione elettrica che verrà collegata alla rete esistente). L’area dell’impianto si divide in due lotti: il primo, di 41 ettari, sarà situato in località Cascine Zinzini, mentre il secondo, di 27 ettari, è in progetto nei pressi della cascina Cipollona.
Il progetto è stato proposto dalla Renantis Italia con sede a Milano. L’impianto produrrà 74,8 milioni di kW all’anno di energia elettrica, equivalente al fabbisogno energetico di circa 25 mila famiglie e con una mancata emissione di CO2 pari a 32.566 tonnellate annue. Nei trent’anni di esercizio dell’impianto, quindi, grazie ai pannelli solari sarà evitata l’immissione in atmosfera di quasi un milione di tonnellate di anidride carbonica.
I 68 ettari della centrale saranno ricoperti da 75mila moduli fotovoltaici montati su oltre 1.600 “inseguitori solari” alti 5 metri e larghi 28, che ruoteranno e si inclineranno per raccogliere la massima quantità possibile di energia. Lungo i confini dell’impianto sarà piantumato un noccioleto.
Questo della Renantis è l’ennesimo grande progetto nel territorio della Fraschetta. Gli impianti fotovoltaici “a terra” nella zona del novese oggi sono 20, per una superficie complessiva di 127 ettari e una potenza generata di quasi 40 megawatt. Meno numerosi, ma molto più estesi, gli impianti in progetto o in costruzione. Parliamo di altri 16 campi fotovoltaici per una superficie totale di 370 ettari. Per avere un’idea dell’estensione, l’area urbana della città di Novi Ligure è poco più di 400 ettari.

Un altro esempio è il parco eolico che si vorrebbe far sorgere sul Monte Cerchio, al confine tra Piemonte e Liguria, che coinvolgerebbe diversi Comuni della zona. Si tratta del territorio dell’Alta Langa e della Val Bormida, già martoriato in passato dalla presenza di poli industriali e continuamente minacciato da ulteriori progetti come il Deposito Unico Nucleare, e dei territori di Uzzone, di parte del Monferrato e del Savonese. Zone preziose e sacrificate, ricche di boschi, pascoli e produzioni locali.
Il progetto prevede sette pale eoliche, alte oltre 200 metri (più di tre volte l’altezza della torre di Pisa), per una potenza di 43,4 MW, soprannominata “la fattoria del vento”. L’azienda promotrice del progetto è la Windtek di Torino, accusata di scarsa trasparenza per la mancata pubblicazione di elementi utili alla valutazione del progetto sin dalla sua presentazione. Il parco eolico vale 42 milioni, ma è già chiaro che ne serviranno molti di più. Secondo le associazioni, più di 28, che si sono riunite per contrastare l’opera, mancano i presupposti per la sua economicità, non è chiara la produzione di energia e quanto frutterebbe. Inoltre si tratta di un’opera devastante per il territorio e di una presa in giro per i Comuni coinvolti: infatti le compensazioni previste frutterebbero meno di un milione di euro da dividere tra Cairo, Cengio e Saliceto, senza contare l’enorme danno ambientale. Le associazioni che si sono mosse sono Italbio, Rinascita della Val Bormida, Progetto Vita e Ambiente, La Porta sulle Langhe, La Prima Langa- Osservatorio per il Paesaggio delle Valli Alta Bormida e Uzzone, La Via Aleramica, Lipu, Parco Culturale Alta Langa, Valle Bormida Pulita, WWF Italia, Italia Nostra, ARI, Pro Natura, Comune Roero, Forum Salviamo il Paesaggio, Associazione culturale Il Paese, Associazione Ambiente 21. Le associazioni si sono avvalse anche di supporto legale e l’avvocata che sta seguendo il progetto, Nadia Brignone, sottolinea importanti criticità relative all’azienda Windtrek, nata nel settembre 2023, diecimila euro di capitale sociale, inattiva e incapace di dare valutazioni serie sull’impatto ambientale. Secondo la Windtrek gli animali presenti (pipistrelli e uccelli) non patirebbero in quanto “specie pigre” (!), mentre la flora non presenterebbe varietà protette.
Gli impatti ambientali, sull’avifauna, le conseguenze idrogeologiche sono invece innumerevoli, anche solo a partire dalla cantierizzazione e dalle opere accessorie per la realizzazione del progetto. Si parla infatti di 17.500 viaggi di bilici e Tir soltanto per trasportare pale e materiale da cantiere. La zona collinare è calanchiva, ossia costituita da terreni molto fragili, e vi dovrebbe essere costruita una nuova strada di 3 km per trasportare il materiale da cantiere. Qui verrebbero abbattuti quattromila alberi per la costruzione della strada e per la realizzazione delle piazzole per l’impianto, e i danni alla vegetazione (rovere, castagni, frassino) sarebbero incommensurabili, per di più su terreni a rischio frana. I proprietari dei terreni coinvolti da espropri sarebbero 100 per una durata di 30 mesi di cantiere: sbancamento di suolo, incremento del traffico pesante, consumo di suolo per le opere accessorie. Una follia che non ha alcun motivo di essere realizzata. Risulta ancor più paradossale se si pensa al fatto che la zona non è ventosa quanto vorrebbe far credere la ditta promotrice.. Forse l’unica spiegazione di tanto interesse è che il progetto è finanziato dal PNRR? Al momento un primo provvedimento concreto per opporsi è stato portato avanti con la firma del Presidente della Provincia di Cuneo insieme ai Sindaci dei Comuni coinvolti per una segnalazione al Tribunale di Savona e alla Procura che ha sancito il no del consiglio provinciale all’opera. Si è ora in attesa della Valutazione Impatti Ambientali dal Ministero dell’Ambiente.
C’è poi una questione sociale che corre sottotraccia ed è potenzialmente esplosiva.
Lo psicologo sociale Adriano Zamperini in Violenza invisibile – Anatomia dei disastri ambientali (Einaudi, 2023) ha spiegato che “violare l’integrità sé-ambiente vuol dire aggredire l’unità fondativa di qualsiasi singola esistenza” perché “non c’è alcun dubbio: individuo e ambiente non sono isolabili”. Stravolgere il paesaggio, sottrarre le terre invocando l’interesse pubblico – che però favorisce i privati – finisce per strappare i cittadini dal loro ambiente di riferimento e per intaccare la loro fiducia nelle istituzioni. Generare spaesamento, esclusione e iniquità porta a conseguenze complesse sui territori.
Inoltre, se saremo più carenti di cibo – data la conversione dei campi da agricoli ad energetici – lo Stato sarà in grado di controllare le speculazioni nelle filiere alimentari? Senza contare che la carenza di cibo qui da noi significherà la spasmodica ricerca di terre coltivabili altrove con l’innesco di ulteriori problemi e potenziali guerre tra poveri.
Sappiamo bene che la transizione energetica è necessaria, sappiamo come debba essere più equa e sostenibile, ma la domanda regina che spesso ci dimentichiamo di fare rimane sempre una sola: a che cosa serve tutta questa energia? Qual è il nostro reale fabbisogno di energia ora e, in previsione, fra 50 anni? I nostri territori diventeranno incubatori d’energia per consumi ancora più smodati o cominceremo a prendere in considerazione l’opzione di una decrescita di produzione e consumo generale? Perché la stessa enfasi e accelerazione non vengono poste sul risparmio energetico o sulla riduzione del consumo di carne da allevamento intensivo il cui saldo, tra energia e risorse usate rispetto alla resa, è negativo? Oppure sul razionalizzare e incrementare i trasporti pubblici per ridurre gli spostamenti urbani ed extraurbani inutili? Anche in questi casi è necessario un cambio di paradigma a monte che non sia dettato dalla crescita economica e dal PIL, ma da altri criteri che tengano conto dell’ecosistema di cui siamo parte. I governi dicono di voler sostituire, in ritardo e male, un’energia “sporca” con un’energia più “pulita”. Nella realtà, le nuove energie stanno semplicemente affiancandosi alle vecchie (fossili): basti pensare al ruolo del Piano Mattei, del GNL (Gas Naturale Liquefatto) americano e del corridoi mediterranei per il gas. In altre parole, occorre mettere a critica anche le ragioni che spingono a produrre e consumare questa energia, anche ammettendo nella migliore delle ipotesi di risolvere tutte le criticità che abbiamo esposto sopra. Altrimenti avremo solamente messo una toppa su una camera d’aria ormai inutilizzabile che porta il nome di sistema economico capitalista, che con le copiose verniciature green sta cercando (per ora con successo) di superare l’ennesima crisi strutturale.
Progetti di questo tipo impongono un serio ragionamento e aggiornamento delle categorie dell’ambientalismo classico. Puntare sulle energie rinnovabili produce lo stesso livello di devastazione delle energie fossili se si vuole mantenere il medesimo standard di produzione e di consumo. Se vogliamo fare la differenza occorre mettere in crisi prioritariamente il sistema di produzione e di consumo, mettere in discussione gli usi per i quali l’energia viene prodotta, effettuare un reale bilancio delle esigenze energetiche, degli utilizzi e di chi ne beneficia.
Infine, è chiaro come in generale tutte le risorse estratte stiano alla base della produzione industriale, la quale produce inevitabilmente scarti.
TERZA FASE: L’ESPULSIONE DEGLI SCARTI
La terza fase riguarda quindi gli scarti che derivano dalla produzione di merci, dalla costruzione di opere e dai progetti inutili. Gli scarti stessi paradossalmente danno nuova linfa al processo di estrazione del valore e presuppongono nuove tappe dell’aggressione territoriale in atto.
Gli scarti prodotti possono essere divisi in due principali categorie: i rifiuti non pericolosi da un lato e i rifiuti pericolosi e le nocività dall’altro.
I rifiuti, ovvero la componente residuale delle fasi precedenti
Il sistema capitalista ha la capacità di cogliere la produzione dei rifiuti come un’ulteriore occasione per innescare nuovi cicli di accumulazione di valore, impoverendo i territori. Questo passaggio è realizzato mediante progetti come biodigestori, inceneritori o discariche. Benché sia necessario mettere in campo delle modalità di riciclo e smaltimento dei rifiuti, molto spesso questi impianti rispondono prioritariamente a logiche di profitto, causando impatti negativi sul territorio a livello di inquinamento e danni alla salute.
Quindi il suolo piemontese, oltre a venire schiacciato e perduto a ritmo incessante sotto edifici e stabilimenti, non di rado abbandonati dopo un breve periodo di utilizzo, con le relative contaminazioni, viene consumato anche da discariche e da grandi impianti di discutibile recupero energetico dei rifiuti. Rifiuti che, nonostante tutte le leggi e i buoni propositi, non ci si sogna di diminuire, riprogettando i prodotti ed eliminando quelli inutili. In particolare ex-cave o ex-miniere diventano spesso discariche, da riempire con rifiuti urbani o speciali, anche pericolosi come l’amianto. Non di rado le discariche vengono realizzate male e originano scoli di sostanze nocive, su cui talora intervengono malamente altri soggetti privati. Devastazione chiama devastazione, insomma, e ogni territorio scelto come zona di sacrificio non smette di esserlo fino al suo completo degrado.
I rifiuti pericolosi e le nocività, ovvero componenti che fuoriescono a ogni fase del ciclo estrattivista e che non possono essere messe a valore di per sé
La particolarità di questi elementi è che potrebbero, di per sé, mettere a rischio la sussistenza del ciclo stesso. Sul territorio piemontese vi sono due esempi lampanti: la necessità di individuare un sito per il Deposito Unico di Scorie Nucleari e la recente scoperta della presenza di PFAS nelle acque. Nonostante questi elementi non possano essere reinseriti direttamente all’interno del ciclo, grazie alla creatività del sistema capitalista i “danni collaterali” diventano essi stessi occasioni di profitto.
I processi di produzione e consumo, che siano di singole persone o di grandi industrie, producono inevitabilmente dei residui.
Nel decreto legislativo 152 del 2006 rifiuto è “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione od obbligo di disfarsi”, e si distingue a seconda dell’origine (rifiuti urbani o speciali) e della pericolosità (rifiuti pericolosi o non pericolosi). Su queste premesse si articola un complesso sistema di classificazione, gestione e pianificazione del rifiuto, che avrebbe l’obiettivo generale di tutelare l’ambiente (il D.Lgs. n. 152/2006 è infatti il cosiddetto Testo Unico ambientale o Codice dell’Ambiente, che comprende anche le norme sulla gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati). Quanto segue però non è una storia di pratiche e tecniche per la tutela ambientale, ma una storia di ricerca del profitto raccontata nei termini ideologici di un’infinita messa a valore dell’esistente, grazie a una altrettanto infinita capacità di manipolare la natura. La narrazione di base è che, anche se oggi produciamo scarti e contaminazioni, prima o poi sarà possibile riassorbirli in nuovi e innovativi cicli produttivi, e se questi cicli produrranno altri scarti, si metteranno a valore pure quelli, ricavandone energie e materie prime per altri processi, e così via, fino al raggiungimento di un regime a zero rifiuti e continui guadagni. Si può constatare però come la retorica si scontri con la concretezza di mezzi e spazi che infiniti non sono, e come questa supposta razionalizzazione a trazione tutta economica del ciclo dei rifiuti porti a esiti che di razionale hanno ben poco.
Luglio 2023, siamo a Govone, in provincia di Cuneo: un enologo in cerca di casa viene informato dall’agenzia immobiliare del progetto di un biodigestore, cioè un impianto che recupera materia dai rifiuti organici (ammendante a uso agricolo) e, come residuo del processo, produce biometano. L’enologo rende nota la vicenda su Facebook, e presto si solleva un caso: la grande maggioranza dei cittadini di Govone era all’oscuro del progetto che il sindaco era riuscito a tenere lontano dal dibattito pubblico per ben due anni. A presentare il progetto è stata Govone Biometano Srl, società controllata dal gruppo SNAM, con l’obiettivo di smaltire il sottoprodotto di cicli industriali della Ferrero di Alba, promotrice di tutta l’iniziativa. Dopo un dibattimento, questa volta pubblico, e le dimissioni del sindaco (Elio Sorba), si forma un comitato spontaneo, che dopo un percorso assembleare decide di fare ricorso al TAR e organizza una raccolta fondi a questo scopo. Il ricorso si basa su vizi formali che riguardano l’autorizzazione concessa al biodigestore: un’autorizzazione unica non può essere rilasciata, il Commissario di Govone non ha mai approvato la bozza di convenzione accessiva al permesso di costruire, le misure di compensazione territoriale e ambientale non sono specificamente identificate, l’impianto non è stato sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica. Quelli che vengono identificati come rifiuti organici sono in realtà sottoprodotti, tuttavia solo in presenza di effettivo recupero di materiale (il digestato, qualcosa cioè di impiegabile in un nuovo ciclo produttivo) si può parlare di economia circolare (e quindi propriamente di un biodigestore). Tra l’altro non sarebbe chiaro fino a quando tali scarti organici sarebbero forniti, e si teme che invece di trattare gli scarti della Ferrero l’impianto finisca per utilizzare soltanto i liquami degli allevamenti intensivi. Vale la pena riportare un passaggio in proposito dalle osservazioni che accompagnano il ricorso, non fosse che per rendere l’idea del lavoro attento che sta alla base del ricorso stesso:
“La descrizione delle biomasse in entrata all’impianto su citate evidenzia prodotti di cui il produttore detentore deve disfarsi in quanto scarti di produzione o residui di produzione non idonei ad altro utilizzo produttivo alimentare se non lo smaltimento. Nel caso in oggetto non vi è certezza dell’utilizzo in un successivo processo di produzione o di utilizzazione, anzi le biomasse verranno mescolate con reflui zootecnici di allevamenti intensivi suini o bovini come in un qualunque biodigestore anaerobico per rifiuti organici o agricoli. Nella documentazione fornita non vi è evidenza di contratti o accordi con i produttori delle biomasse per la fornitura di “sottoprodotti” come previsto dall’art. 5 c. 4 del DM 264 del 13/10/2016 così come definiti dall’art. 184bis e nemmeno sono state allegate le schede tecniche previste dall’art.5 c.5 del DM 264 del 13/10/2016. Nella documentazione fornita non risulta l’iscrizione del proponente alla Piattaforma di scambio e la cessione dei sottoprodotti presso la Camera di Commercio territorialmente competente come previsto dall’art. 10 del DM 264 del 13/10/2016. La mancanza di questi impegni contrattuali, in caso di variazione dei fornitori e dei materiali da trattare, presupporrebbe la modifica del mix di alimentazione ad impianto ormai costruito perdendo così la sua principale peculiarità impiantistica e autorizzativa.”

Insomma, più che di economia circolare sembra si stia provando, in tutta fretta e in modo approssimativo, a mettere la polvere sotto il tappeto. La ragione di un No al biodigestore, più semplicemente, nasce dalla considerazione che a oggi gli scarti Ferrero vengono gestiti come compostaggio, per cui non ci sarebbe bisogno della costruzione di un biodigestore, che causerebbe emissione di CO2 e consumo di suolo. Nasce quindi il sospetto che il principale obiettivo del progetto risieda nella possibilità di monetizzare i rifiuti più di quanto si stia facendo ora, specie grazie all’opportunità di sfruttare dei fondi PNRR per il progetto. Proprio il PNRR, sempre accompagnato dalla retorica di uno stato d’urgenza permanente, è agitato dalla Ferrero come uno spauracchio: se il biodigestore non partisse ci sarebbe una richiesta di risarcimento da parte dell’UE. Il Comitato però presenta il ricorso. Il 21 marzo si è svolta in Camera di Consiglio presso la Sezione II del TAR del Piemonte la discussione del ricorso presentato contro la determinazione del Dirigente del Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo (del 21 dicembre 2023), che autorizzava la costruzione del biodigestore: i giudici si sono pronunciati accogliendo l’istanza cautelare e hanno sospeso l’efficacia del provvedimento del Dirigente, fissando per la trattazione di merito del ricorso una nuova udienza pubblica il 29 ottobre 2024.
La strada del ricorso è quella che ha seguito anche il Comitato No Biodigestore di Borgo San Dalmazzo, per un progetto proposto da ACSR da realizzare lungo il fiume Stura, area di grande qualità naturalistica. Secondo le osservazioni presentate dal Comitato lo studio di fattibilità non offrirebbe dati che rassicurano sulle ricadute negative per l’ambiente e di conseguenza anche per chi vive nelle sue prossimità, con relativi impatti economici (costi sanitari e valore degli immobili). Non sarebbero poi menzionati interventi di ripristino della struttura di compostaggio già presente (l’impianto a biometano ne costituirebbe una nuova sezione) né interventi di compensazione ambientale. Viene anche fatto notare come le dimensioni previste per l’impianto siano di circa quattro volte superiori a quelle sufficienti a trattare la quantità di rifiuto organico dell’area territoriale, mentre non risultino accordi già sottoscritti per lo smaltimento di rifiuti extra-territoriali. Tanti dubbi al momento inevasi, mentre la questione è arrivata in Parlamento, con il Ministero dell’Ambiente che appoggia l’opera, e la mette in capo alla Regione. Il 20 giugno 2023 l’amministrazione comunale di Borgo San Dalmazzo ha presentato nell’ambito della Conferenza dei Servizi altre osservazioni tecniche e richieste di integrazione: una Valutazione di Impatto sulla Salute e una Valutazione di Impatto Ambientale, integrazioni sulla compatibilità urbanistica, sulla tipologia di rifiuti, sul traffico in dettaglio, sugli effetti di dispersione nell’atmosfera, sui criteri territoriali del progetto. Insomma, un altro progetto che sembra pensato in fretta e furia per non perdere il treno del PNRR. Il comitato, intervistato da Cuneodice.it alla presentazione delle proprie osservazioni, dichiara: “È vero che esistono scadenze per spendere i fondi PNRR, ma fare procedure veloci, al limite dell’improvvisazione, prive di certa e rigorosa documentazione, rischiano pure di vedere poi realizzate opere che possono essere non solo inutili, ma anche deficitarie a livello economico durante il loro esercizio e dunque pesantemente impattanti per le tariffe delle quali le famiglie dovranno farsi carico”.
L’asimmetria di potere tra colossi come Ferrero, SMAT e ACSR (ma pure di Regione e Provincia) rispetto a piccoli Comuni e comitati emerge anche nel caso del progetto di inceneritore nell’area della ex Zincocalcare tra Cavaglià e Santhià (nel biellese). Qui il colosso è A2A, la società energetica che ha promesso 200 euro all’anno per vent’anni come compensazione alle famiglie residenti nei due Comuni in cambio dell’acquiescenza alla costruzione di un nuovo inceneritore per la produzione di energia elettrica e termica. Il Comune di Santhià si dichiara contrario, sottolineando come il territorio si sia già sacrificato ospitando cave, discariche e impianti di riciclo, e non sarebbe in grado di reggere anche una ciminiera di 80 metri. Molto netta poi la posizione del Movimento Valledora, che esprime le proprie motivazioni in modo chiaro con una comunicazione sulla propria pagina web (https://www.movimentovalledora.org/): l’inceneritore “brucerà rifiuti speciali e fanghi di depurazione 24 h al giorno, per 364 giorni all’anno e spargerà fumi, polvere sottili e CO2 nel cielo circostante al suo camino di 95 metri. Delle 300.000 tonnellate di rifiuti provenienti da ogni dove, non certamente dal Biellese, il 23% saranno ceneri e scorie e necessiteranno di discariche per accoglierle. Brucerà metano, consumerà acqua e consumerà tanta energia elettrica per funzionare, il 75% di quella prodotta. Le polveri sottili gettate in aria e che respireremo per circa 20 anni, conterranno ossidi di azoto e particolato fine e finissimo che sarà in grado di essere respirato”. Anche Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta notavano come un impianto di quelle dimensioni sia pensato per quantità di rifiuti molto superiori alla produzione biellese. Come per il caso del biodigestore di Borgo San Dalmazzo quindi, questo potrebbe considerarsi come un caso di violazione del principio di prossimità territoriale presente nel già citato D.Lgs. n. 152/2006, per il quale lo smaltimento dei rifiuti dovrebbe essere fatto “in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi”. Principio che a ben vedere è messo costantemente in questione. Nello stesso comune di Torino, dove la filiera dello smaltimento è gestita da IREN, sono regolarmente importati rifiuti da altre Regioni. Il 9 luglio 2024, con la Determinazione n. 1046, la provincia di Biella si è espressa bocciando il progetto di A2A: una vittoria delle molte attività organizzate da comitati e associazioni locali per opporsi al progetto e alzare il livello di attenzione e consapevolezza di chi abita quel territorio. Si teme però un possibile ricorso al TAR di A2A.
Dal riciclo e dallo smaltimento passiamo allo stoccaggio di rifiuti pericolosi, con il caso di un progetto di deposito a Clavesana, che dovrebbe ospitare (a massima capacità) 200 mila tonnellate di rifiuti l’anno, promosso da Cementi Srl che ha chiesto l’autorizzazione a costruire. Si tratterebbe di un capannone alto 11 metri per 2000 metri quadrati di estensione più due tettoie aperte sui lati (nel complesso altri 1500 metri quadrati). I rifiuti definiti pericolosi comprendono, chiaramente, sostanze tossiche, e il deposito di Clavesana non farebbe eccezione, andando a ospitare, tra altri, mercurio, cadmio, amianto. Il Comitato Clavesana Dice No contesta i rischi per la salute e di incidenti (relativamente frequenti in impianti di questo tipo). Contesta anche la scelta del sito, ricco di sorgenti sotterranee e attraversato da un acquedotto che fornisce acqua potabile a 200 mila persone. Si aggiunga che in prossimità si trovano quattro centri abitati (Cascina San Giovanni, frazione Pra, frazione Tetti di Clavesana, frazione Naviante di Farigliano) e, secondo l’ISPRA, sarebbero presenti delle formazioni geologiche di rilevanza nazionale. I residenti sono preoccupati per le ricadute negative che l’impianto avrebbe su agricoltura, allevamenti e turismo. Dopo una movimentata battaglia di circa due anni, siamo allo scontro tra il Comune di Clavesana, che inizialmente aveva venduto a Cementi Srl l’area ed era favorevole al progetto, e l’azienda. Ora la decisione è in mano alla Provincia.
Il sistema lascia vere e proprie cicatrici sui territori contaminati, anche nei pochi casi in cui si tentano delle bonifiche. La storia della nostra regione ci insegna che, nonostante le bonifiche, spesso inefficaci e utili al guadagno più che alla cura del territorio, intere aree rimangono comunque impregnate dalle relazioni tossiche avute con industrie e i loro inquinanti. Ne sono un esempio la discarica di Alice Castello e quella dell’ex area Acna di Cengio, di cui si parlerà più avanti. Molto spesso vengono scelti proprio quei territori che hanno già alle loro spalle una storia di devastazione per ospitare nuovi progetti, come nel caso della discarica di amianto di Salussola il cui progetto è stato bloccato al TAR lo scorso giugno.
Attraverso lo sfruttamento intensivo dell’ambiente avviene un cambiamento permanente e inevitabilmente si producono sostanze inquinanti impossibili da rendere innocue.
Scavi, prodotti chimici, utilizzo di pesticidi contaminano l’aria, l’acqua e il suolo, impedendo il ripristino delle condizioni iniziali, ma soprattutto mettono ad alto rischio la salute delle persone e del territorio. Le nocività testimoniano come le industrie, nonostante innovazione e aggiornamenti in ottica green, si scontrano con l’impossibilità di non essere impattanti sull’ecosistema. Indipendentemente dal grado di prevenzione adottato, prodotti sempre più complessi, catene della produzione sempre più lunghe generano conseguenze “invisibili” ma gravemente impattanti: pensiamo alle emissioni di CO2, alle radiazioni dei depositi nucleari, ai PFAS.
Sul territorio della Regione Piemonte sono presenti circa 1800 siti potenzialmente contaminati, e solo il 17% di questi è stato bonificato in maniera apparentemente definitiva, secondo l’Anagrafe regionale dei Siti Contaminati (ASCO). Sempre secondo l’ASCO sono 5 in Piemonte i Siti contaminati di Interesse Nazionale (SIC): l’area ex Ecolibarna di Serravalle Scrivia, l’ex miniera di amianto di Balangero e Corio, l’ex stabilimento Eternit di Casale Monferrato, l’ex Enichem di Pieve Vergonte e l’ex ACNA (Azienda Coloranti Nazionali e Affini) di Cengio. Luoghi ancora oggi da bonificare completamente e che continuano a danneggiare il territorio in modo permanente.
Le vecchie aree industriali del nord Italia danno prova della scia che lascia un sistema di produzione mortifero, si pensi ai vari casi piemontesi, come l’Acna di Cengio ad esempio, che ha condannato una buona porzione della Valle Bormida per più di 70 anni a danni permanenti e causato morti legate alle sostanze inquinanti prodotte dalla fabbrica. A qualche chilometro di distanza, tra l’Alessandrino e l’Astigiano, lo stabilimento Eternit ha provocato 392 morti a Casale Monferrato e nelle zone limitrofe a causa dell’amianto. Per 79 anni infatti, la zona ha ospitato lo stabilimento per la lavorazione del cemento-amianto più grande in Italia.
A Torino la ThyssenKrupp, adiacente al Parco della Pellerina, continua a inquinare le falde acquifere attraverso il rilascio di cromo esavalente. Lo stabilimento, dopo aver provocato la morte di 7 operai per le scarse condizioni di sicurezza, a distanza di anni dalla sua dismissione persiste nel provocare danni permanenti sulla salute umana e non.
Queste sono solo alcune delle storie indelebili che hanno influenzato e influenzeranno per sempre il Piemonte. Storie dettate dal profondo legame che questi territori hanno avuto con le industrie, soprattutto negli anni ‘70, che hanno sottoposto migliaia di persone a un ricatto tra salute e lavoro, seguendo la logica della produzione, costi quel costi. Anche quando la posta in palio è la vita di lavoratori e cittadini. Si tratta, tuttavia, di storie che ancora oggi continuano a ripetersi in tutta la regione e non solo, diventando presente e destino di molte altre aree minacciate da ulteriori stabilimenti industriali.
Lo stabilimento della Solvay a Spinetta Marengo, ancora oggi in funzione, è responsabile dell’inquinamento da PFAS di un’intera area dell’Alessandrino. Queste sostanze sono anche chiamate inquinanti eterni, dato che rimangono nell’ambiente e negli organismi contaminati per lunghissimo tempo, causando diverse patologie. A Spinetta e nelle zone limitrofe si registra un incremento del 75% rispetto ai dati regionali per quanto riguarda i mesoteliomi pleurici e +76% per tumore al rene.
Ma i PFAS non sono solo un problema alessandrino: la loro presenza è accertata in quasi tutta la Regione. In particolare, Greenpeace ha recentemente reso noti gli alti tassi di contaminazione da PFAS nelle acque delle province di Torino, Ivrea e Novara, più di 70 Comuni in totale. Alte concentrazioni sono state registrate in alcuni Comuni della Val di Susa, come Bardonecchia e Giaglione. Questi Comuni, non a caso, sono quelli adiacenti a una delle opere ecocide più inutili e ingenti di tutta Italia: il TAV Torino-Lione. I PFAS sarebbero solo uno dei tanti effetti collaterali che condannerebbero una delle Valli che è già oggi tra le più inquinate d’Italia. La grande opera, attraverso la perforazione della montagna, in cui è accertata la presenza di rocce contenenti uranio, ha diffuso e diffonderebbe ampie quantità di amianto e di altre sostanze inquinanti.
Sempre in Val di Susa, verso la fine di giugno era diventato di dominio pubblico che Acsel S.p.a., l’azienda valsusina per lo smaltimento dei rifiuti, aveva avviato le procedure di Valutazione d’Impatto Ambientale per riaprire a Mattie l’ex discarica di Camposordo e smaltirvi in dieci anni oltre 100 mila metri cubi di amianto provenienti da “bonifiche edili”. La discarica, che ha visto il suo fine vita a partire dal 2016, aveva iniziato un iter di rigenerazione attraverso un progetto di educazione ambientale e di svolgimento di attività ludiche, che ha visto, tra le altre cose, la piantumazione di più di 500 piante di lavanda, rosmarino e salvia, e la trasformazione degli uffici in una sala riunioni aperta alla cittadinanza. Una discarica di cui però preoccupa ancora la grande quantità di percolato che produce. Lo spettro della possibilità della sua riapertura per ospitare ulteriori tonnellate di uno dei rifiuti più pericolosi e mortiferi, in una valle spesso attraversata da correnti e venti forti, ha subito messo la popolazione in allarme. Infatti, a seguito di una mobilitazione di centinaia di persone tramite raccolta firme e assemblee, durante una riunione con i sindaci e Acsel, convocata dall’Unione Montana Bassa Val di Susa, il progetto è stato ritirato. Occorre dunque aprire il tema delle bonifiche che, spesso e volentieri, arrivano in ritardo, non sono adeguate o rimangono incompiute. Inoltre, sono i Comuni a dover sborsare i soldi per effettuarle, mentre le aziende inquinanti non vengono quasi mai coinvolte nelle attività di bonifica.
A proposito di ritardi, nonostante il referendum del 1987 abbia sancito il NO alla produzione di energia nucleare in Italia, nel 2024 il governo deve ancora individuare un sito per il Deposito Unico Nucleare, disattendendo ai criteri minimi che dovrebbero guidare la scelta del luogo idoneo. Parliamo in questo caso di rifiuti speciali pericolosi che hanno tempi di smaltimento molto lunghi e che per ora sono stoccati in modo non definitivo in alcuni siti del Paese. Il Piemonte ospita 5.923 metri cubi di rifiuti radioattivi (ovvero il 72,5% del totale stoccato in Italia) in 6 siti: il deposito di Bosco Marengo, negli impianti EUREX, Avogadro e LivaNova di Saluggia, nel deposito della Campoverde S.r.l. presso Tortona e infine a Trino, dove sorgeva la centrale Enrico Fermi. Dalla chiusura della centrale di Trino e del centro ricerche della vicina Saluggia a oggi sono stati diversi gli episodi di perdita di liquido radioattivo registrati. In una zona prossima a diversi corsi d’acqua affluenti al Po, il rischio di contaminazione per l’intera Pianura Padana è alto, ma da parte delle istituzioni non è mai trasparito un reale interesse alla messa in sicurezza del territorio.
Negli ultimi mesi è venuto alla luce il nuovo elenco di possibili siti individuati dalla società di Stato SOGIN S.p.A. dove collocare il Deposito unico nucleare definitivo. Alcune delle località papabili rientravano proprio in zone che potremmo definire di sacrificio, dove sorgono vecchi depositi, centrali dismesse o industrie smantellate. Tra le aree individuate sono presenti diversi siti nella provincia di Alessandria, nello specifico a Bosco Marengo, Novi Ligure, Oviglio, Quargneto, Castelnuovo Bormida, Sezzadio e Fubine Monferrato e Alessandria stessa. La CNAI (Carta Nazionale delle Aree Idonee) elaborata dalla SOGIN individua come idonea un’area di un territorio molto circoscritto nella zona più occidentale della provincia di Alessandria, nel cuore della Valle Bormida, già investita dalla presenza centenaria dell’inquinamento dell’ACNA, della Solvay e della discarica di Novi Ligure. Un’altra zona prescelta sarebbe quella dell’Alessandrino in cui esistono una serie di falde acquifere che non compaiono in alcun modo nelle carte di progetto, a riprova del fatto che chi conduce queste selezioni poco ha studiato del territorio che intende stravolgere. Anche il Vercellese è stato messo a repentaglio attraverso l’auto-candidatura (sistema introdotto recentemente dalla SOGIN per sbolognare le scorie a un volontario sacrificale) del comune di Trino, poi ritirata a seguito dell’ampio lavoro del comitato Tri.NO per mostrare l’incompatibilità del territorio. A tutt’oggi non è dato sapere quale sarà la fissa dimora di questi rifiuti radioattivi. Sicuramente trovare una soluzione più sicura che metta fine all’epopea nucleare italiana è essenziale. Inevitabile però è farlo a una condizione precisa, che finora non è mai stata rispettata dalle molteplici proposte avanzate dalla SOGIN, ovvero la certezza che tutto ciò sia fatto mettendo in completa sicurezza il territorio prescelto e con la piena consapevolezza della popolazione. Troppo spesso i progetti presentati si sono dimostrati fallaci, troppo spesso sono stati i comitati a dover dimostrare di conoscere il proprio territorio molto di più di dirigenti energetici incompetenti. Una cosa è certa, ovvero che i comitati che si sono formati a difesa dei territori prescelti dalla CNAI, come il Comitato No Deposito Nucleare di Alessandria, continueranno a lottare (e noi con loro).
Nonostante questi rifiuti tossici non abbiano ancora trovato casa, le politiche europee e nazionali rilanciano sulla possibilità di utilizzare nuovamente il nucleare come risorsa “pulita” per far fronte al riscaldamento globale in corso e alla necessità – per l’assetto produttivo intensivo – di nuove fonti energetiche considerate “meno inquinanti”.
Il cambiamento climatico stesso, che vediamo in atto ogni giorno, e che rischia di perturbare per sempre i nostri habitat deriva dall’impossibilità di tamponare l’effetto negativo che questi processi su larga scala hanno iniziato a infondere nell’atmosfera a partire dalla Rivoluzione Industriale. L’anidride carbonica, il metano, i PPM rientrano in quelle sostanze che il sistema non può fare a meno di produrre. I loro impatti si sono accumulati nel tempo e conducono a trasformazioni globali dell’atmosfera,con conseguenti impatti che si ripercuotono specialmente sulle aree e le regioni più povere e isolate, costrette a subire ondate di calore, alluvioni, aria irrespirabile e siccità che mettono in ginocchio chi le abita. I movimenti climatici, da Fridays for Future a Extinction Rebellion, da End Fossil a Ultima Generazione si sono battuti dal 2018 per denunciare la strada di non ritorno a cui ci stanno conducendo politicanti e aziende fossili. La generazione stessa di queste molecole è diventata fonte di guadagno dal momento che si sono istituiti i mercati del carbonio e le pratiche di carbon capture and storage (cattura e stoccaggio di carbonio), che non sopperiscono al problema, ma lo tamponano e da esso ne traggono profitto, seguendo i diktat del famoso Green Deal Europeo. Non esiste bonifica a un’alterazione permanente del clima.
Nella totale assenza di reali politiche di prevenzione della produzione di rifiuti, sostanze climalteranti e nocività, ed in totale contraddizione con molte altre politiche dell’Unione Europea, in primo luogo quella bellicista, la Nature Restoration Law approvata il 17 giugno 2024 tenta di imporre gli obiettivi di ripristinare almeno il 20% dei territori marini e terrestri dell’UE entro il 2030 e tutti gli habitat minacciati entro il 2050. Al di là della palese difficoltà di rispettare tali percentuali e scadenze, è evidente che la logica estrattivista appoggiata da tutti i livelli di governo e non contrastata da soggetti preposti al controllo (per esempio restano quasi sempre mute le Soprintendenze) sta andando in senso diametralmente opposto, martellando nelle coscienze la necessità della crescita a oltranza e di un conseguente indispensabile sacrificio di ambiente, territori e biodiversità. Fino all’ultima goccia d’acqua, all’ultima foglia, all’ultima zolla di suolo fertile.
Come chiudere il cerchio?
La conseguenza dell’estrazione infinita di materie prime, della cementificazione e della (finta) riqualificazione urbana, della costruzione di mega-opere inutili, della produzione industriale, dell’agricoltura e degli allevamenti intensivi, della produzione energetica, dell’espulsione dei rifiuti e di nocività in continua crescita è il deterioramento progressivo delle risorse che sono alla base del ciclo stesso. I suoli si fanno più aridi, la disponibilità di materie prime diminuisce, mentre aumenta la devastazione dei territori legata alle infrastrutture energetiche considerate sostenibili dalla transizione ecologica attuale. Per tutto ciò, i nostri territori risultano sempre più invivibili.
La voracità del sistema capitalista impone, nonostante la contraddizione alla base del ciclo, di erodere ulteriori porzioni di suolo vergine, di contaminare e incanalare milioni di metri cubi di acqua, di scavare per estrarre terre rare, di occupare terreni agricoli con distese di pannelli fotovoltaici e pale eoliche. Il cortocircuito del sistema sta nella sua imperterrita e miope volontà di distruggere le poche risorse ancora disponibili con l’obiettivo di fare perdurare questo modello di produzione e di consumo, in una sorta di inesorabile declino al quale intende fare fronte ricorrendo alla tecnologia e alla retorica green.

La Ristrutturazione dei territori per il capitale
Quali tendenze e quali anticipazioni?
Nel solco di quanto detto fino ad ora vogliamo giungere ad alcune prime e non esaustive conclusioni, che vorremmo intendere come indicazioni in prospettiva per orientare il nostro sguardo ed essere pronti a contrastare l’attacco sui nostri territori.
La grande contraddizione della nostra epoca si potrebbe riassumere così: la smania di produrre e quindi di devastare i territori, proprio nel momento in cui il contrasto al cambiamento climatico e l’attenzione ecologista sono diventati il paradigma dominante, deve conciliarsi con una logica di legittimazione della produzione ad ogni costo procurandosi un impianto discorsivo all’altezza.
La narrazione green serve precisamente a legittimare il capitalismo, tramite un pretestuoso artificio retorico con il quale si dice di voler declassare le energie fossili a beneficio delle rinnovabili, mentre non si fa mai riferimento alla necessità di imporre un freno alla produzione e al consumo sfrenati. Anche i potenti hanno la necessità di dichiararsi ambientalisti, ma la progettualità miope di chi gestisce risorse e territori fa crollare come un castello di carte il loro adoperarsi di facciata. Non soltanto per pulire le coscienze ma anche per una necessità pratica, le energie rinnovabili occupano il centro della scena oggi. Mentre continua l’erosione delle risorse e delle materie prime e si generano crisi geopolitiche, mentre si riduce l’accesso a fonti fossili come gas e petrolio e la guerra viene sdoganata come possibilità a cui ricorrere nella corsa all’egemonia mondiale, il sistema capitalista si rivolge alle fonti gratuite e illimitate per poter garantire la propria riproduzione e restare così com’è. Per quali usi e per quali consumi il vento, il sole, l’acqua vengono mercificati e sfruttati, in una logica in cui si tutela il capitale e non il territorio? Il sistema estrattivista offre delle soluzioni fintamente lungimiranti, in particolare nell’ambito del riciclo e nell’ambito delle energie rinnovabili. Nell’immediato diventano così nuove possibilità per alimentare il ciclo di accumulazione a scapito delle terre e delle risorse. Questa contraddizione si manifesta concretamente sul territorio con l’appropriazione di terreni fertili e agricoli con l’obiettivo di installare distese di fotovoltaico o di pale eoliche, tutto a beneficio di una catena che si deve autoalimentare. Questo processo favorisce la privatizzazione dei territori e dinamiche di sfruttamento su diversi livelli. La prima domanda da porci è: ma per chi? per quale utilizzo?
La famosa transizione ecologica ed energetica tanto decantata dall’Unione Europea si inserisce così in questa fase come una necessità innanzitutto narrativa e di creazione di immaginario, più che essere espressione di una reale volontà di intervenire a fronte del disastro annunciato. Come stiamo assistendo sui nostri territori, la prima conseguenza è la pioggia di finanziamenti che irrora in maniera irrazionale Comuni indebitati, pronti a svendere la terra cedendo al ricatto del denaro. I progetti finanziati dal flusso di capitale green si schiantano prima davanti alle opposizioni della popolazione e poi davanti all’insensatezza e inadeguatezza di questi interventi. Sulla base di esperienze passate, si può ben temere che, pur di accedere ai fondi, le amministrazioni locali aprano cantieri, sbanchino terreni, posino una prima simbolica pietra della nuova opera senza minimamente preoccuparsi di terminarla. Questa pratica apre la strada a cantieri e subappalti disseminati in ogni dove, a esternalizzazioni, a infiltrazioni mafiose, anche con il risultato di un complessivo peggioramento e deterioramento delle competenze tecniche necessarie per realizzare opere. Condizioni inumane per i lavoratori, tempi stretti, carenza di materiale di qualità, progetti non finiti, sperpero di denaro pubblico, colate di cemento, incapacità e miopia diventano così la realtà quotidiana della transizione verde a casa nostra. In tendenza leggiamo l’imposizione del paradigma dell’impoverimento e della svendita non solo delle terre e delle risorse, ma anche delle competenze di chi dovrebbe gestire, intervenire, operare in questi ambiti. Il sistema capitalista estrae valore anche dalle persone senza dare nulla in cambio, con la mercificazione, la svendita e l’esproprio delle capacità umane, nonché impoverendo i contesti di vita e peggiorando progressivamente le condizioni delle nostre esistenze.
Il sistema tende anche a restringere progressivamente gli spazi di tutela e difesa amministrativa e giuridica che i cittadini o i Comitati utilizzano, per lo più insieme ad altre pratiche, per lottare contro gli interventi che hanno impatti nocivi sull’ambiente e sulla salute.
La logica emergenziale abbrevia i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni ai progetti o ricorrere in tribunale. Inoltre, la magistratura amministrativa (il TAR e il Consiglio di Stato) “è ancora, e rimane spesso, il tribunale del Re”4, tende a considerare prioritario l’interesse pubblico che in teoria e in astratto – ma non in pratica e in concreto – muove l’azione della Pubblica Amministrazione. Perciò respinge pressoché sistematicamente i ricorsi dei cittadini, condannandoli a spese a quattro zeri. Questo avviene soprattutto nel caso di ricorsi che mirano a scongiurare un danno potenziale: i giudici del TAR, infatti, accettano di valutare quasi esclusivamente le vertenze che riguardano un danno già compiuto. Se ne accertano l’esistenza, liquidano un risarcimento. In tal modo, il sistema tipicamente compensa danni materiali e immateriali talora irreparabili cedendo una piccola parte del valore monetario estratto. L’azione inibitoria, ossia la prevenzione del danno alla salute e all’ambiente, è invece di fatto esclusa dalle competenze dei giudici: quantomeno questo è ciò che si riscontra sinora nella pratica giuridica. Quanto alla giurisdizione del magistrato ordinario, essa viene spesso contestata o negata dal magistrato stesso, anche quando si tratta di lesione di diritti fondamentali. Occorre quindi un profondo cambiamento giuridico-culturale.
Nel 2022 l’articolo 9 della Costituzione, che già affermava che la Repubblica “tutela il paesaggio”, è stato modificato aggiungendo “Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”. Ma, alla luce di tutto quanto sta accadendo, sembra che la politica intenda la Costituzione a rovescio, come elenco di tutti i diritti che l’estrattivismo può impunemente calpestare. Da fonte suprema del nostro diritto, sta diventando la cenerentola delle norme. Confliggono infatti con l’art. 9 della Costituzione anche le leggi che puniscono duramente i manifestanti, emanate dichiaratamente contro gli “ecovandali” o contro chi manifesta contro un’opera pubblica o un’infrastruttura strategica (si veda il Ddl Sicurezza in corso di approvazione), inasprendo ancora di più l’uso perverso della legge contro il dissenso, come visto con gli arresti e i processi ai NOTAV in Valsusa e recentemente nel caso degli attivisti climatici. Quindi oltre alle restrizioni degli spazi di azione giuridica dei cittadini, vengono limitati sempre più per decreto anche quelli di azione politica.
Ulteriore ostacolo all’azione dei Comitati è il fatto che le Amministrazioni si servano degli organi di stampa e dei mezzi di comunicazione come di armi contro i cittadini attivi: esaltando la bontà dei progetti, stigmatizzando l’aggressività dei manifestanti e legittimando, al contrario, il margine di azione violenta delle forze dell’ordine, accendendo, spegnendo e orientando i riflettori in modo da influenzare l’opinione pubblica. Attraverso la narrazione, si creano ad arte anche spaccature ideologiche tra la popolazione, rinnovando il motto divide et impera. Il degrado dell’obiettività, della qualità e dell’indipendenza del giornalismo attuale ha un ruolo importantissimo nel creare facciate di greenwashing e democrazia mentre procedono le distruzioni e si calpestano i diritti. Chi come noi è attivo nei comitati talora riesce a far passare la sua voce senza deformazioni attraverso qualche quotidiano locale, ma per lo più si fa ricorso ai social network, con tutti i loro limiti, per comunicare all’interno e all’esterno. È importante sottolineare la necessità di ripristinare l’abitudine alla discussione in presenza, alle assemblee, alle decisioni basate sul consenso, andando oltre la democrazia fondata sulla maggioranza e rammendando quel tessuto comunitario che è andato sempre più sfilacciandosi.
Tutto ciò deve spingerci a interrogarci sull’incisività e le possibilità di azione che abbiamo. È infatti utile domandarsi, a partire dalle condizioni in cui ci attiviamo, quale modalità di lotta possa portare a dei risultati, a fronte del restringimento degli spazi di tutela giuridica e amministrativa,
L’analisi che stiamo mettendo in campo vorremmo fosse strumento utile per anticipare le mosse future del capitale: essere consapevoli delle tendenze in atto può permettere di organizzarci a nostra volta impedendo al sistema di profitto di agire indisturbato. Affinando le nostre pratiche e le nostre intelligenze potremo attivarci e mobilitarci in maniera da spiazzare chi vorrebbe imporre opere e progetti inutili e dannosi, e da trasformare i nostri territori da zone di sacrificio a zone da difendere di cui riappropriarci per il bene collettivo.

Strumenti per resistere
AUTONOMIA DEL NO E AUTONOMIA DEL SAPERE
Oggi è fondamentale salvaguardare la nostra autonomia del NO e la nostra autonomia del sapere.
Molto spesso le istituzioni, dalle amministrazioni locali al governo, muovono ai comitati l’accusa di “essere quelli del NO”. Per noi dire NO è l’atto costitutivo di un processo democratico reale e ricompositivo. Intorno a tutti i nostri NO si coagulano relazioni, rapporti con il territorio e l’umano e il non umano, capacità critica, possibilità di riscatto dalle imposizioni dall’alto, identità che rifiutano di essere trattate come burattini e che vogliono tagliare i fili del loro burattinaio. Dentro tutti i nostri NO sono insite proposte che parlano di tutela, di cura, di attenzione al patrimonio naturale e umano che permette la riproduzione della vita sul nostro pianeta. Le nostre proposte individuano i propri fini comuni non nel profitto ma nella possibilità stessa di sopravvivere, ambendo alla conquista di esistenze, spazi e tempi più sostenibili, più vivibili, più a nostra misura.
Dobbiamo quindi rivendicare la legittimità di dire NO all’estrazione indiscriminata delle risorse naturali, alla cementificazione, alla sovrapproduzione e alle esigenze di consumo indotte, all’inquinamento e al deterioramento delle nostre terre e delle acque. Perché dire NO a quello che abbiamo definito un “cortocircuito estrattivista” significa avere compreso che il sistema così come esiste oggi è programmato per ristrutturarsi continuamente, per garantire l’estrazione di valore che gli permette di riprodursi. E per fare ciò è (pre)disposto a sacrificare territori, vite umane e non umane. Il costo della riproduzione del sistema capitalista, su piccola e larga scala, è sempre più enorme perché, per alimentare il ciclo di accumulazione del valore, il sistema è costretto a impoverire e a erodere i territori dai quali estrae le risorse primarie che, immediatamente, trasforma in merci. A essere erose sono le possibilità stesse di riproduzione della vita, fino a scatenare anche guerre vere e proprie per l’accesso e la conquista di spazi e di beni.
Molto spesso chi si attiva contro un progetto o un’opera inutile viene accusato anche di ignorare la scienza, di provare avversione contro il progresso, di avere una mentalità retrograda. Come abbiamo visto, a essere anacronistici e antiscientifici sono molto spesso la nostra controparte e il suo agire. Noi siamo coscienti di stare costruendo, invece, un sapere aggiornato, scientifico e autonomo, un sapere che vuole liberarsi dalle maglie del profitto. Nelle lotte territoriali che abbiamo raccontato uno dei fili rossi è, infatti, la grande e profonda conoscenza della storia e del presente del proprio territorio, è la volontà di informarsi, comprendere, analizzare costi, benefici, conseguenze, impatti dei progetti e delle opere. Queste spinte danno forma a saperi tecnici e scientifici risultanti dalla cooperazione, dalla messa in rete di competenze diverse e dal coinvolgimento di tecnici non asserviti alle logiche del potere, che mettono a disposizione le loro conoscenze. È un patrimonio prezioso che dobbiamo mettere in circolo e soprattutto è ciò che dimostra che nelle comunità locali, nei comitati, nelle realtà che spontaneamente nascono per proteggere le proprie dimensioni di vita ci sia un’idea precisa di come si vorrebbero gestire risorse e territori, ossia nell’interesse della collettività, del bene comune e non del profitto di pochi.
LA RETE È FORZA: IL PROGETTO CONFLUENZA

Il progetto CONFLUENZA nasce proprio a partire da queste constatazioni e dalla necessità di moltiplicare e dare solidità reciproca alle esperienze territoriali. Il progetto intende costruire una rete effettiva tra tutte quelle realtà che si attivano per difendere i propri territori contro progetti inutili, dannosi e imposti dall’alto senza condivisione. Per noi rete effettiva significa una rete di rapporti di scambio e conoscenza reali, di confronto e di supporto reciproco, in presenza.
Per mettere in pratica questo obiettivo bisogna considerare due aspetti fondativi: da un lato, la necessità di sistematizzare il patrimonio di conoscenze costruite dal basso grazie alla ricchezza delle opposizioni ai progetti e opere devastanti per il territorio; dall’altro lato, l’esigenza di poter contare e di costituire una massa, dei numeri, in grado di ottenere i propri obiettivi nel rapporto di forza con la controparte.
Ci siamo dotati di due strumenti.
Il primo è una sezione sul sito Infoaut (https://infoaut.org/confluenza) in cui raccogliere i contenuti di ciascun comitato, li rendiamo visibili e li mettiamo in rete, proponendo inoltre contenuti di approfondimento. Questo significa con-ricercare5, cercare insieme a chi anima le lotte per la tutela dei territori le leve e le possibilità per opporsi a chi vuole devastarli: vogliamo esprimere e diffondere le buone ragioni per dire NO, le conseguenze, gli impatti ambientali, sociali ed economici.
Il secondo è l’idea di organizzare iniziative nei territori, sia laddove esiste già un’attivazione, sia dove ancora è marginale, per supportare le varie realtà nel creare momenti di sensibilizzazione, di informazione e dibattito ma anche di mobilitazione, mettendo insieme le nostre forze.
Perché quello che abbiamo capito, e provato a rappresentare come un cortocircuito estrattivista, è che ciascuna opera è funzionale ad un’altra. Davanti alla capacità del sistema capitalista di strutturarsi e di organizzarsi dobbiamo essere all’altezza della complessità di questo sistema e organizzarci a nostra volta, darci la possibilità di essere di più, di contare di più, di farci forza a vicenda. Proprio perché i progetti dislocati sui nostri territori sono nel complesso parte di un unico sistema, anche le nostre energie devono confluire verso un unico obiettivo: la difesa e la tutela del vivente.
Non esistono alternative se vogliamo un futuro.
Quindi la nostra proposta è di avviare un processo costituente al quale invitiamo a collaborare e partecipare attivamente:
- il primo modo per contribuire è inviare materiale, scambiarci informazioni, produrre ricerca e dare visibilità alle singole iniziative: siamo disponibili a venire sui territori dove ci sono progetti di devastazione, incontrarci, fare interviste, video e foto da pubblicare sulla rubrica di Confluenza, in modo da diffondere il più possibile le iniziative di ciascuno, le ragioni del NO a un’opera, gli studi che sono stati fatti;
- il secondo modo per contribuire è costruire insieme iniziative, momenti di dibattito, di incontro e di informazione sul territorio insieme ai comitati e alle realtà già attivate in loco. Vogliamo dare supporto logistico e costruire contesti di confronto il più largo e partecipato possibile;
- infine, vi invitiamo a collaborare al tour di presentazione del Manifesto di Confluenza, organizzando una data presso il vostro Comune: il tour prenderà avvio in autunno e si prefigura di ragionare insieme sulla costruzione di un momento collettivo di mobilitazione.
Per raggiungere questi obiettivi, restiamo in contatto:
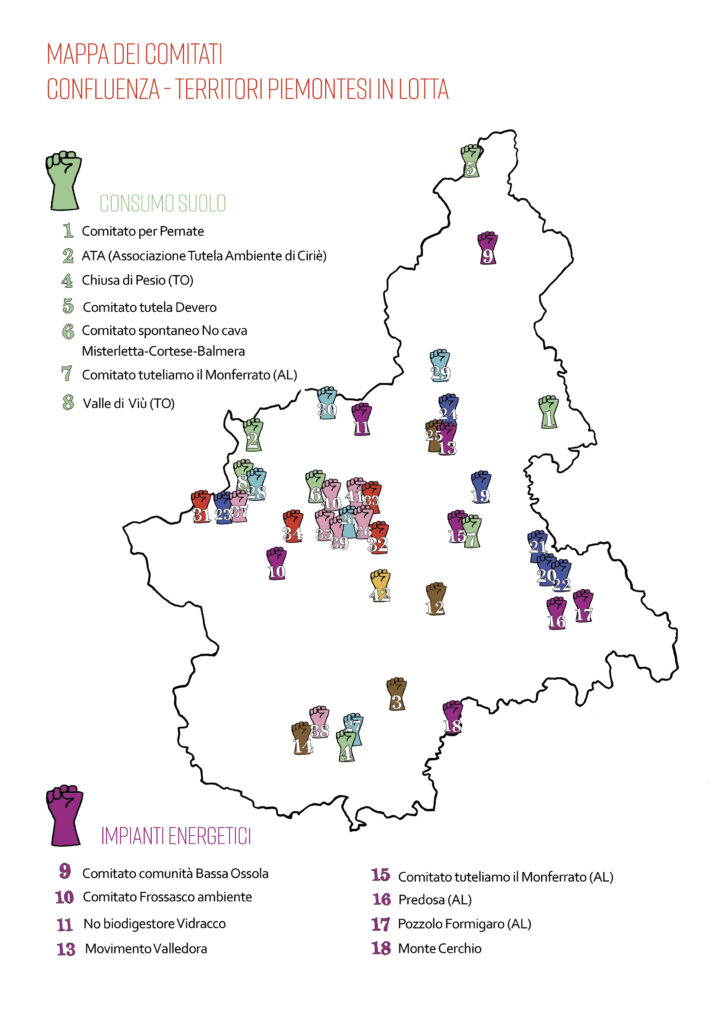

GLOSSARIO
Buffer zone: una zona cuscinetto, posizionata accanto a corpi idrici, vegetazione naturale, aree specifiche molto frequentate da popolazione per proteggerle da potenziali impatti ambientali, come quelli provocati dai fitofarmaci.
Capitalismo dei disastri: traduzione italiana di disaster capitalism, espressione coniata da Naomi Klein (The Shock Doctrine, 2007) con cui si indica la pratica neoliberista di sfruttare le calamità naturali e di generare catastrofi artificiali (es. guerre), come vettori di profitto privato, vitali per mantenere lo status quo, traendo lucro dalle conseguenze negative sull’ambiente, sui territori e sulle popolazioni.
Confluenza: in geografia, la confluenza è l’incontro di due o più corsi d’acqua, l’incontro di due o più ghiacciai o vallate. Per noi è un’unione di intenti.
Fracking: tecnica di estrazione di gas o petrolio tramite frantumazione delle rocce mediante iniezione di liquido ad alta pressione. Una pratica ad altissimo impatto ambientale.
Deregulation: processo attraverso cui i governi diminuiscono o eliminano i controlli sul mercato e cancellano le restrizioni nell’economia, al fine di lasciare mano libera al mercato stesso, considerato come un organismo autoregolatore
Estrattivismo: secondo la letteratura accademica, l’estrattivismo è un processo attraverso cui il capitale sottrae valore dai territori, devastandoli e depauperandoli e prelevando le risorse presenti. Per noi non è semplicemente un ciclo ma un cortocircuito, in quanto impoverisce e desertifica – in maniera spasmodica e continuativa – i territori, generando un effetto mortifero che minaccia la sua stessa possibilità di riproduzione.
Land grabbing: accaparramento delle terre, che si verifica quando una larga porzione di terra è svenduta a soggetti privati o espropriata senza il consenso delle comunità. Lo stesso meccanismo può avvenire nel caso dell’acqua, per cui si parla anche di Water Grabbing.
Shock economy: espressione coniata da Naomi Klein (The Shock Doctrine, 2007) con cui si indica la pratica dell’economia neoliberista – derivata dalla Scuola di Chicago facente capo a Milton Friedman – di attuare privatizzazioni e tagli alla spesa pubblica in situazioni di shock, ossia emergenziali, derivanti da calamità naturali o disastri creati dal sistema stesso.
Territorio: contesto composto da relazioni umane e non umane, sociali, economiche, politiche e culturali. Al suo interno ogni soggetto si definisce, ma al tempo stesso ogni soggetto influenza in maniera mutuale il territorio in cui è immerso.
Zona da difendere: dal francese Zone à Defendre (ZAD), è un territorio minacciato dalla costruzione di un’opera o dall’installazione di un progetto che ne minerebbe le qualità e l’assetto. Le Zone da difendere sono quelle da preservare in quanto tali e che vengono protette da comitati e cittadini che non sono disponibili ad abbandonarle a un destino che le comprometterebbe per sempre.
Zona di sacrificio: area già oggetto di inquinamento o danneggiamento permanente, che anziché essere ripristinata, viene selezionata come più adatta di altre per ulteriori progetti di distruzione, e quindi destinata a essere oggetto di sfruttamento in permanenza in quanto già compromessa.

Per scaricare Confluenza in versione per la stampa:
NOTE
- Raoul Zibechi, La scottante attualità di Fanon, in “Comune-info”, 9 settembre 2015 https://comune-info.net/la-scottante-attualita-di-fanon/ ↩︎
- Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con la legge n. 481 del 1995, che dovrebbe controllare il mercato e tutelare i consumatori, ma di fatto favorisce le operazioni dei gestori che spesso sono multiutility come ACEA. HERA, A2A, IREN ↩︎
- Nel Rapporto sul consumo di suolo 2023 del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) gli ettari di suolo occupato dai parchi fotovoltaici sono 17830. ↩︎
- Così la definisce l’Avv. Mario Marcuz nel suo intervento al convegno Il Don Bosco fa scuola organizzato il 25/05/2024 dal Comitato Besta che a Bologna lotta contro il progetto comunale di demolizione di una scuola e di distruzione di un giardino pubblico. Si consiglia la visione del video:
https://www.youtube.com/watch?v=JR7–GnAUGo&list=PLH-WioeRsi-7TKwX7-_BVsc1LU5IX1N3x&index=8&t=16s ↩︎ - La conricerca è un termine che viene spiegato nel volume Per fare conricerca di Romano Alquati. La conricerca è il rifiuto delle certezze, si tratta di un metodo e un atteggiamento che porta a non accettare le cose di per sé perché c’è sempre la necessità e la possibilità di fare un passaggio successivo. La conricerca significa essere presenti dove occorre fare fronte comune, ricercare insieme e costruire saperi che vogliamo sottrarre all’avversario, con il fine di organizzarci insieme a partire dai saperi che emergono dalle lotte e dalle attivazioni spontanee. ↩︎
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.
confluenzaconricercaCRISI CLIMATICAESTRATTIVISMOmanifesto confluenzapiemonteterritori










