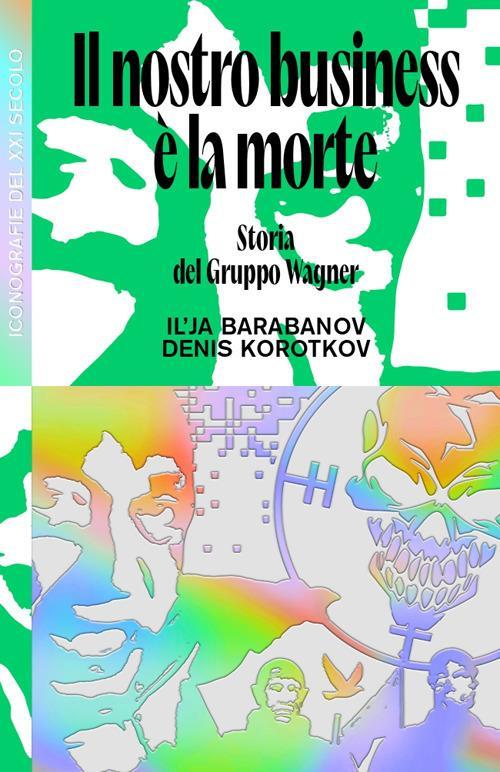Black Mirror: in viaggio tra distopia, nichilismo e ambivalenza

Un mondo di gabbie o di campi di battaglia?
“Essere caparbiamente rivoluzionari quando non ci sono rivoluzioni non è né divertente né tanto invidiabile”, scriveva Romano Alquati anni fa. Ma essere rivoluzionari, domanda il secondo episodio di BM costruendo la figura del protagonista di “15 Million Merits”, è ancora possibile al giorno d’oggi, quando ogni aspetto della vita è messo a valore? Quando la bellezza è travolta dalla corruzione capitalistica? Quando viene costruito un ambiente soffocante quanto le vetrate e la pubblicità perenne che circondano le stanze dove vivono, isolati, gli uomini e le donne di questo immaginario futuro dispotico? Rompere questa vetrate sembrerebbe l’unica possibilità che rimane per immaginare un mondo dove la bellezza e il “buon vivere” la facciano da padrone. Eppure, anche rompendole, non è detto che la situazione migliori: la forza di sussunzione del sistema è troppo potente rispetto allo sforzo del singolo, che rischia di essere riassorbito dal primo.
Diciamolo subito: questa risposta (la risposta implicita della puntata citata) così come la risposta dell’intera serie, non ci convincono. Ma ciò non vuol dire che queste risposte non debbano essere analizzate a partire dai grandi temi di fondo che mettono in luce le domande da cui scaturiscono. BM sembra sottolineare che anche i momenti di rottura, al giorno d’oggi, diventano benzina per il fuoco dell’industria dello spettacolo, del dominio dell’evento, dello show che sussume a sé economia, politica,etica. Ma questa prospettiva è intrinsecamente nichilistica, dal punto di vista di chi invece crede nell’ambivalenza dei processi, nel loro possibile direzionamento: un nichilismo non proiettato all’esterno, vissuto come carica destituente (pensiamo come esempio contrapposto alla furia distruttrice di un “Fight Club”), ma masochista, passivo, orientato ad una sconfitta totale nella battaglia per la costruzione di relazioni sociali altre.
Molti spazi di costruzione di queste relazioni sociali “altre” possono avere determinazioni risalenti anche ad episodi che vanno a rinfocolare l’industria dello spettacolo. Ciò è provato da decine di accadimenti passati, che piuttosto ci dicono che l’importante è non vendersi, è saper utilizzare le vetrine senza cedere alle lusinghe della corruzione, per quanto difficile possa essere. Quello che sembra ignorare BM è che molto spesso i nuovi antagonisti che si soggettivano nelle pieghe della metropoli lo fanno grazie proprio alla fruizione di quelle poche cose che accedono sul mainstream, riutilizzate e risignificate nella produzione di comportamenti di rottura.
Sfondare il muro del media mainstream significa offrire una vetrina a comportamenti che poi però vanno giocati in quei terreni non completamente colonizzati da parte del nemico, o quanto meno in quei terreni nei quali una rifiuto e una rottura della colonizzazione nemica di parte antagonista è possibile. In termini più elevati, la destrutturazione o è combinata insieme all’autovalorizzazione, o semplicemente non è. Come in The Wire, è apprezzabile di BM il non voler costruire figure eroiche, l’accento messo su una realtà possibile anche se mascherato nella fantascienza; non del tutto convincente però l’immagine di una gabbia impossibile da squarciare, lo schieramento implicito (di impronta borghese..) degli autori verso l’ineluttabilità del “non c’è niente da fare”. La storia ci insegna che in tante gabbie costruite dalla controparte – basti pensare all’esperienza delle lotte anti-coloniali – si sono sviluppate le capacità di rompere le sbarre per proiettarsi nella costruzione di un esistente diverso.
Un mondo dominato dalle giurie?
Prendiamo ancora “15 million merits”. E’ notevole il modo in cui è resa l’immagine che collega la solitudine dell’individuo contemporaneo al bombardamento sulle soggettività (gli specchi che ci circondano – social e tv insieme, con buona pace dell’idea della liberazione automatica tramite la rete) e delle relazioni che si manifestano tramite avatar Ci convince l’accento sulla quasi-impossibilità di fuggire a tale bombardamento sui comportamenti, se non ricevendo in cambio sanzioni di vario tipo e stigmatizzazione sociale (quando non con psicofarmaci, che assurgono a costante dell’esistenza). Eppure è accennato troppo poco il fatto che ci sono spazi comuni dove la bellezza e lo scambio, la mutualità, si possono ricercare, spazi sui quali bisogna insistere. La mensa, l’ascensore (per restare alla puntata in esame) sono luoghi in cui diverse modalità di relazione (cooperazione/egoismo, amore/isolamento) si espongono, ed è proprio quella possibilità di costruire cooperazioni differenti che viene accennata troppo poco nella distopia complessiva di cui si ammanta l’episodio.
La puntata pone altre domande. Inanzitutto, su una delle dicotomie che caratterizza i nostri tempi. E’ possibile cercare qualcosa di reale nel mondo dominato dal virtuale? Anche qui, la risposta degli autori non ci convince affatto. Non crediamo abbia senso riproporre la distinzione tra un “reale” positivo e un “virtuale” negativo: viviamo in un mondo dove reale e virtuale sono spesso iscindibili.
Gli spazi di celebrità sono ridotti al minimo (grande produzione che soffoca quella indipendente, quella davvero “bella”) e allora al bello, per “smettere di pedalare” rimane solamente la prostituzione, non solo nel senso fisico, ma soprattutto in quello della svendita della propria esistenza, in uno scenario tristemente ambito da “quelli fuori” che giustamente cercano una scappatoia dalle costrizioni della bicicletta, dalla miseria. Uno scenario che porta al fatto che non allinearsi, non scambiare quella miseria con un’altra equivale quasi al fatto di tradire chi è costretto a pedalare. E’ un ricatto morale, quello su cui si fonda il dominio della società dei reality e dello sfruttamento, ed è un enorme punto a favore di BM avercelo fatto percepire cosi bene.
Ma amore e relazioni, arte e cultura, sono sì forse una parte della via per la salvezza, eppure sono sempre determinate dall’ambiente in cui si sviluppano..e in cui le diverse arene, dall’incontrarsi nella piazza al chattare, sono entrambe costitutive di queste. Reale e virtuale sono, certo, ambienti entrambi sussunti (vedi gli avatar che rappresentano lo specchio della propria immagine da coltivare, oppure l’esibizione al talent show dove la messa a profitto delle passioni nel capitalismo attuale viene affrontata superbamente ), ma nei quali è possibile agire in maniera diversa.
Ma non tutto il giudizio, per quanto riguarda il lato del “messaggio” è negativo; ci esaltiamo nel vedere come il lavoro non venga affatto rappresentato nella dimensione di un qualcosa di nobile venuto a mancare (la metafora della bicicletta lo descrive invece come dura fatica quotidiana, nella quale anche una maggior flessibilità dei tempi di lavoro, in un contesto di mancanza di diritti e di welfare, aggiunge ansia e stress) e ci convince la narrazione di una società “ad escludere” in cui pochi giudicano le possibilità di molti di poter salire di grado; un mondo dominato da giurie (pensiamo ai reality musicali, ai vari MasterChef e cosi via) in cui la competizione è la regola e i comportamenti riprodotti dai “giusti” i giurati, li elevano a star indiscusse e a moderni “arbitri in terra del bene e del male” come avrebbe detto un noto cantautore genovese.
Rivoluzioni copernicane, ma con quale soggetto?
Cambiamo scenario. In “Vota Waldo!” si assiste alla rappresentazione delle conseguenze sulla rappresentanza politica dovute all’avvento dei social network. Non è un caso che la puntata inizi con le dimissioni di un esponente politico dovute proprio al potere rivelatore e alla viralità a cui è impossibile sfuggire del web 2.0. E’ proprio però l’impossibilità della politica di oggi a sottrarsi dalla relazione con i social network il punto focale dell’episodio. Il tema è trattato con ancora più realismo in “Messaggio al Primo Ministro”, dove addirittura una farsa, una messinscena, uno dei tanti fake della rete si eleva ad episodio capace di poter cambiare le dinamiche politiche grazie al potere ricattatorio dell’opinione dei netizens (i cittadini della rete).
In “Vota Waldo!” si racconta la possibilità, nel mondo di oggi, di poter pensare a candidature politiche di personaggi non in carne ed ossa, di prodotti della rete, di simboli più che di uomini. Di artefatti che approfittando della disillusione nei confronti della “vecchia politica” si possono proporre per rimpiazzarla. Lo scambio in cui il politico conservatore accusa Waldo di non esistere, e il pupazzo risponde di non capire, se non esiste, perché allora questo parli con lui spiega alla perfezione questo discorso. Waldo diventa fenomeno popolarissimo in rete, il video in cui demolisce i candidati “classici” nel dibattito organizzato dagli studenti ottiene un milione di visualizzazioni..ma?
Ma questi prodotti della rete e dello spettacolo in senso largo, e qui sta il messaggio principale dell’episodio, non possono esimersi dalla dimensione della carnalità intesa nel senso dei manovratori di questi prodotti. Non possono esimersi dalla misurazione sul terreno del reale, inteso non in senso antagonistico al virtuale ma come parte di una totalità dell’arena politica. Le controindicazioni sono tutte nell’ambivalenza della rete: emerge la possibilità e la volontà di spregiudicati controllori del mondo dell’informazione di usare il capitale sociale di Waldo per fini privati, che viene suggerita come esito più probabile di fenomeni di questo tipo (la somiglianza del produttore televisivo con la figura di Casaleggio è strabiliante).
Una deriva ineluttabile? Non crediamo. A non essere sottolineata nell’episodio è la rapidità, la velocità con la quale l’effetto sorpresa-meraviglia di questo tipo di operazioni si dissolve nel breve volgere di qualche settimana, dato che se la politica diventa moda, esplosione del breve, automaticamente poi ritorna nel suo cantuccio:“Lui provoca, e quando non riesce a dire battute divertenti, ricorre alle parolacce”..vi ricorda qualcuno? Un’ipervelocità del “passaggio di moda” di ogni prodotto/idea/programma che riguarda non solo la vecchia politica, ma anche ciò che si spaccia come nuovo. Anche qui forse BM si spinge troppo in là nella possibilità di vedere continuità in processi che invece hanno un elemento fondamentale nella propria freschezza, nella propria novità. E’ proprio la novità che oggi domina in maniera totale la produzione di valore, in un mondo dove i social network ciò che portano alla luce, lo nascondono un secondo dopo. Piuttosto Waldo, come ben sottolinea l’emissario della CIA nell’episodio, è un metodo: cosa che lo rende ancora più spaventoso..
Il punto anche qui sta nell’elemento che manca. Ovvero la possibilità dell’ambivalenza: quando la candidata Harris accusa l’attore che sta dietro Waldo di aver mancato di coraggio, di non aver puntato alla rivoluzione ma solamente di aver rafforzato il candidato conservatore sputando su tutto e tutti, rinchiude gli effetti di Waldo solamente nell’ambito dell’istituzionale: ma è negli spazi aperti dalla crisi della rappresentanza, nell’agirla politicamente dal basso, che si può sfruttare e andare oltre la rappresentazione del malcontento sociale agita da un pupazzo. Facendo i conti con sé stessi e dicendosi chiaramente che la mancanza nella capacità di coagulare quel malcontento a fini antagonistici non è dovuta all’azione del pupazzo, ma alla insufficienza attuale dei movimenti (che non implica la loro assenza o la loro mancanza di tenacia).
Come in “Messaggio al Primo Ministro” si sottolinea la correlazione tra i fenomeni dovuti agli effetti del mix tra il web 2.0 e la crisi della rappresentanza e della credibilità della politica istituzionale ai tempi della crisi globale. Anche la candidata laburista è attaccata nel suo voler giocare alle regole nonostante queste la vedano perdente o comunque subalterna ad un ordine del discorso non aperto ai cambiamenti; del resto è lo stesso comico a dire “Tutto funziona così, per questo tutto fa schifo!”. Il problema è che la tentazione del profitto è ben presente anche in questo tipo di economia, in un’evidenza narrativa che fa a pezzi chi ancora (pochi) crede nell’automatica liberazione in potenza che la rete può produrre.
Profilazione, colonizzazione e sfruttamento delle soggettività
Il tema dei social network ritorna anche in “Torna da me”, primo episodio della seconda tranche. In questo caso vengono evidenziati aspetti ormai notori nel dibattito in ambito militante sulla potenzialità di sfruttamento di tutti i dati sensibili che lasciamo di noi nelle reti sociali; in questo caso addirittura si immagina la possibilità, del tutto possibile in teoria, di ricreare a partire da questi dati un robot avente la stessa personalità e lo stesso “archivio” di frasi, conoscenze, esperienze di una persona X. La puntata è un’intera allegoria dell’economia dei dati sensibili, economia che colonizza il campo degli affetti facendo profitto su di questi; e soprattutto, facendo profitto sul desiderio di riempire i vuoti che un mondo sempre più atomizzato ci consegna. Nel rifiuto della protagonista di un rapporto con la sorella, sostituita dal rapporto con il robot che ricostruisce la personalità del defunto fidanzato, c’è in termini davvero fantasiosi una critica delle relazioni sociali al tempo del web 2.0.
Ma c’è anche la presa di coscienza che il virtuale non potrà mai, per quanto sofisticato, sostituire la bellezza delle relazioni, e di quel loro elemento di imprevedibilità che sfugge alla profilazione e alla costruzione di identità incomplete. Viene in mente, dopo aver visto questo episodio, il testo di “Aurora Sogna” dei Subsonica, quelle carni sintetiche, quei nuovi attributi, quei microchip emozionali che in BM emergono però nella loro tragica manchevolezza.
 E’ in “Ricordati di me” però che queste possibilità vengono riportate all’estremo. La profezia distopica dei chip sottocutanei che permetteranno un nostro continuo controllo prende forma, arrivando a costituire una memoria completa delle nostre azioni: è la realizzazione pratica del controllo sociale totale, ma l’aggravante è che in questo caso è una sorveglianza di tutti su tutti (cosiddetta “sousveillance”), un mondo in cui tramite la registrazione e l’immagazzinamento di tutto ciò che vediamo ogni comportamento può teoricamente essere disvelato. L’entità del controllo, della normalità del controllo, della legittimità del controllo reciproco è testimoniata dal momento in cui il fatto che ci sia qualcuno senza chip è visto con straniamento: la stessa reazione che abbiamo di solito quando qualcuno non ha un profilo Facebook.
E’ in “Ricordati di me” però che queste possibilità vengono riportate all’estremo. La profezia distopica dei chip sottocutanei che permetteranno un nostro continuo controllo prende forma, arrivando a costituire una memoria completa delle nostre azioni: è la realizzazione pratica del controllo sociale totale, ma l’aggravante è che in questo caso è una sorveglianza di tutti su tutti (cosiddetta “sousveillance”), un mondo in cui tramite la registrazione e l’immagazzinamento di tutto ciò che vediamo ogni comportamento può teoricamente essere disvelato. L’entità del controllo, della normalità del controllo, della legittimità del controllo reciproco è testimoniata dal momento in cui il fatto che ci sia qualcuno senza chip è visto con straniamento: la stessa reazione che abbiamo di solito quando qualcuno non ha un profilo Facebook.
Una società in cui tutto è show, e in cui l’atto stesso di filmare molto spesso è più importante ed immediato dell’ipotesi di intervenire di fronte ad una manifesta ingiustizia, come giustamente osservato da Fabio Chiusi nel suo saggio “Black Mirror e la dittatura dell’istantaneo”. Scenario preoccupante per come sviluppato in “Ricordati di me”, ovvero in relazione a un tradimento amoroso o ad un colloquio di lavoro, ma anche all’esposizione di una tragedia a mo’ di reality show di “Orso Bianco”; proprio in questa puntata troviamo uno dei tratti della società mediatica del nostro tempo, ovvero la speculazione sulla cronaca nera, la spettacolarizzazione della tragedia che si accompagna alla ghettizzazione di chi, per aver commesso un qualunque tipo di reato, rischia di trovarsi oltre che condannato colpito da una gogna mediatica.
Una gogna basata sul voyeurismo malato. Che modifica e rigira i fatti in una stortura malata dove i fatti e le motivazioni si perdono nella necessità di fare audience e di trovare capri espiatori e sfogatoi per la rabbia dovuta al peggioramento delle condizioni di vita. Una gogna che però così facendo banalizza, annulla le riflessioni sulle motivazioni e sulle soluzioni per gli accadimenti: è quella che ad esempio vediamo nella sfera politica, ad esempio sul tema della corruzione: basti pensare alla quotidiana indignazione per lo scambio di tangenti tra un costruttore ed un politico, ad una manifestazione di piazza con brutalità poliziesche, e in generale ad ogni azione “scandalosa” potenzialmente registrabile e pubblicabile che non si risolve mai in un processo di attacco reale al fenomeno ma solo in una sua spettacolarizzazione mediatica, che tiene in piedi un’industria dai profitti enormi (basti pensare ai talk show pomeridiani di Barbara d’Urso et similia) sulle spalle dei devianti che vengono criminalizzati e inseriti, a prescindere dalle loro colpe, in un ambiente senza possibilità di redenzione..
La sensazione finale, dopo aver visto tutte e 6 le puntate della serie, è quella di una grande paura, associata ad una punta di nausea, simile a quella che può accompagnare la lettura di uno dei più ovvi riferimenti della serie, “1984” di Orwell (per questo volutamente non toccato finora dalla recensione). E’ difficile avere la forza di credere in un mondo migliore, quando le potenzialità del controllo e dell’interazione tra le forme di sorveglianza sembrano togliere il fiato ad ogni voce di liberazione. Eppure quello che BM non sottolinea è la potenza della cooperazione: la narrazione, realistica, in cui il campo capitalistico ha colonizzato il singolo omette (ed è un’omissione forte) di posare il suo sguardo sulle capacità che hanno avuto forme di cooperazione collettiva di squarciare quel Panopticon e di rifiutare con forza l’atteggiamento tipico dell’individualismo proprietario. E’ forse proprio la possibilità di ripensare il noi a partire da alcuni no, quello che nega BM, per quanto mettendo in maniera perfetta sul piatto molti degli ingredienti della società di oggi; sta a noi però ribaltare il tavolo, senza farci annichilire da un controllo che non sarà mai assoluto.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.