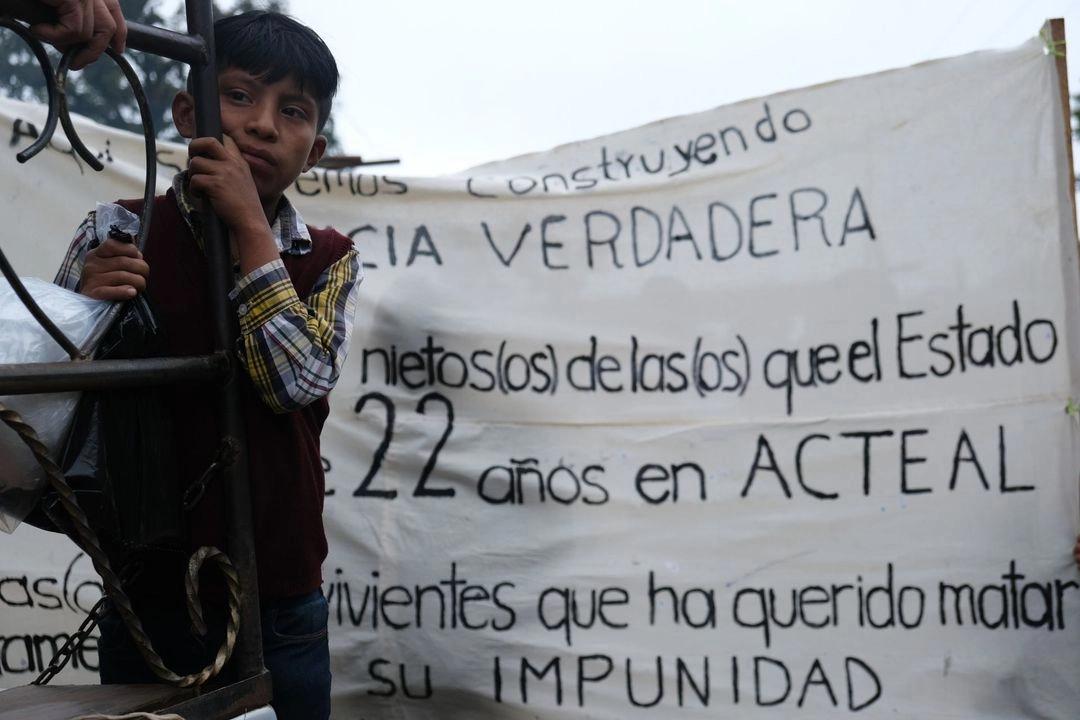Cronache dal terremoto a Città del Messico #CDMX

Corrispondenza di Perez Gallo da Città del Messico
Scrivo a caldo. Perché non riesco a dormire. O forse perché solo così riesco a tenermi nella mente le cose più orribili che ho visto in vita mia.
19 settembre 1985: un terremoto devastante distrugge Città del Messico.
19 settembre 2017: 32 anni esatti dopo, un altro terremoto devastante distrugge Città del Messico. La ricorrenza è stata la prima cosa notata e sottolineata da tutti dopo che per un minuto, o forse un minuto e mezzo, in ogni caso un tempo che ci è sembrato un’eternità, ci ritroviamo in strada, spaesati, confusi, spaventati.
Proprio per la ricorrenza, in mattinata, c’è stata una prova antisismica: dei miei amici che studiavano in biblioteca, all’UNAM, sono stati fatti uscire.
Nemmeno 3 ore dopo, alle 13.15, ci stavo per andare anch’io all’UNAM, mi stavo giusto preparando. Alle 14 avevo un’assemblea degli studenti di posgrado (master e dottorato) in preparazione per la manifestazione per Ayotzinapa del 26 settembre (sì, settembre è un mese funesto per questo paese disgraziato); alle 16.30 era previsto, a scienze politiche, un incontro con Raúl Zibechi…
E invece, d’un tratto, le finestre di camera mia sbattono forte, fortissimo. “Cazzo, ma oggi tutto sto vento non c’è…”. D’improvviso mi precipito fuori, in cortile. Dall’altro lato della casa fanno la stessa cosa i miei coinquilini Hektor e David: “no mames, lo sentiste?”. Schizziamo in strada. Le case della via ondeggiano, si aprono e chiudono a fisarmonica. Tutto il vicinato è in strada. Mando immediatamente un messaggio vocale ai miei, per avvertirli che c’è stato un terremoto, che riceveranno presto la notizia dai giornali, e che sto bene. Un messaggio identico lo avevo mandato la sera del 7 settembre, ma stavolta non si invia, non c’è linea. I cellulari non vanno, non va internet, è saltata l’elettricità, in tutta la città. Una città da 20 milioni e passa di abitanti è totalmente al collasso.
In fondo alla strada, vediamo che dei vicini hanno acceso una radio, l’hanno messa sul cofano, e si sta raggruppando un po’ di gente lì intorno. Andiamo anche noi. Dicono che l’epicentro sia a Puebla, e che la scossa è di 7.1. Merda… Poi viene fuori che l’epicentro è nel Morelos, ma vicino alla frontiera con Puebla: ancora più vicino a noi…
Visto che si sta raggruppando tutto il vicinato, ansioso per i propri cari (un signore ci dice che nel terremoto di 12 giorni fa era morto un suo zio), decidiamo di tornare a casa e preparare un café de olla per tutti, nell’attesa di informazioni. Fino a quando non le avremo, infatti, si può fare ben poco. La linea internet si recupera per alcuni minuti, tempo di mandare qualche messaggio. Poi si perde di nuovo. Nelle varie chat non rispondono all’appello gli amici Bogart e Tonantzin, e qualcuno sta iniziando a pigliarsi male. Poi la connessione si perde di nuovo. Solo molte ore dopo sapremo che stanno bene pure loro. Iniziano ad arrivare informazioni: è crollato un supermercato a Tasqueña e una scuola in Divisiòn del Norte angolo con Calzada de las Brujas. Optiamo per la scuola: recuperiamo 5 litri d’acqua, dei caschi da bici, e delle mascherine, e poi con un compa del barrio ci avviamo tutti assieme in taxi. In strada si va a passo di lumaca, le vie principali sono completamente intasate, e il fatto che i semafori non funzionino per nulla non aiuta. A un certo punto decidiamo che è più comodo a piedi, e ci mettiamo a correre, alternandoci con la tanica d’acqua.
 (nella foto: escuela colegio Enrique Rebsamen, Città del Messico, si riportano 21 bambini morti e 4 adulti, una trentina sono “non localizzati” per cui continuano le ricerche)
(nella foto: escuela colegio Enrique Rebsamen, Città del Messico, si riportano 21 bambini morti e 4 adulti, una trentina sono “non localizzati” per cui continuano le ricerche)
Avvicinandoci si vede come la situazione si fa tesa: los topos, brigate specializzate in questo tipo di aiuti, corrono a perdifiato nelle loro moto, la gente accorre, e corre, da tutte le parti. Una ragazza si mette in mezzo alla strada e urla a tutti di recuperare materiale, qualunque tipo di materiale. Di fianco a noi c’è un ferramenta, vuoto. Gli prendiamo in “prestito” una sega. Chiediamo ai vicini e ci danno una corda. Ricominciamo a correre. Poco a poco dei motociclisti ci danno dei passaggi, e da lì ci perdiamo definitivamente. Nel momento in cui scrivo non ci siamo ancora ribeccati.
All’arrivo sul posto il caos regna. Ci sono già migliaia di persone, e barricate che impediscono di entrare nella via della scuola perché è già congestionato. Non c’è polizia, qualunque istituzione è perfettamente assente. C’è solo il pueblo, tanta gente generosa e di buona volontà. A me e tanti altri che sono rimasti fuori ci tocca recuperare materiale in giro: corriamo un paio di vie di lato, che ci sono le transenne di un cantiere. Vanno giù di volata, manco si stesse facendo un riot. E magari si stesse facendo un riot…
Ad aiutare ci sono tutti, donne uomini vecchi bimbi. Ognuno fa quel che può. Tiro in mezzo due ragazzini un po’ spaesati e andiamo assieme a cercare altro materiale. I vicini in poco tempo ci danno pale, secchi, corde, e così fanno con tante e tanti altri. Lasciamo due spicci alla gente che recupera materiale medico in farmacia e ci catapultiamo sul posto. Ci fanno passare e arriviamo fino all’esterno della scuola, o meglio dell’ala della scuola che è completamene venuta giù. Di mezzo riconoscibile c’è solo l’ultimo piano, il quarto se non ricordo male, che poggia, dal lato in cui sono, su un’automobile distrutta, i piani sotto si sono completamente sgretolati. L’automobile, per di più, ha l’allarme spianato, cosa che ostruisce i tentativi di sentire se qualcuno da dentro sta gridando aiuto. Ci vogliono troppi minuti prima che qualcuno non riesca a spaccare il cofano a picconate tanto da far smettere l’allarme. Inorridisco. Però per un attimo, perché guardandosi intorno si vede che c’è ben poco tempo da perdere per inorridirsi. Mai come questa volta penso che ogni piccolo gesto, ogni secondo, è prezioso. Quello che è difficile, in quel delirio, è capire cosa è utile fare, considerando che tutto ciò che non è utile è d’impiccio. Mi affanno a trasportare cose, cose, cose di qui e di là: acqua, secchielli, picche, pale.
Finisco non so come su un altro lato della scuola, quello che da verso il cortile. C’è una totale congestione tra un paio di ambulanze e un trattore che sta provando a buttare giù il muro del cortile per permettere alle ambulanze di entrare. Mentre il trattore e una dozzina di persone pensa a buttare giù il muro, afferro una pala e con tanti altri spalo come non ci fosse un domani le pietre del muro che crolla, mentre altra gente porta secchi, e poi ne porta ancora ancora ancora. Vengo distratto appena un secondo da una donna che urla disperata, inconsolabile. Qualcuno mi dice che ha un bimbo sotto le macerie. Non ho mai visto tanto dolore atroce sul volto di una persona. Immagino mia madre quando ha visto la sua prima figlia morire nella culla a due mesi. Ma poi l’adrenalina ha il sopravvento e ricomincio a spalare. Carichiamo i pezzi di muro sul trattore e, dopo un tempo che sembra interminabile, mi ritrovo all’interno del cortile. Stavolta l’ala della scuola distrutta la vedo dall’interno.
Anche nel cortile centinaia, forse migliaia di persone. Finalmente il governo pare essersi svegliato, e cominciano ad arrivare in forze la polizia federale e la marina militare. Facendo più danni che altro, in realtà, perché in termini di aiuto concreto fanno ben poco, e le poche cose buone le fanno eseguendo gli ordini di chi si sta facendo il mazzo da ore. Ma il loro ruolo è, come sempre, controllo e ordine, per cui incominciano a incordonarsi per impedire ad altre persone di entrare. A un certo momento vedo un federale correre con un mitra puntato: io e il mio vicino ci guardiamo, e ci domandiamo quale razza di idiota può mettersi a correre con un’arma in quella situazione.
Vedo che quello che più si richiede è di tagliare dei pali di legno in varie misure, per fare delle specie di treppiedi che reggano quel che resta della scuola mentre protezione civile (o qualcosa del cenere) e cani si mettono a cercare nelle macerie. Creiamo una piccola equipe e ci mettiamo a misurare pali e tagliarli con una sega elettrica. Ogni tre per due parte il grido collettivo e un coro di braccia in alto: “silenzio!”. Sono i ripetuti tentativi di sentire le urla da dentro. In quei momenti la sega elettrica deve tacere e ci diamo il cambio con la sega normale. Noto subito come sia impedito in questo genere di cose e lascio l’incombenza ad altri. Ogni tanto si sente un urlo di gioia: vuol dire che è stato salvato un bimbo!
Io incomincio ad avere giramenti di testa: sono stanco, ho mangiato poco, sono teso. Vago qualche minuto nel nulla e poi capisco che in quelle condizioni non servo a nulla, quindi faccio per allontanarmi. Esco dal cortile in direzione delle ambulanze e vengo sommerso dalle grida: “serve insulina! Servono bombole d’ossigeno, bombole d’ossigeno!”. Mi dirigo fuori e incomincio a urlare alla gente di cercare un ospedale, perché solo lì si trovano le bombole d’ossigeno. Qualcuno dice che ce n’è uno a quattro isolati e ci mettiamo a correre. Per strada in tanti si uniscono fino a creare un gruppo di 20-25 persone. Correndo, passiamo davanti a un altro edificio completamente pericolante. Arriviamo finalmente all’ospedale, chiediamo ste benedette bombole e ci fanno fare una trafila estrema: un’infermiera dice a un’altra di portarci al primo soccorso, questa prova a contattare i superiori che non si capisce ma sembrano irreperibili. Nel frattempo altri 20 tra medici e infermieri se ne stanno con le mani in mano e con la faccia da ebete. Una dottoressa particolarmente arrogante ci intima di sederci. Sederci!? Non ci possiamo credere. Dopo dieci minuti buoni, e quando le nostre insistenze arrivano al colmo, spunta fuori un responsabile che ci dice che non ci possono dare bombole perché non ne hanno un numero infinito. Che vogliamo fare, l’ospedale è privato e ci manca solo che regala delle bombole d’ossigeno! Per loro il terremoto, alla fin fine, è profitto. Manca poco e scoppia una rissa. Io minaccio personalmente di denunciarlo se non ci da delle bombole in quel preciso momento. Poi rifletto su quanto ridicola sia la mia minaccia nella capitale mondiale dell’impunità. Per tutta risposta il dottore mi dice che devo essere io responsabile di riportargliele dopo vuote. Un tipo si inalbera e dice: “il responsabile, semmai, è Peña Nieto!”. Dopo un’incazzatura collettiva che la metà basta ci danno finalmente due (DUE!!!!) bombole d’ossigeno e un po’ d’insulina. Insistiamo perché vengano dei pediatri e dobbiamo quasi fare a botte perché lo accettino.
Corriamo come dei pazzi per dare le bombole, e le file di militari incordonati si polverizzano per farci passare. Dico a uno di loro che farebbe bene a mandare una pattuglia in quell’ospedale e a prendergli le bombole con la forza, e lui sembra pure ascoltarmi tutto serio. Quanto mi sento ridicolo…
Stremato, mi metto a cercare da mangiare con due tizi che erano con me all’ospedale, Fabricio e sue figlio Edwin. Non c’è un negozio aperto, niente cibo di strada. Finisce che mi invitano a casa loro, a due isolati dalla scuola, e mi offrono un panino e dell’acqua. Fabricio dice che ha sentito la scossa più forte che nell’85. Sono ormai le sette e mezza ed è da più di cinque ore che sono lì. Sta iniziando a fare buio, e il buio di una città senza elettricità è interrotto solo dalle luci di polizia e ambulanze e dalle centinaia di torce che vengono recuperate da ogni dove, e che diventano rapidamente la necessità più urgente. Ma col buio viene anche il freddo e io sono in canottiera, per cui gentilmente mi regalano una giacca. Mi riavvicino alla scuola: con la giacca in mezzo a tutta quella gente ho un caldo pazzesco, quindi torno fuori, mi metto in strada e comincio insieme ad altri a fermare tutte le macchine che passano, perché vadano a recuperare luci, torce, insulina, dolci calorici. O, se possono passare da un’ospedale migliore, bombole d’ossigeno. In tutte le vie intorno alla scuola siamo migliaia e migliaia: la gente si mette in fila e passa di mano in mano una moltitudine di oggetti di qualunque tipo. A un certo punto corre la notizia che è crollato uno, o forse due edifici, in un viale lì vicino. Con tre ragazzi automuniti decidiamo di muoverci verso di là, che alla scuola c’è un sacco di gente e pare che lì serva più aiuto. Ma nel secondo posto la situazione è ancora più inaccessibile: i federali hanno fatto un gran cordone, una vera e propria barricata, e nessuno si può avvicinare. Ci tocca di nuovo cercare cibo, acqua, luci e materiale medico. Ma è tutto chiuso. Nel frattempo in un rapido momento in cui mi prende internet, ricevo messaggi da decine di persone. Comincio a rispondere ma presto internet finisce di nuovo. E per giunta mi si scarica la batteria. Chiedo a degli sbirri se possono caricarmelo un po’ nella loro macchina e mi viene concesso. Mi raccontano che in città ci sono 38, o forse 41 edifici crollati, e che nella scuola sono morti 10 bimbi e 3 o 4 maestre, ma ci sono ancora parecchi bimbi intrappolati. Il numero, per quel che ho visto, mi sembra basso. Solo ora vedo che le vittime sono 26.
Vado, stremato, alla ricerca di una farmacia. L’unica della zona è completamente illuminata ma chiusa. Ci avviciniamo in 5 o 6 chiedendo di entrare. La farmacista, o la dipendente, o salcazzo cosa, fa spallucce e giochicchia col cellulare. Incominciamo a bussare e sbattere la porta: “non sapete che c’è stato un terremoto!?”, gridiamo tra il comico e il tragico. Si avvicina uno sbirro con il mitra, minaccioso. Ce ne andiamo disgustati: gli ospedali privati vedono il terremoto come un profitto, e lo Stato manda i federali a difendere in armi le farmacie in quella situazione, forse con la paranoia che le assaltino? Dicono che più avanti c’è un supermercato, un Sanborns, il più di lusso del Messico, che ha una farmacia poco munita e dei dolci mediocri carissimi, e ovviamente, per non deludere le attese, fa pagare tutto fino all’ultimo peso. Dopo aver ricaricato ancora un po’ il cellulare nella macchina di un tizio, trovo un’isola in cui va internet, e mi metto a rispondere ai vari messaggi di gente preoccupata per me. Poi porto il mio malloppo di spesa sul posto, prendo un taxi e un paio di passaggi in autostop e arrivo a casa. Noto con piacere che nel mio quartiere l’elettricità è tornata, ma la casa è vuota. David è andato a dormire dalla cugina, Hector e l’altro coinquilino, l’argentino Dardo, sono andati a dare una mano in un altro posto. Indeciso sul raggiungerli, inizio a riscaldarmi il risotto avanzato da ieri e di colpo la luce va via di nuovo. Con il cellulare nuovamente scarico, mangio, mi bevo una birra, e mi sdraio sull’amaca. Sto per addormentarmi che la luce mi riscuote d’improvviso. Apro il pc, rispondo a un po’ di gente e leggo le notizie. E comincio a scrivere queste righe, o meglio queste pagine chilometriche. Nel frattempo Dardo ed Hector tornano, e Hector mi racconta come è andata la sua giornata alla scuola: mi dice che ha tirato fuori una bimba dalle macerie, viva. E che però, quando poco dopo stavano tirando fuori un cadavere vicino a lui, non ha più retto ed è andato a dare una mano da un’altra parte.
Lo sgomento è tanto, e domani non sarà una giornata facile. Tra il 19 settembre 1985 e il 19 settembre 2017 in Messico è stato un susseguirsi, un’escalation, di riforme neoliberiste lacrime e sangue, di assassini di donne perché donne, di aumento della povertà, di furto e devastazione della terra, di sparizioni forzate. Nell’ultimo mese, tra Messico e Caraibi, ci sono stati 5 uragani e due terremoti. “Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”, diceva qualcuno. Domani torniamo a rimboccarci le maniche; e speriamo davvero che da domani cominci un’altra musica.
Tratto da Lamericalatina.net
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.