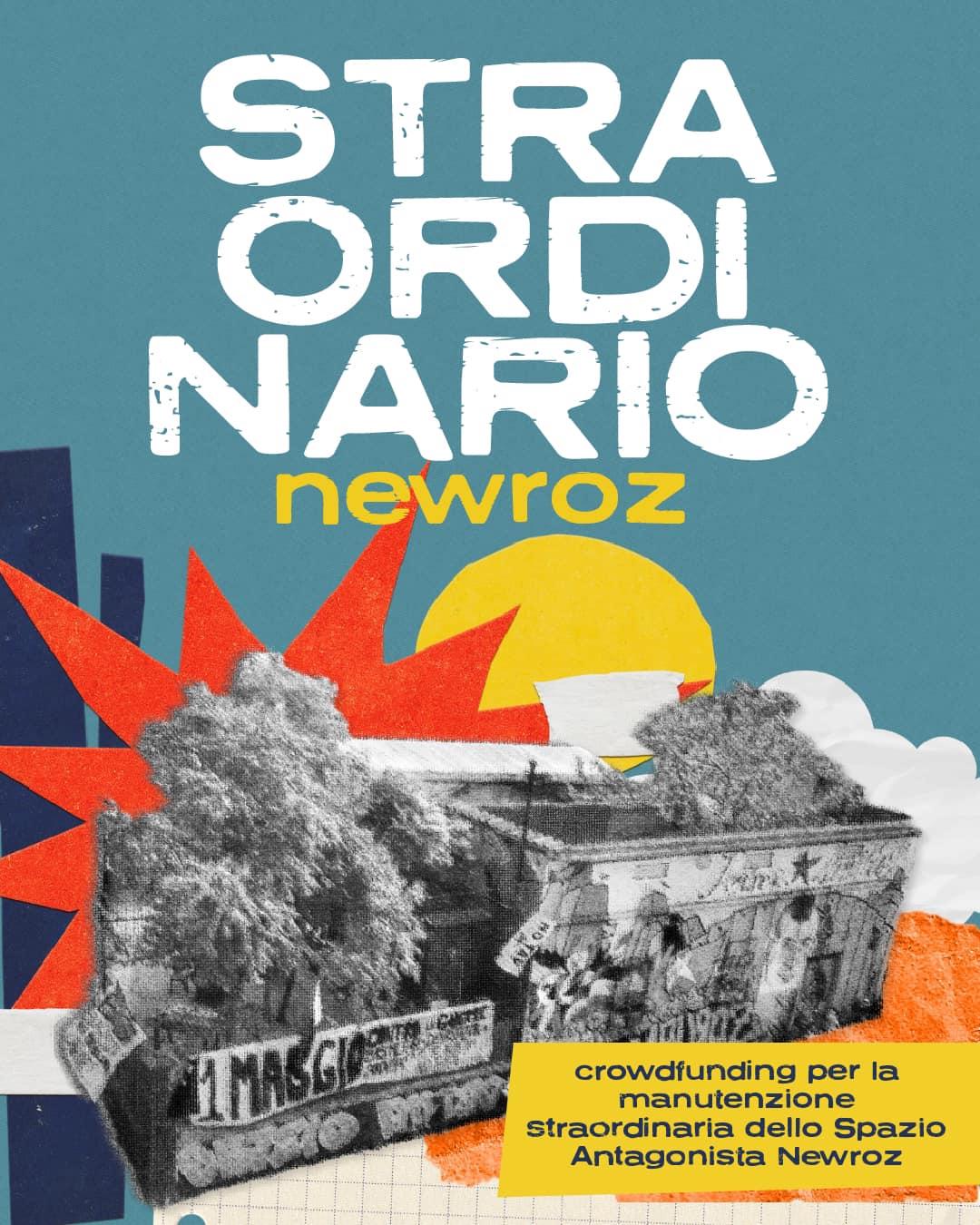Foggia: gli spazi e la comunità
 Volentieri segnaliamo questo reportage che documenta il percorso di inchiesta sociale e riappropriazione operato da una realtà politica di base in un contesto che sbrigativamente potrebbe essere liquidato come ‘provinciale’ o ‘periferico’.
Volentieri segnaliamo questo reportage che documenta il percorso di inchiesta sociale e riappropriazione operato da una realtà politica di base in un contesto che sbrigativamente potrebbe essere liquidato come ‘provinciale’ o ‘periferico’.
Al di là del rinnovato protagonismo espresso da questi ambiti negli ultimi anni, ci preme sottolineare come la cura del sé, degli spazi e della comunità da una parte, e l’inchiesta e le sperimentazioni antagoniste di generalizzazione di comportamenti incompatibili dall’altra, possano rappresentare utili grimaldelli per attaccare piani istituzionali e di rendita locali ormai mummificati ed autoreferenziali.
Un attitudine ben presente anche nell’esperienza di altre “periferie” come quella valsusina – e necessariamente da declinare a seconda delle specificità territoriali per esaltarne il potenziale conflittuale ed innescare forme di organizzazione dentro, contro ed oltre le forme più o meno retrive di dominio capitalista.
La nostra città
Gianni Mongelli, nella vita, fa l’imprenditore edile. È stato anche presidente della Confindustria pugliese. Un po’ perché a sinistra, col vuoto ideologico e la morte dei partiti, il ricorso alle personalità di pregio spacciato per allargamento alla “società civile” è diventato più che un vezzo. E un po’ perché Foggia è la città dove il mattone detta i tempi. Dal Dopoguerra a oggi. Un’emergenza abitativa infinita. La genia dei palazzinari della Dc. Quella del cottimo e del risparmio sui materiali. Quella che ha tirato su il palazzo di viale Giotto. 11 novembre 1999. 67 morti e un monumento griffato. Quella legata alla malavita e alle logge. Quella per cui non si muove foglia. I duemila alloggi popolari dell’epoca Agostinacchio, il rautiano che guidò la città a cavallo del Millennio. I quattromila in cantiere. Le varianti al Piano regolatore. Allorquando si costruivano nuove case invocando il dramma dei senza casa, e si innalzavano interi quartieri di casermoni in un’orgia di deregulation architettonica, con poche aree pubbliche e zero verde. E i senza casa continuavano a rimanere nei loro bassi, nelle loro baracche. Via delle Frasche, quartiere di Borgo Croci. 20 novembre 2004. 8 morti. Il mattone è l’investimento parassita per eccellenza, da queste parti. La lavanderia del denaro mafioso. Chi tocca il business muore. Francesco Marcone, direttore dell’Ufficio del Registro. Tredici anni fa. Leonardo Biagini, consigliere comunale di An. Il primo indagava sulle speculazioni edilizie in aree destinate a verde agricolo, il secondo frequentava alcuni appartenenti alla mafia indigena, dei quali sosteneva la lotta per il diritto ad un’abitazione. Case, con la filiera della tangente e degli appalti pilotati a fungere da collante di specie. Con un valore di mercato inquinato all’inverosimile da affitti e prezzi da far invidia al Testaccio. In questo contesto, nessuno è al sicuro. Nessun cortile storico in centro, nessun rudere d’epoca. I segni del passato vengono lasciati marcire. Fino all’intervento salvifico del palazzinaro. All’abbattimento. Alla costruzione speculativa che però, agli occhi di molti, sembra quasi una riqualificazione d’area. In questo contesto, noi ci muoviamo.
Noi
Noi siamo quelli delle scritte per strada. I vandali per cui la comunità virtuale invoca la forca. O i lavori forzati. Siamo i militanti poco raccomandabili sotto processo per l’assalto a CasaPound. O gli ultras del Foggia calcio. Suona ironico pensare che, nel novero di tanti illustri politicanti dalle giacche azzimate, di giovani sensibili dalla carriera precotta, di esperti impegnati a risolvere i problemi del mondo, proprio da noialtri possa transitare una causa così seria. Eppure è così. Spazi sociali e cura. Siamo partiti dai primi, non v’è alcun dubbio. Del resto, non poteva essere altrimenti. Siamo fratelli minori della gigantesca e mirabile stagione delle occupazioni, dell’autogestione. La Diskarica, la Piscina, l’ex-Cim. Un movimento che, nell’epoca del riflusso, seppe reinventarsi, riappropriandosi dei luoghi, donandogli nuova linfa vitale, alimentando una generazione che si apriva alla lotta nella gestione di un mondo parallelo e complementare. Un lampo lungo un lustro. Come il Punk. I transporter Volkswagen che scendevano giù da Berlino e proseguivano a tentoni lungo una Via Arpi buia e non ancora cartolinizzata, a meno di dieci anni dalla strage del Bacardi. I kilt su Corso Roma, tra gli sguardi divertiti degli anziani che giocavano con le cento lire- La vivacità di una piazza che, gioiosamente periferica alla resa dei Movimenti con la maiuscola, resisteva all’usura del tempo. Dal convegno dell’Autonomia alla Tre giorni anarchica dell’Ex-Cim ci passano quindici anni. Poi, dal 1996 – esclusa l’esperienza di uno squat al Rione Martucci – è rimasto il mito. La Chanson de Geste di un’epoca irripetibile e luminosa. Il ciclo bretone delle narrazioni collettive. E una nuova generazione senza riferimenti. Senza ideologia e senza fratelli maggiori. A Foggia l’attività politica di base – contro tutto e tutti – la creatività di quella che in altri tempi si chiamava lotta sovrastrutturale, la Rivoluzione culturale, è sempre stata legata, dall’ultimo sgombero ai giorni nostri, all’idea romantica del centro sociale. Di quell’unico serpentone che, dal lavoro preparatorio del Comitato servizi del 1989, ha portato al Centro d’igiene mentale. Non a caso, da allora, ciclicamente, la questione dell’occupazione (o, in generale, della riappropriazione degli spazi) ritorna all’ordine del giorno, tanto a corollario di una stasi quanto a coronamento di un fermento. I capannoni di Via Bari, nel lontano 2004, le serate al Cep. I volantinaggi a Sant’Eligio. E, prima ancora, l’impresa avventurosa e suicida dell’Ex-Istituto d’Arte, conclusasi una mattina di dicembre del 2002 con una sfilza di denunce e tanta sfiducia. Fu quello, probabilmente, il momento in cui meglio ci si dedicò all’involontaria ridefinizione delle proprie carte in tavola. All’inventario delle possibilità. Il lasso di tempo, pur bordato di scoramento, in cui si comprese che la volontà, per quanto ferrea, non può sopperire integralmente all’attenzione e al progetto. Che lo slancio è un atto nobile, ma senza lavoro politico o sociale, finisce per risultare addirittura irresponsabile. Non tanto per l’esito in sé, quanto per l’esempio che ne consegue. Ogni occupazione finita con una retata di ribelli è un colpo basso ai ribelli che verranno. A quelli che osservano, che timidamente stanno per farsi avanti. Nel 2008 i sedici giorni del Programmatori sono stati la prova-pilota di quel che intendiamo per riappropriazione. Sedici giorni passati a rimettere in sesto un pianterreno, un cortile, l’aula magna di una struttura abbandonata al suo destino a due passi dal centro e a due dalla periferia. A progettare bar e serate, a vederci ai tavolini d’estate all’aperto, come se dovessimo rimanere lì per sempre. Volantinando porta a porta il quartiere, per spiegare che non siamo angeli del fango in una Firenze alluvionata, ma neppure vandali che godono allo schianto delle vetrate al primo piano. O, peggio, ladri alla ricerca di cavi di rame e suppellettili. La gente ci apriva, si apriva. Parlava con noi dei propri timori, raccontava esperienze dirette, aneddoti. Che avrebbero raccontato anche ad un emissario del Comune, se il Comune avesse inviato un emissario a Viale Di Vittorio. Cosa che, ovviamente, si è guardato bene dal fare. Noi, di nostro, abbiamo provato a scardinare (sulla fiducia) lo stereotipo del centro sociale come Non Luogo della Dissolutezza e del Disimpegno, che in troppi – come sommo pregio o massimo difetto – conservano in fondo all’anima. Il progetto. Una strategia, oseremmo dire. Fatta di impegno e dedizione gratuita. Fatta di coinvolgimento delle realtà, di stimolo e supporto dell’esistente piuttosto che di idealistica creazione di un mondo fatato, di là da venire. E, se pure quell’esperienza s’è chiusa nei meandri drappeggiati di una trattativa a perdere, l’esigenza è divenuta visibile. E s’è fatta istanza.
È servita. A sincronizzare i nostri umori. A sverniciare certe convinzioni consolidate. A misurare i principi con la pratica. A comprendere, tanto per dirne una, che l’epoca eroica dei drappelli duri, puri e autoreferenziali alla conquista di un fortilizio abbandonato, hanno fatto il loro tempo. Naufragando col resto. Che oggi la necessità di conquistarsi uno spazio da popolare di idee e prassi non è in alcun modo disgiungibile dalla valutazione del contesto – lo stato di dormiveglia del movimento, il quartiere, la città che ci circonda con tutte le sue gerarchie di potere e le sue contraddizioni – e dalla difesa attiva del territorio. Il centro sociale come oasi, spazio d’idillio e di menefreghismo compulsivo, da strappare con la forza ad uno spazio-città indifferenziato ed indifferente, da difendere come si difende un’esclusività, un “a parte”, una prerogativa elitaria, è un concetto perdente. Destinato a perdere ancora, nella reiterazione. O a divenire macchietta. Oggi si lavora per sottrarre luoghi all’incuria. E restituirli alla gente, già spossessata di tutto ciò che aveva il sentore del diritto. E del pubblico. In un processo che i marxisti definirebbero “dialettico”, con la gente non più spettatrice passiva d’un fenomeno estraneo, ma parte in causa. Attori, anche quando non protagonisti, di una messinscena che deve farsi collettiva. In quest’ottica non abbiamo ritenuto disdicevole, per i nostri saldi principi antagonisti, presentare una domandina dettagliata per accedere – con tutti i crismi del diritto “borghese” – ad una micro-struttura di Piazza Mercato. Era il 2012. Mese di maggio. Ci siamo proposti per la gestione di un Infopoint turistico. Perché, sul serio, riteniamo la nostra città e la nostra provincia un patrimonio da non delegare. E mal si conciliava la nostra velleità di servire alla sua valorizzazione con la pretesa clandestinità che dobbiamo, per statuto, anteporre al nostro agire. Il Comune ha protocollato la nostra richiesta. E non ci ha degnato di risposta alcuna. Segnando, di fatto, un punto a nostro vantaggio. Eh, già! Perché il segreto è nella cura. Avere cura di una comunità, nel senso più ampio del termine. Proporsi e farsi avanti, come fanno i candidati ad ogni tornata elettorale. Sgomitare per comunicare che si ha tanta, ma tanta voglia di riempirsi di problemi da risolvere. E provare un piacere immenso nel farlo. È bastata una letterina. Dei punti chiari, semplificati, elementari, per smascherare – agli occhi degli illusi – la consistenza reale dei nostri amministratori. Il loro impegno profuso. Le loro promesse baldanzose. Per legittimarci ancor di più. Così, quando due mesi fa, abbiamo lanciato – col più classico degli slogan: Apriamo spazi di libertà! – la battaglia che ci porterà all’ottenimento di un luogo fisico, lo abbiamo fatto forti delle porte chiuse sul muso, dell’anticamera che ci è toccato subire nella trafila degli affari correnti, così come la gente per bene dice che vanno fatti.
Un concetto in espansione
Abbiamo cominciato guardandoci negli occhi. Come sempre, del resto. Consapevoli di dover immergere le mani nella fanghiglia e di doverlo fare, in gran parte e almeno all’inizio, da soli. Col rischio di sfiorare i nervi scoperti degli interessi privati. E degli atti pubblici. Una mappa mentale delle situazioni di degrado. Capannoni dismessi, palestre riconvertite a dormitori e poi sgomberate, archeologia industriale. In ogni luogo siamo entrati. In ogni anfratto abbiamo seminato un sogno. Ma abbiamo cominciato altrove. Dal salotto buono della città, a poche centinaia di metri dal municipio. Da un cortile del Seicento, avvertito come un peso da chi non anela ad altro che al cedimento strutturale. Per allungare le mani e innalzare, al cielo del banale, l’ennesimo palazzone brutto, anonimo, uguale. La copia ennesima di una presunta praticità che annulla la bellezza e il suo valore sociale. In quanto antieconomico. Poi è stata la volta del Teatro Mediterraneo, un anfiteatro figlio dei finanziamenti a pioggia dell’era democristiana, abbandonato – coi suoi tremila posti a sedere e la sua breve storia chiusa negli scatoloni dietro le quinte – alla mercé di ladri improvvisati e saccheggiatori di sfizio. E dell’ex-cinema Garibaldi. Iniziative pubbliche, di sabato mattina. Nel pieno del passeggio. Volantini alla mano, a testare l’interesse della piazza. A riscoprirsi sorpresi. Della mole di storie che la gente è pronta a regalare a chi predispone l’orecchio all’ascolto. Perché questa è la nostra comunità. Non una nostra semplice proiezione o l’alibi per schermare le nostre mire. All’ex-carcere di Sant’Eligio, irrorato di denaro dalla giunta Vendola per farne un ricovero di senza fissa dimora, abbiamo compreso quanto sia inutile leggere la realtà in maniera monodimensionale. Che quel che sembra chiaro e lineare spesso, parlando di collettività, nasconde antitesi e volute. Ne siamo usciti arricchiti, consapevoli, determinati e integrati. Parte di una prospettiva sempre meno ristretta, sempre meno esclusivamente nostra. Perché, ad ogni giro di ruota, il punto di vista altrui diventava parte integrante del nostro. Fino alla due giorni dell’ex-scuola media “De Sanctis”. Lì, in quella cattedrale nel deserto a due passi dallo stadio, ci siamo entrati dopo aver toccato con mano lo scempio. L’incuria, allo stato brado. Dopo aver visto i computer sventrati, le feci umane sui quadri staccati, la storia di un istituto caro alla foggianità sparsa al suolo, o data alle fiamme. Come i libri di un’intera biblioteca. Armati di scope, secchi e buona volontà, abbiamo traslocato il salvabile in aula magna. Mentre attorno la gente, incuriosita, incalzava coi suoi perché. L’arrivo delle volanti, poi dei radi giornalisti, e il giorno successivo degli operai coi lucchetti, della gente della strada, della polizia municipale, e alla fine degli affannati assessori, ha fatto si che la faccenda passasse di bocca in bocca. La cura. Perché la nostra sete di spazi non ci ha impedito di farci portavoce delle maestre e delle famiglie dei bambini che, fino a due anni fa, frequentavano quelle aule, lasciate in balia degli aguzzini dal disinteresse dei politicanti. La cura. Perché non ci siamo rimbecilliti, e neppure abbiamo convertito i nostri istinti in bieco spirito filantropico. In attesa di un riscontro o, peggio, di un rendiconto. La nostra è una battaglia che non abbiamo voglia di combattere da soli. Per quelle c’è sempre tempo. Ci sono gli ambiti. Questa è la vertenza che più somiglia al nostro modo di vedere la vita. Perché si, ci sono le istanze civiche. La pretesa d’essere centrali tra le priorità dell’amministrazione. Noi, come cittadinanza, e non i palazzinari. Ma c’è anche l’essenza del nostro antagonismo. Che non si limita più, da tempo ormai, ai proclami altisonanti di chi, nella fretta dell’estremismo, butta il bambino con l’acqua sporca. Antagonismo, per noi, è attenzione verso la comunità. Difesa, riappropriazione, rilancio della conflittualità. Ed è su questi binari che ci stiamo muovendo.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.