
Custodiamo la Val Sessera: le buone ragioni per dire NO alla diga.
Al vënner i smonto al saba fas festa e vad con la Vespa a Sangon l’è pien ëd gorin-e ‘n pò serie ‘n pò min-e che vëddo sempre a balè ma cosa importa se sai nen noè mi devo cariè e perciò: Sangon Blues
Gipo Farassino “Sangon Blues”

Per affrontare il tema della gestione delle risorse idriche occorre partire dall’impatto sui territori che i progetti di accumulo di acqua possono arrecare, considerando vari aspetti.
Innanzitutto bisogna sottolineare che la vita di un fiume, il suo stato ecologico, la possibilità che il fiume garantisca habitat e servizi ecosistemici ad umani e non umani è assicurata dalla presenza costante e continua di portate liquide, solide, organiche: per salvaguardare la vita di un fiume vanno assicurate la presenza, il trasporto o mobilità di fogliame, legno, microrganismi (fauna bentonica), specie ittiche, sabbia e inerti.
Un secondo aspetto fondamentale nell’approcciarsi al tema della gestione delle risorse idriche, e di conseguenza per valutare un progetto o un’infrastruttura che si colloca in questo ambito, è domandarsi la destinazione d’uso delle acque.
In Unione Europea il 58.3% delle risorse idriche viene utilizzato per l’agricoltura, il 18.2% per uso energetico, il 10.6% per uso industriale, mentre il restante per il terzo settore e per consumo domestico. Per permettere l’uso dell’acqua occorre dunque costruire delle infrastrutture che la trattengano, in modo che si possa accumulare e poi indirizzare. Vi sonodiverse tipologie di sbarramenti, i più famosi sono proprio le dighe (così definite se gli invasi hanno una capienza di oltre 1 milione di metri cubi di volume invasato o sono più alte di 15 metri), vi sono poi, numerosissime, le traverse di derivazione o di stabilizzazione che costituiscono ostacolo e detrimento alla continuità fluviale. Le dighe, in particolare, determinano alterazioni del regime della portata liquida e solida di un fiume e conseguentemente impatti idromorfologici ed ecologici.
I principali impatti riguardano l’habitat fluviale e perifluviale, una minor portata e ricarica della falda a valle, l’incremento dei rischi di instabilità delle infrastrutture antropiche per erosione e abbassamento del letto fluviale, disconnessione delle piane inondabili, la perdita di connettività per molte specie ittiche in quanto i pesci hanno necessità di muoversi, l’aumento delle temperature delle acque (thermopeaking) e variabilità estrema delle portate (hydropeaking). La somma di questi impatti comporta una notevole perdita di biodiversità, fatto assai preoccupante poiché le acque dolci ospitano la maggiore varietà e ricchezza di specie vegetali e faunistiche.
In Italia, secondo la mappatura del progetto AMBER, esistono 532 grandi dighe per una capacità totale di 13.6 miliardi di metri cubi di invaso. A fronte di tale notevole sfruttamento della risorsa idrica occorre ancora aumentare le capacità di invaso (e gli impatti ambientali che questa provoca) od occorre migliorare la gestione della risorsa e delle attività/esigenze idriche? Occorrono nuove dighe o è sempre più necessario commisurare gli usi alla disponibilità? Oltre a ridurre le inefficienze di rete, al recupero dei volumi degli invasi interrati, e alla corretta pianificazione colturale (analisi del reale fabbisogno irriguo, puntando su colture meno idroesigenti) è sempre più necessario ripristinare la naturalità e la connettività fluviale (anche la demolizione di sbarramenti ormai inutili) e di capacità di assorbimento idrico dei terreni, migliorandone il contenuto organico: la ricarica della falda è infatti possibile solo se si opera in tale direzione, favorendo sistemi di “accumulo sostenibile” quali gli allagamenti delle aree di ricarica delle falde.
Purtroppo ad indirizzare la gestione delle risorse non sono la cura e la salvaguardia del patrimonio ecosistemico e la fertilità dei suoli, fondamentale per prospettare un futuro sostenibile, ma le mere esigenze e gli interessi delle categorie produttive coinvolte (principalmente i consorzi irrigui, i produttori di energia idroelettrica, agricoltori, mercato edilizio, ecc.). I progetti avanzati e finanziamenti pubblici disposti in un contesto di shock economy sono nel solco della ormai anacronistica risposta alle esigenze di uso della risorsa idrica: sono progetti vecchi e superati, finalizzati al profitto (acqua a basso costo e rigetto della limitatezza della risorsa) e in deroga alle esigenze di tutela ambientale.
Questo è infatti il caso del progetto di diga che riguarda il torrente Sessera, affluente del Sesia in provincia di Biella, un progetto inutile, costoso e pregno di conseguenze dannose per l’habitat circostante. Nel 2009 nasce il comitato Custodiamo la Val Sessera che si è occupato per tutti questi anni di contrastare il progetto di questa grande diga, considerato dagli abitanti del luogo assolutamente privo di logica su un piano di costi e benefici. Un progetto faraonico e contro l’ambiente, un progetto inutile, per la cui realizzazione il Consorzio per la Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese (CBBBV) non è mai riuscito a trovare i soldi a 10 anni dall’approvazione del progetto in sede di VIA, fatto che imporrebbe la novazione del provvedimento di autorizzazione.
Le criticità sollevate dal comitato Custodiamo la Val Sessera sono invece cristalline!


1. La questione economica.
Il Consorzio proponente ha in passato realizzato altre tre dighe nel biellese (Ostola, Ingagna e Ravasanella), caratterizzate da costi elevati e cresciuti esponenzialmente rispetto ai preventivi iniziali e da scarsi risultati irrigui (invasi con basso turnorver ed efficienza). Un primo campanello d’allarme.
Il CBBBV è un consorzio di bonifica. Tutte le opere proposte e realizzate dai consorzi di bonifica sono opere di proprietà del Demanio, finanziate interamente dallo Stato. I Consorzi di bonifica hanno diritto a contabilizzare a proprio favore dal 13% al 16% delle spese generali sul costo dell’opera, a seconda degli importi dell’opera stessa. Tale meccanismo, molto generoso, ha certamente favorito l’avanzamento di proposte costruttive. A questo si aggiunge la inadempienza dello Stato Italiano nella applicazione dell’articolo 9 della Direttiva Quadro delle Acque che impone a tutti i settori di utilizzo delle acque, irriguo compreso, l’attribuzione in tariffa degli oneri per la copertura dei costi di investimento.
Il CBBBV, proprio per la spiccata missione di soggetto proponente e realizzatore di infrastrutture irrigue, si è strutturato creando una società “in house” per la progettazione ingegneristica, la società STECI Srl. Questa società ha curato altri progetti di invaso quali quello della Serra degli Ulivi, in provincia di Cuneo.
2. L’imposizione dall’alto.
La proposta progettuale è stata avanzata senza rispettare i passaggi previsti nell’allora PTA. Il consorzio ottenne un preliminare finanziamento statale per la redazione del progetto di “fattibilità” ma tale progetto non fu mai preliminarmente sottoposto, come prevedeva il PTA del 2007 all’esame delle amministrazioni territoriali (Comuni ed Unione montana). Queste amministrazioni si erano infatti opposte nel 2004 ad una previsione di nuovo invaso sul Sessera contenuta nel PTA, in subordine alla impossibilità di realizzare un invaso sul torrente Mastallone, in Valsesia.
Il Consorzio, forte anche del finanziamento assicuratogli per la progettazione definitiva dal Ministero delle Politiche agricole (circa 5,5 milioni di euro), depositò in regione un progetto per un invaso di circa 7,1 Mmc, ottenendo l’avvallo del Presidente della Regione in carica, Mercedes Bresso. Nel 2009 presentò invece un progetto in procedura VIA per un invaso di 12,3 Mmc. Nessun coinvolgimento della comunità territoriale locale, le decisioni furono prese altrove. Un ennesimo esempio di totale alienazione dalle esigenze e dalla volontà di coinvolgimento della popolazione.
3. L’impatto ambientale e idromorfologico.
La costruzione di una diga alta quasi 100 mt e la realizzazione di un invaso da 7,1 Mmc (non è stato autorizzato l’invaso a 12,3 Mmc) comporta la sommersione di circa 44 ettari di aree boscate nel SIC/ZPS Valsessera (un Sito di Interesse Comunitario) Valsessera. Altri ettari di foreste verrebbero poi distrutti per i lavori a esso connessi. Da considerare, oltre agli impatti idromorfologici ed ecologici sul torrente Sessera a valle dell’invaso, l’aspetto cantieristico che riguarderebbe non solo la diga in sé ma anche la costruzione di strade di accesso, un teleferica di cantiere, la tombinatura del Sessera a Piancone, una lunghissima condotta forzata (circa trentacinque chilometri, con tratti in galleria e numerosi attraversamenti in alveo) che deve convogliare le portate invasate sul torrente Sessera in altro sottobacino idrico del Sesia, alimentando altri due invasi (Ostola e Ravasanella), alcune centrali elettriche ed infine alimentando la roggia Marchionale. Lavori molto impattanti che deturperanno irrimediabilmente l’ambiente, metterebbero in pericolo l’habitat di specie animali e vegetali rare (in particolare nel SIC) sconvolgendo la vita e le attività degli abitanti a monte e a valle.
A chi giova un tale sconquasso del territorio e di chi lo abita, lo vive, lo attraversa?
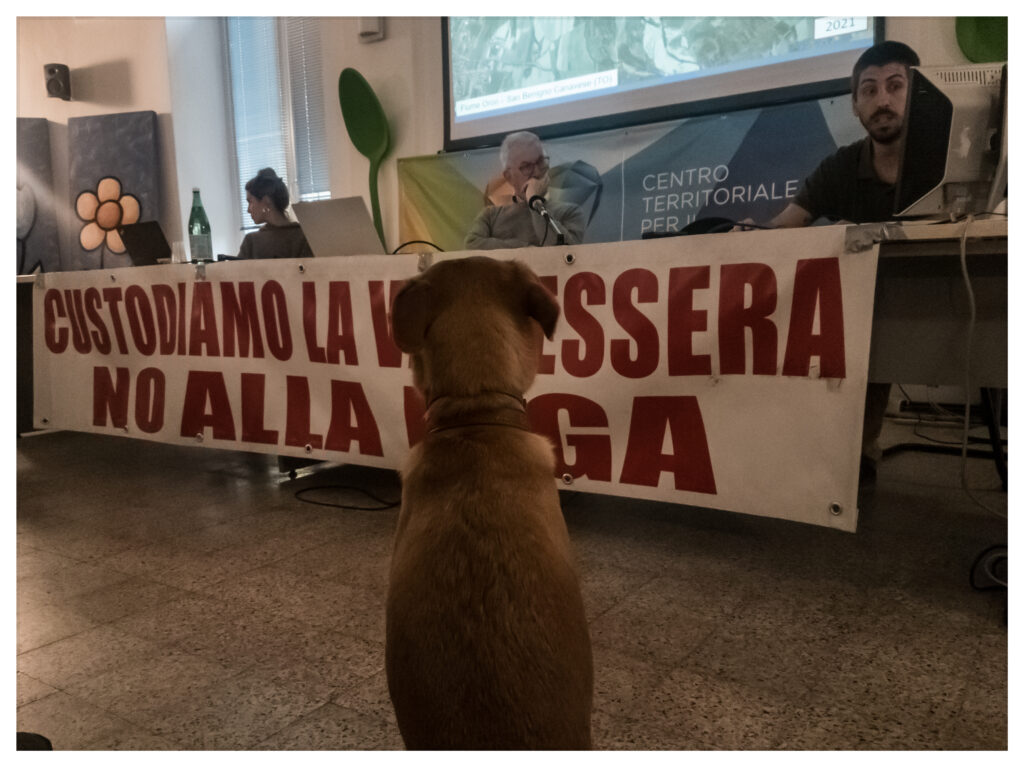
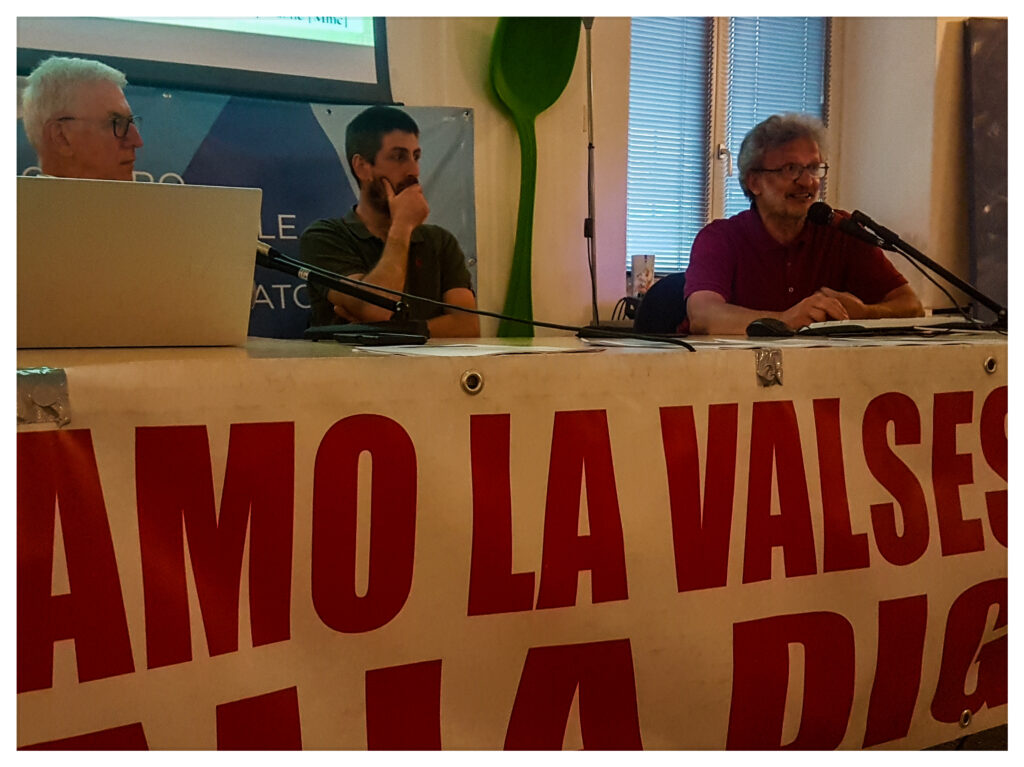
La leva utilizzata per giustificare e legittimare il progetto è l’estrema necessità di acqua dovuta dalla coltura del riso nella piana biellese e vercellese. Una narrazione a senso unico che occorrere approfondire e sfatare con i risultati agronomici degli ultimi 20 anni: la varianza nelle rese agronomiche di tale coltura, a fronte di anni con scarsa piovosità, non sono così severe come per altre colture (cali massimi entro il 10 %) confermando che il quadrante nord Est del Piemonte è l’area meno a rischio e con minori danni per il rischio siccità, con maggiori disponibilità di risorsa idrica. Un investimento oneroso (ad oggi il costo dell’opera con le opere acquedottistiche annesse è stimato intorno ai 500 Milioni di euro) con risultati irrigui scarsi se non irrilevanti su un fabbisogno stimato di 488 Mmc: 18-22 Mmc nella stagione irrigua con normale piovosità, 10-12 Mmc nella stagione irrigua con scarsa piovosità.
Eppure, sulla base di questa alterata narrazione e presupposti, si cercano di imporre scelte contraddittorie che rischiano di mettere a rischio la possibilità di coltivare e di produrre alimenti garantendo, allo stesso tempo, la tutela del patrimonio naturale.
In questo falso bivio, nell’inversione dell’ordine dei fattori e delle priorità, non si tiene infatti conto che è principalmente la salvaguardia della naturalità del reticolo fluviale e delle acque profonde a garantire resilienza e la futura disponibilità della risorsa, non le infrastrutture di accumulo e distribuzione. Senza una seria presa di responsabilità nella gestione delle risorse (poche) si rischia di ridurre progressivamente e drasticamente le possibilità stesse di futura riproduzione, come la storia dell’umanità già testimonia (la fertile ed irrigata pianura tra il tigri e l’Eufrate, diventata area desertica dopo l’eccesivo sfruttamento, ne è un esempio). Non sono solo i cambiamenti climatici a doverci preoccupare ma l’intensità nello sfruttamento delle risorse: in gioco è la produzione agricola e, in prospettiva, la vivibilità dei luoghi.
Pur considerando che il climate change in atto già influisce e influirà sulle colture e sul settore agricolo in generale, possiamo fare alcune considerazioni in merito alla produzione di riso in Piemonte, tenendo conto che nella seconda metà del ‘900 sono raddoppiate le estensioni delle superfici irrigate e triplicati i consumi idrici. In primis, le superfici di coltivazione in regione hanno ormai raggiunto la loro massima estensione e il settore risicolo nel prossimo futuro dovrà fronteggiare una riduzione dovuta a perdite di quote di mercato (concorrenza globale), variazioni delle disposizioni comunitarie (PAC), consumo di suolo per infrastrutture, ragioni ambientali. Inoltre, le oscillazioni della superficie coltivata a riso degli ultimi anni sono sostanzialmente dettate dalle previsioni del prezzo di collocamento del risone e non dalla disponibilità idrica (notevole è il rischio di prodotto invenduto, comunque acquisito dallo Stato per le emergenza alimentari a prezzo convenuto). Ovvero: le risorse idriche a disposizione per la coltura del riso sono ad oggi sostanzialmente sufficienti, dunque non si spiega perché dare la priorità a quest’opera anziché finanziare interventi in aree a maggior rischio desertificazione.
E’ pertanto evidente che a dettare molte scelte infrastrutturali, nel caso di specie quelle idriche, siano gli interessi di settore (agricolo, energetico, costruttivo) e il profitto quale unico orizzonte. Scelte condotte con spregio alle legittime istanze di tutela del territorio avanzate da chi abita i territori montani.
Siamo inoltre di fronte ad una anacronistica contrapposizione tra natura e fabbisogno umano, una idroesigenza senza limiti e in concreto indotta da chi ha interesse a realizzare progetti come la diga in Valsessera. Opera dall’ingiustificato rapporto tra costi e benefici economici ed ambientali, priva di alcuna ricaduta concreta per la popolazione interessata a cui non è mai stato consentito di potersi esprimere con un parere vincolante ancorché gli impatti della realizzazione dell’invaso e del trasferimento delle portate del Sessera in altro bacino deturperanno l’habitat e la morfologia di questo affluente del Sesia, condizionando – sia per gli umani che per i non umani – le presenze, le vite e le attività in valle.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.
acquacomitati territorialiECOLOGIAECOLOGIA POLITICAno digano grandi operePNRRval sessera










