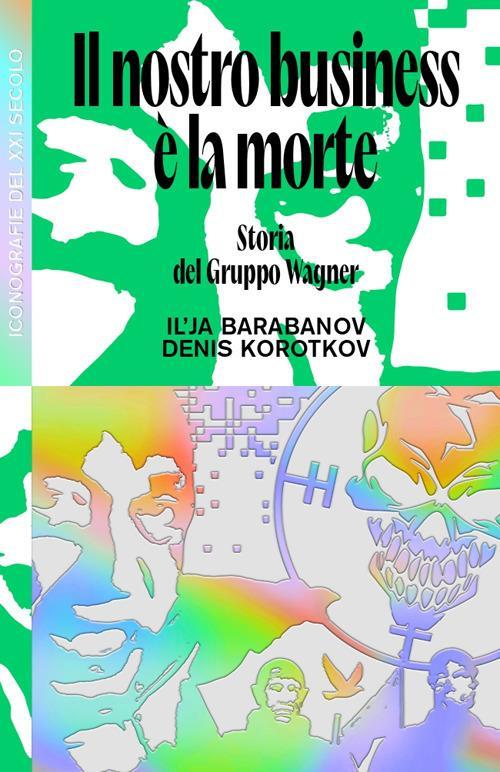La bianca scienza. Spunti per affrontare l’eredità coloniale della scienza
E’ uscito da qualche mese La bianca scienza. Spunti per affrontare l’eredità coloniale della scienza, di Marco Boscolo (Eris Edizioni). Ne proponiamo un estratto da Le Parole e le Cose.
di Marco Boscolo
Botanica coloniale
Durante il periodo coloniale la botanica era in tutto e per tutto “big Science”, come lo sarebbero state molto dopo la fisica delle particelle o la corsa allo spazio durante la Guerra Fredda. Le prospezioni botaniche delle potenze europee tra il XVII e il XIX secolo sono un’impresa scientifica dagli altissimi budget che coinvolge alcuni degli intellettuali più importanti del periodo e ha come palcoscenico il globo nella sua interezza. Il perché di tanto sforzo è perché a “big Science”, oggi come allora, tende a corrispondere “big business”. C’è il più antico traffico di spezie, beni di lusso che da secoli generano profitti stellari per quei mercanti, come per esempio i veneziani e i genovesi, che riescono a portare dall’Asia in Europa la noce moscata, il pepe, la cannella e altre piante che finiscono sulle tavole dei più ricchi. A queste merci se ne affiancano altre che arrivano, dopo i viaggi di Cristoforo Colombo, dal cosiddetto “Nuovo Mondo” e che trovano soprattutto nella popolazione urbana europea una clientela disposta a pagare profumatamente.
Al centro di questa rete di rapporti tra scienza, politica e commercio c’è un’istituzione fondamentale per la scienza coloniale: il giardino botanico. Orti votati alla raccolta, alla conservazione e allo studio delle diverse varietà di piante esistevano già. In Italia, per esempio, ce ne sono due che si contendono il titolo di più antico d’Europa e probabilmente del mondo: quello di Pisa fondato nel 1543 e quello di Padova fondato nel 1545. Entrambi sono nati all’ombra delle due importanti università cittadine come strumento di ricerca e di didattica. In un periodo in cui le piante sono praticamente l’unica fonte di rimedi contro le malattie, gli orti rinascimentali servono sia da riserva di piante da cui trarre medicamenti, sia da strumento per insegnare ai futuri farmacisti a riconoscere quali utilizzare. Questi orti hanno dunque un ruolo di grandissima rilevanza sociale, ma anche economica. Lo testimonia il fatto, per esempio, che dopo la sua fondazione l’orto padovano viene murato per scongiurare i furti: le piante possono essere molto preziose.
Nella storia del colonialismo europeo uno scarto decisivo avviene nel XVIII secolo e sottolinea proprio il valore economico crescente che le piante acquistano nella cultura e nella società dell’epoca. La più grande potenza della prima fase del colonialismo è la Spagna, proprio il paese che ha finanziato i viaggi di Colombo e ha, prima tra le potenze europee, sfruttato le risorse naturali delle Americhe. Ma per praticamente due secoli, ha preferito sfruttare economicamente più che altro i metalli preziosi: sono l’oro e l’argento delle miniere che finanziano lo splendore in patria del Siglo de Oro, il Seicento, cioè quel secolo in cui la ricchezza e lo sfarzo culturale della Spagna sono probabilmente al proprio apice. Dall’inizio del XVIII secolo, l’interesse economico della Spagna nei confronti dei territori oltre l’Atlantico muta e segue la tendenza che le altre potenze coloniali europee – Inghilterra, Francia e Paesi Bassi – stanno seguendo; una tendenza che si potrebbe riassumere dicendo che da quel momento fino alla fine dell’era coloniale il vero oro è quello verde delle piante.
Rispetto alla prima fase coloniale, in questa fase si rinnova il ruolo dei giardini botanici, che acquisiscono un’importanza crescente. Per i sovrani delle potenze imperiali, i giardini reali sono uno sfoggio di potere e lustro: maggiore è la varietà delle piante esotiche che vi sono coltivate, più la corona potrà mostrare la propria potenza. E oltre a questa funzione politica importantissima, ovviamente, i giardini continuano a svolgere il proprio ruolo di catalogo della conoscenza botanica, ma su una scala completamente nuova. Ora è fondamentale che i giardini possano diventare centri di aumento della ricchezza botanica estratta dalle colonie attraverso un lavoro di studio delle singole piante che possono dare un profitto, la moltiplicazione degli esemplari per la costituzione di vere e proprie piantagioni e lo sviluppo dei migliori incroci e delle migliori varietà per massimizzare gli investimenti.
La centralità di questo ruolo affidato ai giardini botanici è testimoniata dal loro censimento alla fine del XVIII secolo, quando cioè la macchina coloniale si sta preparando a inserire le marce più alte. In questo momento i giardini botanici europei sono oltre 160. Ci sono quelli delle capitali, come il Jardin du Roi di Parigi o i Royal Botanic Gardens di Kew a Londra, ma ci sono anche le decine di giardini “di servizio” che Francia, Inghilterra e altri paesi mantengono nei territori che controllano lontano dai centri di potere. Nel 1804 Thomas Dancer, botanico alle dipendenze della corona inglese in Giamaica, dà un’idea di quello che stiamo raccontando in un breve trattato: “la necessità di un giardino botanico per la promozione della conoscenza delle piante in generale, per l’introduzione e la coltivazione di quelle esotiche che sono rare, curiose o utili, sia per la medicina che per le arti, è nell’epoca attuale così universalmente noto che sono fortemente voluti in una qualunque parte del mondo civilizzato”.
La storiografia su questi argomenti è vastissima e interi libri sono stati scritti sui singoli giardini botanici o su singole specie vegetali. Qui, per provare a mostrare quanto la botanica – e per estensione la scienza tutta – sia intimamente legata agli imperi e alle loro potenze economiche, raccontiamo una storia emblematica di una pianta che ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo della forza imperiale inglese.
La corteccia peruviana
Secondo la leggenda, nel 1639 la moglie del viceré spagnolo del Perù, Ana de Osorio, viene guarita da una febbre malarica con un rimedio ricavato dalla corteccia di una pianta che cresce sulle Ande. Il fatto viene visto quasi come un miracolo in un contesto in cui le popolazioni europee non conoscevano una medicina efficace contro la malaria. Sarebbe stata la sua guarigione a mettere in moto la prima importazione in Europa della pianta, la Cinchona, che deve il nome a Chinchón, la città spagnola nei pressi di Madrid di cui Ana de Osorio è la contessa.
Oggi sappiamo che il genere Cinchona comprende circa venticinque diverse specie che sono originarie delle foreste degli attuali Perù, Colombia, Ecuador e Bolivia e che in natura crescono tra gli 800 e i 3400 metri di altitudine. Le popolazioni indigene conoscono queste piante da prima dell’arrivo degli europei e della creazione del vicereame del Perù sotto il controllo della Spagna. Tutte le parti di questi alberi contengono delle sostanze chiamate alcaloidi, una delle quali è il chinino, che sono efficaci contro le febbri malariche. È però la corteccia la parte che ne contiene la maggiore concentrazione e quindi diventa il prodotto più pregiato e ambito. Sono gli stessi europei, che per vari motivi arrivano in Perù e negli altri vicereami andini, a notare che nelle comunità locali la corteccia di questi alberi viene impiegata per preparare rimedi contro diversi tipi di febbri e anche per alleviare i sintomi della sifilide. Ma, da quanto ha potuto ricostruire Lucile H. Brockway (una delle prime ricercatrici a studiare il ruolo della botanica nel contesto coloniale), si tratta di notizie che vengono accuratamente nascoste agli europei. Lo si legge chiaro e tondo in un trattato del 1663 pubblicato a Ginevra e intitolato Anastasis Corticis Peruviae e che fa il punto sulle conoscenze riguardo alla “corteccia peruviana”. Siamo poco più di una ventina di anni dopo l’episodio della prodigiosa guarigione della contessa di Chinchón e dell’inizio dell’importazione in Europa. L’autore, un certo Sebastian Bado, non ha nessun problema a riconoscere che gli “indiani”, come definisce le popolazioni andine che conoscevano il chinino, avevano una conoscenza delle piante medicinali molto più profonda e sviluppata degli europei. In particolare, sapevano preparare un infuso di corteccia che guariva dalle febbri malariche, mentre i colonizzatori non avevano idea di come curarle.
La sincera ammirazione per le conoscenze botaniche delle popolazioni indigene nel primo periodo dell’esperienza coloniale non si limita al caso della Cinchona. Diversi storici, sia europei sia sudamericani hanno infatti documentato come i filosofi naturali, i botanici e gli esploratori del XVI e XVII secolo non esitano a riconoscere l’estensione e la varietà dei saperi indigeni in fatto di botanica. È un atteggiamento che nel corso dei secoli cambierà completamente, fino alla negazione di qualsiasi intelligenza o conoscenza nei confronti di popolazioni che agli occhi dei colonizzatori perdono di dignità, intelligenza e perfino di umanità.
Per tutto il Seicento e il Settecento, la corteccia peruviana arriva in Europa dall’America meridionale, alimentando un mercato disposto a pagarla profumatamente. Per esempio, pagano cifre importanti per assicurarsi scorte del rimedio gli stessi Stati colonizzatori, che vedono progressivamente nel chinino un elemento fondamentale per proseguire la propria operazione di colonizzazione di territori, come quelli tropicali, dove la malaria è una malattia endemica. La stessa Brockway sottolinea come il chinino sia stato un fattore determinante per l’espansione degli imperi coloniali in Africa: “sembra più che una coincidenza che l’Africa Occidentale sia stata penetrata da un significativo numero di europei solo dopo la costituzione dell’industria del chinino”. Un’industria che si sviluppa e afferma nel XIX secolo e passa proprio dai Reali Giardini Botanici di Londra.
Una finta crisi
Nella seconda metà del Settecento comincia a girare la voce che la pianta da cui si ricava la corteccia peruviana sia in pericolo e debba essere salvata. La causa principale di questa crisi è, secondo le potenze europee, da ricercarsi nelle tecniche arretrate con cui viene prodotta in America meridionale. Alcuni storici, invece, sostengono che non ci fosse nessun pericolo imminente per la pianta, ma che la presunta crisi sia stata creata ad arte per giustificare il progetto britannico. La Cinchona infatti non viene propriamente coltivata, ma le sue piante vengono semplicemente abbattute e scortecciate sul posto, secondo la tecnica impiegata dalle popolazioni indigene. Nel frattempo, la ricerca botanica e farmacologica ha messo a punto il corretto dosaggio del rimedio e il chinino, all’inizio del XIX secolo, conosce una enorme popolarità.
In questo contesto, il governo inglese decide di entrare pesantemente nel mercato, costituendo una propria piantagione industriale di Cinchona in una delle sue colonie. Il luogo scelto è il subcontinente indiano, entrato da poco a far parte dei possedimenti della corona e ritenuto ideale dal punto di vista climatico per piantare l’albero del chinino. Bisogna, però, procurarsi i semi o le piante.
La nascita delle piantagioni asiatiche
Nel 1859 il progetto prende ufficialmente il via, sotto la guida di Clements Markham, un dipendente degli uffici governativi in India che conosceva la zona da esplorare per viaggi precedenti e sa riconoscere a vista tre delle specie di Cinchona, oltre a parlare spagnolo e quechua. Markham viene quindi incaricato e spesato dal segretario di stato dell’India e affiancato da Richard Spruce, un botanico che in quel momento stava già raccogliendo campioni nella zona andina dell’Ecuador, e Robert Cross un giardiniere dei Kew Gardens.
Giunti in Sudamerica, Markham approfitta di una situazione politica in grande fermento. L’Ecuador è un paese indipendente dall’inizio del secolo, ma solo nel 1840 la Spagna lo riconosce ufficialmente. In questa situazione, Markham si accorda con la Chiesa cattolica, proprietaria di grandi appezzamenti di terra, e l’ex presidente dell’Ecuador Juan José Flores (venezuelano di nascita) per i diritti di prospezione botanica in una zona della Cordigliera vicino a Quito. Sono quindi Spruce e Cross a condurre in concreto la raccolta che dura da giugno a settembre di quell’anno.
Qui bisogna mettere un momento in pausa la storia di Markham, Spruce e Cross per contestualizzare la loro impresa e comprendere perché si tratti di una sfida tutt’altro che semplice. In generale, trapiantare un albero non è mai particolarmente semplice. Qui, l’obiettivo era raccoglierne una serie di esemplari giovani dal loro habitat a qualche migliaio di metri di altitudine. Le piante dovevano quindi essere trasportate fino al mare per essere imbarcate in un viaggio di qualche mese verso l’Inghilterra, dove avrebbero dovuto essere valutate, moltiplicate e spedite in India grazie a un altro lungo viaggio per mare. In India avrebbero dovuto essere piantate dopo lo stress di tutto questo sballottamento in un terreno diverso e con un clima simile (ma non identico) a quello delle Ande, per realizzare una piantagione industriale. Si tratta di una storia che ricalca quelle di tutte le specie botaniche che hanno subito lo stesso destino, dalla canna da zucchero alla noce moscata e alle altre specie tropicali diventate colture da reddito per le potenze imperiali. In queste storie, i giardini botanici giocano un ruolo fondamentale: sono gli scienziati e gli esploratori che vi fanno capo che hanno studiato il clima e il terreno del luogo di origine e quello di destinazione, valutando se si tratta di due ambienti compatibili. Inoltre, i botanici hanno studiato le caratteristiche della pianta per capire come si comporta e quali sono le condizioni di coltivazione ideali per ottenere il massimo in termini di produttività e, quindi, di reddito.
Infine, un’invenzione tecnica recente ha permesso con più facilità di trasportare esemplari non troppo grandi di piante tropicali. Si tratta della cassa di Ward (wardian case in inglese): una specie di terrarium di legno e vetro che funzionava come una piccola serra portatile. Oltre a permettere il passaggio della luce solare e mantenere il calore, essendo chiusa non faceva disperdere l’umidità delle piante, garantendo una maggiore probabilità di sopravvivenza degli esemplari. A inventare queste casse è stato un medico di Londra, Nathaniel Bagshaw Ward, appassionato di botanica, negli anni Venti del XIX secolo. La loro adozione da parte dei Royal Botanic Gardens ha permesso di importare in soli quindici anni sei volte la quantità di piante importate nel secolo precedente. Insomma, la scienza e la tecnica sviluppate nei giardini botanici sono completamente messe al servizio del progetto coloniale di trapiantare l’albero del chinino.
Tra le difficoltà di trasportare le casse di Ward dalle Ande al mare attraversando territori pattugliati da bande armate e popolazioni locali non necessariamente benevole, il 31 dicembre del 1860 Spruce e Cross lasciano l’America meridionale avendo imbarcato 637 giovani piante di Cinchona oltre a 100mila semi essiccati. Tre mesi dopo, 463 esemplari giungono a Nilgiri Hills, il sito a oltre 500 chilometri a sudovest di Madras che è stato individuato: l’industria britannica del chinino sta per cominciare la propria produzione.
Nei primi tre anni di avvio della piantagione, sotto la supervisione dei giardinieri di Kew, a Nilgiri Hills vengono piantate 250 mila piante. Il progetto sta funzionando così bene che nel 1870 viene aperta una nuova piantagione disboscando parte delle foreste. Nel 1891, secondo i rapporti degli uffici inglesi di Madras, a Nilgiri Hills si trovano quasi due milioni di piante di Cinchona e nel frattempo altre piantagioni sono state avviate anche in altre colonie britanniche: Ceylon (l’attuale Sri Lanka) e Bengala.
Nel giro di qualche decennio, l’Inghilterra è riuscita ad addomesticare una pianta selvatica nativa dell’America meridionale, costituire le piantagioni praticamente dall’altra parte del pianeta e diventare il leader mondiale del mercato del chinino. Sul piano botanico, scientifico e imprenditoriale un successo clamoroso. Certo, avvenuto sempre sfruttando manodopera a bassissimo costo (la schiavitù nell’Impero britannico è abolita ufficialmente nel 1833) e con un enorme impatto sulla storia coloniale dell’Africa Occidentale a cui abbiamo accennato. Sono argomenti che meriterebbero altra trattazione e adeguato spazio. Quello, però, che ci preme sottolineare qui è che la conquista di un bene naturale come il chinino, avvenuta grazie a uno sforzo scientifico non meno importante di quello militare e politico, ha corrisposto al miglioramento delle condizioni di solo una minoranza dell’umanità, gli europei, che si sono arricchiti ulteriormente senza mai nessun riconoscimento alle culture andine che avevano per prime individuato il rimedio per le febbri malariche.
L’appropriazione della risorsa naturale, inoltre, racchiude in sé anche un ulteriore elemento di disuguaglianza. Le evidenze storiche, ormai numerose, mostrano che il chinino prodotto nelle piantagioni asiatiche controllate dai britannici non arrivava che in minima parte alle popolazioni locali, seppure spesso si trovassero a lavorare in aree dove la malaria era endemica. La cura per la malaria veniva destinata primariamente ai mercati più ricchi e alle scorte dell’esercito, generando una situazione in cui i magazzini delle piantagioni si riempivano del rimedio per una malattia a cui gli stessi lavoratori delle piantagioni non avevano accesso.
[Immagine: Chinchona].
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.