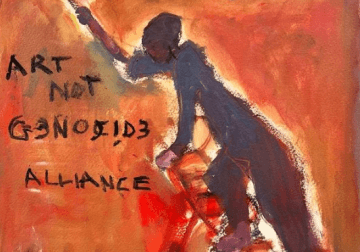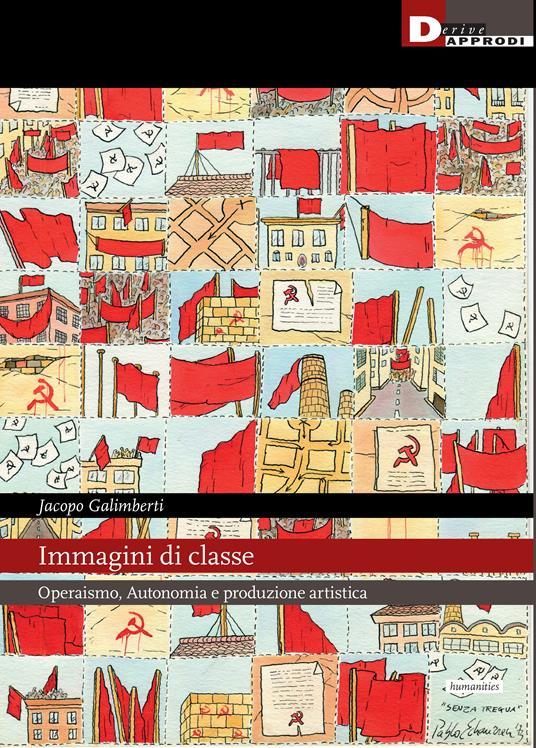L’arte alle spalle, la bellezza di fronte?

Critici d’arte se ne trovano ad ogni angolo, mentre di una critica dell’arte c’è sempre bisogno. Per questo vale la pena prendere tra le mani l’opera di Arthur C. Danto, professore emerito alla Columbia University, scomparso lo scorso 25 ottobre, e seguire i fili di un’impresa speculativa che lo ha portato, dopo esser stato un giovane studioso di filosofia della storia, poi di Nietzsche, ad affrontare alcuni tra i temi più complessi della cultura contemporanea: arte, essere, linguaggio, esperienza estetica, forma e stile. Si mettano il cuore in pace quelli che già pregustano l’opera postuma dell’ennesimo elucubratore oscuro, che affoga in un linguaggio più raffazzonato che esoterico il vuoto di idee che generazioni di accademici sanno lasciare come testimone. Nelle opere di questo professore scorre al contrario una scrittura piana e ordinata, che non cede alla tentazione di intorbidare le acque per lasciar immaginare un’insondabile, quindi ipotetica, profondità; nel caso di Danto è valso davvero ciò che scrisse Zarathustra: la profondità, se è tale, non può e non deve temere la limpidezza della superficie.
Sarà anche per questo che il dilemma della spiegazione di cosa sia ciò che chiamiamo “arte” prende le mosse, nel suo percorso, dal personaggio che amò definirsi, in un’occasione, “profondamente superficiale”: Andy Warhol. Di fronte all’opera Brillo Box (una riproduzione pressoché identica di scatole che, nei supermercati, contenevano pagliette) Danto si chiese: perché questo oggetto è un’opera, mentre l’analogo, sullo scaffale del grocery, non lo è? Apparentemente, tutto ciò che cambia è la posizione che occupa l’oggetto nello spazio fisico e sociale: un supermercato in un caso, una galleria d’arte nell’altro. La reazione popolare a questi fenomeni non di rado è ed è stata quella esemplificata a suo tempo da Theodor Roosvelt, che di fronte alle opere esposte all’Armory Show del 1913 (tra cui non mancavano espressioni cubiste, futuriste o fauve) esclamò: “Questa non è arte!”. Che si tratti del 1913 o del 1964, anno dell’esposizione dei Brillo Box (o del 2013, anno in cui non si fatica a trovare chi sia pronto a negare che le opere di Damien Hirst siano oggetti d’arte), la reazione che voglia rifiutare lo status di opera a un oggetto non può eliminare il problema: che si voglia o meno concederlo, un simile status possiede un’esistenza sociale. Di che cosa si tratta?
Nell’articolo del ‘64, The Artworld, Danto mise in evidenza l’indiscernibilità estetica tra il readymade e l’oggetto con cui esso viene a identificarsi: non esiste una proprietà estetica (ossia qualcosa che sia possibile sentire, vedere, odorare, toccare) che distingua la Fontana di Duchamp da un qualsiasi orinatoio, o il Brillo Box di Warhol da un qualsiasi Brillo Box. Lo status di opera che viene riconosciuto a questi oggetti, una volta esposti, non ha nulla a che fare con il loro rapporto con i sensi: è un concetto/etichetta che viene loro applicato o, se si preferisce, sotto il quale sono sussunti. La nascita di un’opera è frutto di una catalogazione intellettuale, di un battesimo sociale, nel corso dei quali – in forme, modi e con giustificazioni che possono variare enormemente – una serie di individui riconosce a un oggetto questo status. Non si trattava di sostenere, come Warhol, che tutto è arte; semmai, che tutto o quasi può diventare arte, giacché questo status non dipende dall’oggetto (sia esso bello o brutto, stimolante o stupido, realizzato secondo questa o quella tecnica) ma da considerazioni puramente teoriche, che mutano rapidamente e lasciano ogni volta spazio al nuovo.
A causa di questa idea, Danto è stato spesso confuso con i sostenitori delle teorie sociali dell’arte (che nel linguaggio accademico, per ragioni di puro gergo, sono dette “istituzionali”); in verità, la precisazione della sua teoria (La trasfigurazione del banale, 1981) si ferma al di qua del promettente sentiero aperto in questa direzione, tra gli anni Settanta e Ottanta, da un altro professore statunitense, George Dickie, ancora oggi pressoché sconosciuto in Europa. Per Danto il consenso sociale attorno al battesimo di un oggetto come opera, anche quando limitato, non è la spiegazione, semmai ciò che deve essere spiegato; e volle cercare la soluzione nella sfera del cognitivo, definendo opera l’artefatto in grado di restituire al mondo un punto di vista, quello dell’artista. Definizione di dubbia forza, per ragioni su cui qui non c’è spazio di insistere; ma ciò che è importante è che questa impostazione ha presentato in modo nuovo il problema del rapporto tra arte e realtà, con un debito profondissimo verso gli stimoli del neo-dada e della pop art. L’arte non appare indebolimento (magari alla seconda potenza) del reale, come nelle diverse concezioni che possono richiamare l’antica condanna platonica; né ne costituisce un potenziamento sul piano della dignità, come nelle pretese di ogni estetismo o romanticismo, ivi compreso quello ermeneutico proposto da Heidegger e sviluppato da Gadamer.
L’insieme delle opere è, piuttosto, una parte del tutto ordinaria del reale, sebbene caratterizzata da una specifica concentrazione di attenzione semantica, da parte dei creatori come dei fruitori. L’“è” che compare nella frase di battesimo “Questa scatola (o questo orinatorio) è un’opera” produce certo una regione specifica dell’essere, ove tutto è sociale e nella fattispecie artistico, ma non introduce una gerarchia assiale tra questa parte del reale e le molte, forse infinite altre. Molto più attento, rispetto a numerosi suoi contemporanei, ad evitare il rischio filosofico per eccellenza, quello dell’antropocentrismo, Danto compone con equilibrio ammirevole, e in modo ampiamente credibile, anche il rapporto di necessaria coesistenza tra singolarità individuale e mediazione sociale nello spazio della creazione artistica. Lo stile è analogo all’azione dello stilus, oggetto appuntito per tracciare segni, da cui prende il nome (si pensi alle penne dette stilografiche), soggetto alle irripetibili scariche nervose che muovono la mano in un dato istante, che lascia traccia dell’intervento singolare di un essere umano in un dato momento (si tratti di un disegno, di una pennellata, di una scultura; o, per estensione, di unaperformance musicale, drammatica, ecc., dove altri sono i medium, ma analogo l’hic et nunc della situazione emotiva). Lo stile non rimanda ad alcuna “conoscenza o arte” socialmente ereditata, secondo l’intuizione platonica dello Ione; ed è in questo residuo puramente singolare che trova spazio il punto di vista unico e irripetibile dell’autore, che per Danto rende riconoscibile l’opera come arte.
Eppure, proprio la tecnica del readymade sembra ridurre l’intervento “stilistico”, in questo senso, a un minimo: se è vero che il gesto di inserire un oggetto commerciale in una galleria denuncia un pensiero e un messaggio – di ciò a Danto va dato indubbiamente atto – resta la conseguenza prevalente del gesto stesso, che è l’allusione potente alla centralità dell’oggetto, con le sue caratteristiche estetiche, più che all’artista con la sua mano e il suo stile. Di tutto ciò Danto è stato tutto fuorché inconsapevole. I suoi saggi e le sue lezioni sul bello, in parte raccolti nel volume The Abuse of Beauty (2003, recentemente tradotto in italiano) mostrano, con estrema profondità d’analisi, quanto il sottile desiderio di assassinare la bellezza rivendicato da Tristan Tzara, e comune a non pochi protagonisti della prima e della seconda generazione d’avanguardia, abbia annunciato un’azione paziente di decostruzione dei canoni tradizionali del bello, più che dell’interesse estetico come tale. Nonostante Danto limiti eccessivamente le potenzialità affascinanti di questa dilatazione, mostrando nei suoi testi di non accettare fino in fondo le profondità che il grottesco e il perverso possono assumere, la sua descrizione del processo storico di indebolimento delle pretese obiettive della prescrizione estetica (che va distinta accuratamente dalla descrizione, che ne ha di legittime) introduce al tema fondamentale del rapporto contemporaneo non soltanto tra arte e industria, ma soprattutto tra bellezza e industria.
Danto ha parlato, a questo proposito, di “fine dell’arte”. Se l’arte è strettamente imparentata con la centralità dello stile e dell’individuo (residuo romantico, a ben vedere, in un pensatore altrimenti profondamente moderno), ciò che trionfa oggi è la non-arte, proprio perché l’arte pop (e l’industria che l’ha ispirata) hanno contribuito al tentativo di squarciare il velo che il mondo accademico – teorico e artistico – si ostinava e si ostina a tenere in piedi: il bello non è nell’arte, neanche in modo privilegiato; il bello è, o può essere, ovunque, anche in senso eminente. Il bello non è nulla di eccezionale; soprattutto, non è patrimonio di individui eccezionali, né retaggio di particolari teorie del bello. Il trionfo del design, della riproduzione analogica e digitale delle immagini, della decorazione/scrittura murale illegale, del photo e video sharing; la massificazione delle mode, l’attenzione popolare per l’abbigliamento, per il look, per il make up; l’invenzione quotidiana di stili che perdono singolarità nel loro essere tecniche, riproducibili da tutti secondo accorgimenti o regole, secondo una “conoscenza o arte” (giacché l’arte ebbe in origine, tra gli antichi, questo senso, quello di tecnica: così che la modernità appare meno romantica, e più greca) denunciano una condizione in cui la bellezza viene cercata più allo specchio che nelle gallerie, più al negozio che nei musei.
Orrore? Questo è il punto. Nell’economia complessa della storia, e in un’eterogenesi dei fini che vogliamo cogliere esplicitamente a posteriori, con spirito interessato e parziale, il satanismo estetico del capitalismo nordamericano si fa portatore eminente, anche attraverso il tono fondamentale dell’opera di questo autore, almeno di questo suggerimento universale di emancipazione. L’arte, dopo aver sondato l’insondabilità effettiva dei suoi confini, ha saputo guardare alla società con puntuale lungimiranza, e si è disfatta del proprio privilegio nel rapporto col bello. L’ammirazione per essa è dunque, oggi, il più grave tradimento delle sue consegne; ed essa appare conservata più che onorata, negli spazi ingloriosi della museografia, e nella sua ricca ma ristretta fetta di mercato. Il continuo riconoscimento sociale che le si offre è analogo, a ben vedere, all’assenso che si concede a un innocuo insano di mente, e sulle sue spoglie (metaforiche) un nuovo mondo è sorto, un mondo di mille sperimentazioni estetiche e milioni di ideali enciclopedie del gusto, scritte e riscritte dalle pratiche di miliardi di esseri umani. Qualunque evoluzione subirà questo mondo, l’abuso della bellezza è ormai conquista ordinaria, pratica quotidiana; e questo non è un orrore: è una meraviglia.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.