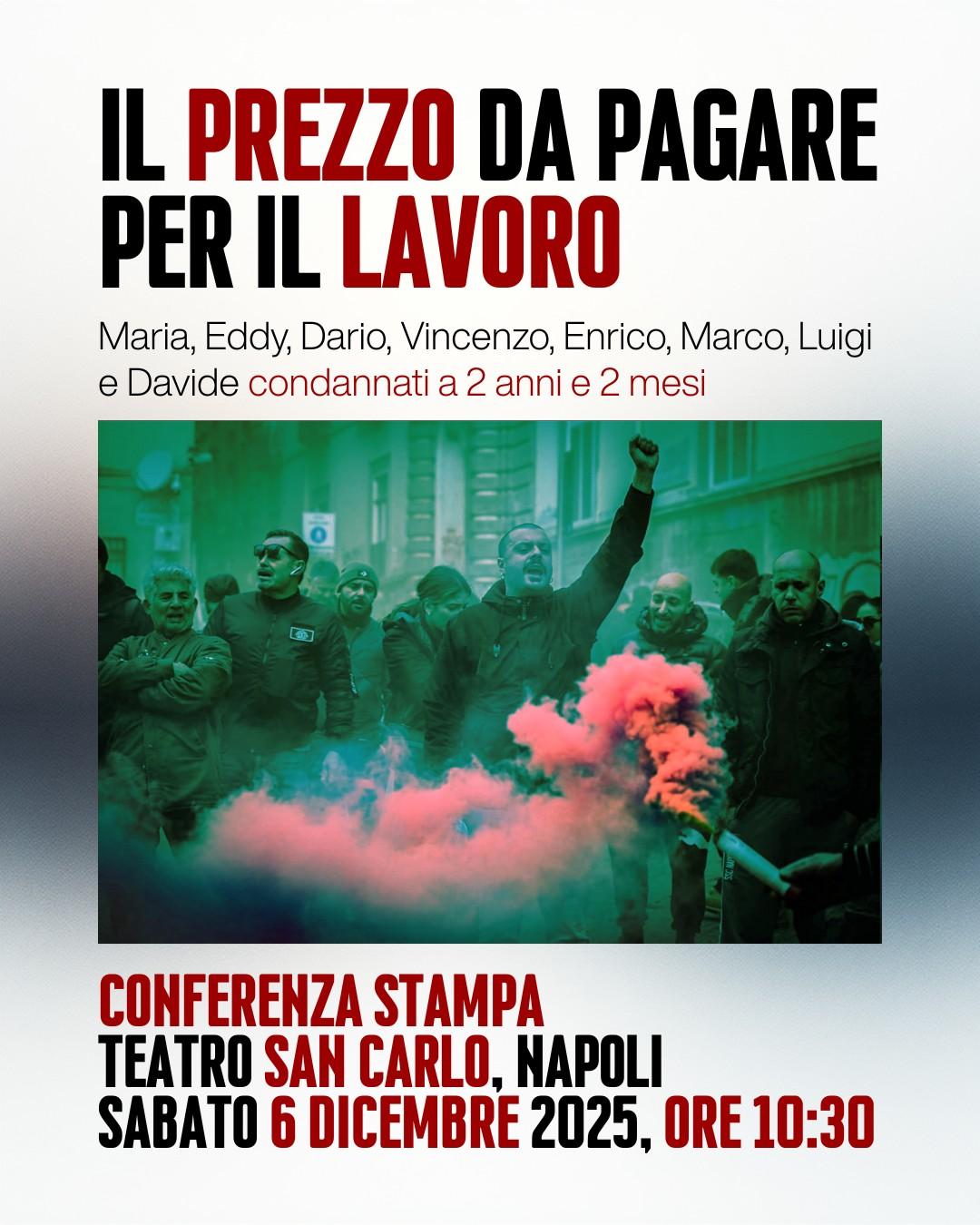Il lavoro al “tramonto della politica”
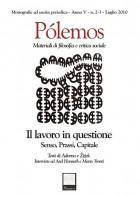
Intervista a Mario Tronti.
La rivista Polemos ha dedicato un intero numero al tema del lavoro. Il fascicolo è intitolato “Il lavoro in questione” ed ospita importanti contributi di filosofi e studiosi di livello internazionale e di giovani ricercatori che da tempo si dedicano a questo tema. Sul sito del Centro per la Riforma dello Stato (CRS) trovate quattro tra i principali contributi in vista di un seminario di approfondimento che si svolgera nella sede del CRS il 12 Maggio 2011 alle ore 15.30.
Vi proponiamo l’intervista a Mario Tronti (da: ControLaCrisi).
Questo numero della rivista è dedicato al tema del lavoro. Abbiamo constatato che nei suoi interventi più recenti Lei ha menzionato spesso la necessità di ripartire dalla dimensione del lavoro, esplicitando l’urgenza politica di tale necessità. Come motiva questa urgenza? Ritiene che il lavoro oggi sia ancora un terreno di antagonismo e che sia possibile ripartire politicamente dal lavoro per produrre conflitto?
C’è un apparato ideologico oggi molto forte e consistente, che è cresciuto nell’arco degli ultimi due-tre decenni, diciamo dagli anni ’80 in poi, e che ha riconfigurato il rapporto tra il lavoro e il resto del mondo, tra la società e la politica, le forme istituzionali e rappresentative, i sindacati, i partiti. Questa corrente di pensiero riconosce che sicuramente nel ’900 c’è stata una centralità del tema lavoro, ma afferma che adesso non esiste più, e che quindi il lavoro è diventato un tratto marginale. La cosa preoccupante è non tanto che tale apparato ideologico sia stato agito dalle classi dominanti, ma il fatto che sia stato introiettato anche da parte di quelle forze che dovrebbero essere alternative. Queste ultime, nell’orbita della sinistra, hanno assunto questo punto di vista ed hanno cominciato a interessarsi ad altre contraddizioni che sarebbero presenti oggi. Non hanno escluso la contraddizione del lavoro, ma hanno fatto un’operazione di questo tipo: hanno posto la contraddizione del lavoro insieme ad altre contraddizioni più o meno sullo stesso livello: la grande contraddizione ambientale, per esempio, che è considerata come decisiva anche nella critica al capitalismo contemporaneo; la questione di genere che è una contraddizione reale, emersa con grande forza negli ultimi decenni; e la contraddizione dei diritti civili in base alla quale, essendoci stato un processo di decollettivizzazione e individualizzazione della società, si ritiene prioritario ripartire dal mondo dei diritti individuali che vengono negati e messi in crisi. In questo modo la contraddizione del lavoro è scomparsa, perché non è una contraddizione che può essere appiattita, e appena perde questa centralità viene meno.
Io, invece, penso che il punto di partenza non è quasi mai la soggettività propria, ma l’oggettività del proprio avversario. La politica deve individuare prima il suo “contro chi”. Il “contro chi” è la struttura fondamentale del capitalismo contemporaneo, come si presenta oggi, nelle forme mutate sicuramente rispetto al Novecento classico. Ora, a parte capitale e lavoro, tutte le altre contraddizioni sono riassorbibili dentro al sistema complessivo. Può esistere un capitalismo che intelligentemente si fa carico della questione ambientale. Non la vedo come una questione di rottura al suo interno, insanabile, come a volte viene declinata. Quando Obama, ad esempio, dice «energie rinnovabili», individua il fatto che, appunto, le energie rinnovabili possono essere un fattore di rilancio dell’economia, il grande business del futuro. La stessa cosa vale per i diritti. Oggi abbiamo una “sinistra dei diritti” che si è sostituita a una sinistra che, una volta, chiamavamo “dei bisogni” oppure “dei conflitti”. Tutti questi diritti è possibile che siano riassorbibili dentro un ordine sistemico capitalista. Si può chiudere Guanatanamo e non fare più le cose che faceva la Cia a Guanatanamo e il capitalismo americano può continuare ad esistere tranquillamente. Altrettanto vale per i diritti civili delle minoranze.
Io parto sempre dall’idea che il capitalismo è la più grande forza inclusiva che sia mai stata realizzata dalle classi dominanti. Non è vero che esclude, include, anzi ha un’enorme capacità inclusiva. Il presidente nero alla Casa Bianca è l’ultima prova di questa grande capacità di inclusione.
Da cosa deriva la priorità che lei accorda al lavoro, la sua inassimilabilità nei confronti del capitale? E soprattutto vale ancora oggi?
Dipende dal modo in cui il lavoro è stato pensato da Marx, sulla scia delle indicazioni hegeliane e, soprattutto, giovani hegeliane. Hegel aveva capito che il lavoro libero era la modernità, era un elemento fondamentale della soggettività moderna. Marx partendo da questo dato ha affermato che non solo il lavoro è un elemento della soggettività moderna, ma è un elemento incompatibile, in ultima istanza, con la struttura del capitale.
Se noi mettiamo il lavoro direttamente in rapporto con il capitale – è questa l’operazione che io ho cercato di fare con Operai e capitale –, quanto più cresce la soggettività nel lavoro, tanto più entra in difficoltà l’oggettività del capitalismo. Tutto questo si misura nel rapporto salario-profitto: quanto più aumenta il salario a danno del profitto, tanto più il profitto capitalistico entra direttamente in crisi.
L’operazione novecentesca, molto abile nel tentativo di includere il lavoro stesso nel capitale, è stata quella di evitare il confronto diretto tra lavoro e capitale, di stornarlo per altre vie, di evitare sempre quella conflittualità diretta, che teoricamente dovrebbe mettere in crisi la struttura del capitale. Dico “teoricamente” perché in mezzo c’è qualche cosa che non nasce automaticamente, spontaneamente.
Perché la soggettività-lavoro non è una soggettività che già c’è, è una soggettività che va costruita, che va organizzata, che va fatta crescere, motivata. E quindi in questo rapporto diretto lavoro-capitale c’è un elemento che deve intervenire, e che è intervenuto sempre da parte capitalistica e molto meno da parte operaia, ed è la politica. Il capitale ha sempre fatto in modo di far intervenire l’elemento politico al fine di governare il rapporto diretto tra capitale e lavoro. Per esempio quando con la grande crisi degli anni ’30 c’è stato l’immediato pericolo di un crollo del capitalismo – l’unico momento in cui veramente questo crollo è sembrato possibile –, la soluzione che il capitale ha trovato, la grande risposta keynesiana-roosveltiana, non a caso, ha introdotto un elemento politico nella struttura economica. Non solo il New Deal, ma anche tutta la teoria keynesiana dello stato sociale. È stata una risposta al fatto che era talmente cresciuta la forza d’impatto delle lotte che si erano sviluppate negli anni ’20-’30, in Europa come negli Stati Uniti, che il pericolo di un confronto diretto tra operai e capitale era imminente. Allora questa uscita politica
dalla crisi è stata la risposta del capitale.
In Operai e capitale, Lei ricostruisce un duplice movimento, da un lato quello per cui la classe operaia trasforma il capitalismo e lo costringe a mutare forma di dominio, dall’altro quello per cui il capitalismo si rafforza proprio traendo vantaggio dalle innovazioni e perfino dalle rivendicazioni introdotte dalla classe operaia. È questa seconda linea che ha prevalso?
Si, è successo questo, ha prevalso la seconda strada. Però la situazione è rimasta notevolmente equilibrata per molti decenni, dopo questo intervento politico del capitale nell’economia e nella società. Perché il compromesso keynesiano, che poi era il compromesso dell’orientamento democratico, era un compromesso tra due punti di forza che avevano pari potenza e che perciò hanno trovato punto di equilibrio. Tutto questo è andato avanti nel corso dei cosiddetti Trenta gloriosi, gli anni che vanno dal dopoguerra alla metà degli anni ’70, durante i quali l’equilibrio delle forze in gioco è stato abbastanza evidente. Teniamo presente i fattori politici che agivano. Intanto, c’era un movimento operaio organizzato a livello mondiale, c’era una Seconda Internazionale, una Terza Internazionale, i grandi partiti di massa e c’era l’Unione Sovietica, che non era un elemento di poco conto. L’esperimento dell’Urss non va letto per quello che era, o meglio va letto per quello che era, ma va letto anche per quello che rappresentava. Significava l’idea di avere dietro le spalle qualcosa di grande, che forniva motivazione alle lotte e produceva capacità di mobilitazione. Costituiva un apparato di credenze ideologiche che aveva un peso indiscutibile: in altre parole, l’idea, non come si dice oggi che “un altro mondo è possibile”, ma che un altro mondo già c’era. Che è diverso. Poi non era un altro mondo, l’abbiamo capito dopo. Però allora lo sembrava, a tanti intellettuali ma anche a livello collettivo, culturale. La storia, che comincia dagli anni ’80 in poi è la storia di oggi, quando il movimento operaio si è indebolito. Si è indebolito prima ancora che si assistesse al crollo dell’Unione Sovietica, quel mondo “alternativo”, perché l’89 viene alla fine di un percorso di indebolimento generale per cui non poteva che crollare tutto insieme. A quel punto è scomparsa la contraddizione del lavoro. E molti hanno festeggiato.
Questo è il dramma.
Una volta venuto meno il sistema di mediazione che garantiva l’assenza di un contatto diretto tra lavoro e capitale – il compromesso fordista, keynesiano –, venuto meno anche il contrappeso della scissione dei due mondi, Unione Sovietica vs. Stati Uniti, e, infine, venuto meno quel complesso sistemico che in qualche modo garantiva al lavoro una sua inclusione all’interno del sistema, non le sembra paradossale che, nonostante questo, la contraddizione del lavoro sia ben lungi dal farsi palese? Come è possibile questa assenza? Quali sistemi sono stati messi in atto dal capitale per impedire che la contraddizione emergesse e ci fosse un contatto diretto tra capitale e lavoro?
C’è stata una lotta di classe fatta soltanto dall’altra parte, al contrario. Il passaggio che avviene, dagli anni ’80 in poi, è un passaggio epocale, da non sottovalutare. C’è stata una grande trasformazione del capitalismo che è questa sorta di Proteo, capace di trasformarsi e di migliorarsi perché ha sempre bisogno di avere una forza propria di molto superiore a quella del suo avversario. Proprio sulla base di quel compromesso che si era realizzato durante i Trenta gloriosi e per smontare quel compromesso, cioè per spezzare quell’equilibrio delle forze, è stata immessa una dinamica trasformatrice della struttura capitalista. Ha giocato molto a suo favore il grande sviluppo tecnologico che è stato introdotto nel processo lavorativo. Si è cercato di rendere sempre meno strategica la presenza del lavoro dentro la produzione stessa, con la sostituzione del lavoro vivo per mezzo della macchina. Questa era una cosa che era già implicita in tutta la fase fordista-taylorista, ma che dopo ha avuto uno sviluppo eccezionale, con vari tentativi che tendevano, ad esempio, a smontare quel processo lavorativo che teneva ancora insieme tra loro i singoli operai. Ci si è accorti che la catena di montaggio era un elemento politico, perché teneva insieme, faceva classe: gli operai, l’uno dietro l’altro, formavano una collettività. Smontare la catena di montaggio e trovare altre forme per il processo lavorativo che scomponevano la filiera è stata un’operazione geniale perché ha distrutto proprio il collettivo, “l’operaio collettivo”. Ecco, sono tutti processi reali che sono stati funzionali alla trasformazione capitalistica e molto meno funzionali ad un processo di crescita antagonistica della classe operaia. A proposito di antagonismo, il problema è sempre quello, che il lavoro ha una soggettività potenziale che, per passare all’atto, in termini aristotelici, ha bisogno di un altro tipo di soggettività, cioè di una soggettività politica e di una forma di organizzazione politica. Qui c’è la disputa eterna che ha percorso anche la storia del movimento operaio tra l’ala spontaneista, l’ala luxemburghiana e l’ala, diciamo, leninista. Io mi sono sempre riconosciuto in quest’ultima perché penso che la forma organizzata sia un elemento imprescindibile per i conflitti sociali e che l’elemento della coscienza nella lotta non sia innato nella figura operaia, ma che sia un elemento che va immesso dall’esterno.
Perché la soggettività politica non può nascere nella realtà lavorativa e deve in qualche modo essere introdotta dall’esterno?
Il lavoro non è politico, perché è immerso in una struttura materiale – anche quando è lavoro immateriale – che è economica. Il lavoratore produce merci, così come la merce produce denaro, così come il denaro produce il capitale. Siamo dentro un percorso economico. Il lavoro è una categoria economica che, però, ha una potenzialità politica che non ha nessun’altra categoria. Il lavoro ha una potenzialità politica, perché minaccia il capitale dall’interno, perché è una parte interna del capitale. Il lavoro è un pezzo di capitale, è, come diceva Marx, capitale variabile.
Poiché è una parte interna, se si arriva alla consapevolezza politica di sottrarre questa parte interna al capitale, si arriva a mettere quest’ultimo di fronte alla sua contraddizione mortale. Ma, ripeto, il lavoro in sé non ha immediatamente una sua attualità politica, ha solo una potenzialità. Qui dobbiamo distinguere tra classe operaia e movimento operaio. La classe operaia sono gli operai effettivamente esistenti, in carne ed ossa, i singoli operai diventati classe attraverso la coscienza. Il movimento operaio è una cosa diversa, cioè è la classe operaia più le sue organizzazioni e non solo le sue organizzazioni, ma anche la sua teoria. Il movimento operaio è stata questa grande soggettività politica moderna, che ha fatto la seguente operazione: ha preso la classe operaia, l’ha dotata di un apparato teorico, quindi di una cultura operaia, che è quella marxista, e di una forma organizzata. La concentrazione operaia ha favorito la capacità di autonoma organizzazione, la socializzazione, la cooperazione. Non a caso un’altra trovata del capitale dagli anni ’80 in poi, è stata quella di smontare le grandi concentrazioni operaie, di diffondere la produzione a livelli aziendali, perché capiva che la concentrazione operaia era pericolosa. Oggi siamo di fronte a una classe operaia non concentrata, ma individualizzata e diffusa nella catena delle medie e piccole industrie.
La figura dell’operaio si distingue dal borghese, perché è una figura antiindividualista: essere operaio vuol dire essere insieme ad altri, non può nascere un individualismo operaio. Quando nasce l’individualismo operaio, come accade oggi, è il momento della sconfitta, e d’altra parte, è lo stesso padronato che cerca di farlo nascere. Tutta la riforma dei contratti negli ultimi anni è consistita in questo, nel soddisfare l’ideale del padrone ad avere un rapporto diretto con il singolo operaio, invece che con la collettività organizzata. Questo è uno strumento di indebolimento delle difese operaie e di smantellamento del movimento operaio. Esso è stato l’ultima grande forma della soggettività politica: la fine del movimento operaio ha coinciso con la fine della politica, con il ‘tramonto della politica’.
Cosa c’è oggi al posto della politica tramontata?
C’è il deserto. Io oggi parlerei esplicitamente di fine del movimento operaio, questa grande soggettività che sicuramente sta dietro le nostre spalle. Credo che sia stata un’esperienza irripetibile. Il problema non è ricostruire il movimento operaio, ma farsene eredi. Farsi eredi della storia operaia significa anche farsi eredi della lunga, lunghissima storia delle classi subalterne, di tutte le rivolte, da quella di Spartaco, alle guerre dei contadini nella Germania di Thomas Müntzer, passando per le sette eretiche medievali, fino alle emergenze sovversive interne alle rivoluzioni borghesi – penso alla Rivoluzione Inglese, ai Livellatori, alla stessa Rivoluzione Francese, al ’48. Questa è la nostra storia.
Quella che oggi si chiama sinistra può essere credibilmente sinistra soltanto se dichiara apertamente di essere l’erede legittima del movimento operaio, della sua lunga storia, che è nata con la rivoluzione industriale: una storia autonoma dentro la modernità, di esperienze, di cultura, di socialità di organizzazione. Bisogna che la sinistra la rivendichi come la propria storia e da qui riparta per costruire qualcos’altro. La classe operaia ha operato una rottura nella storia delle classi subalterne perché, per la prima volta, non si è più sentita classe subalterna, non ha più giocato nella storia come classe dominata, ma come una classe dirigente e anche come classe potenzialmente dominante. Dobbiamo capire in che modo c’è una potenzialità nella fine della classe operaia, nel senso che la fine della classe operaia ci ridà in mano un orizzonte di lavoro ampio, più esteso e più vasto, visto che non c’è più la classe ristretta, ma c’è una struttura diffusa del lavoro che dovrebbe innanzitutto essere indagata. Un esempio è dato dall’emergere di figure come quella del lavoratore autonomo di prima, seconda, terza generazione che ha una sua specificità poiché incarna una forma per cui il lavoratore è nello stesso tempo padrone, cioè padrone di se stesso, sfruttatore di se stesso. Queste situazioni meritano di essere analizzate e comprese attentamente.
Nella fine del movimento operaio e nel tentativo di raccogliere l’eredità di quest’ultimo, cosa accade di nuovo e come muta la politica?
Per me la politica è essenzialmente conflitto e il criterio del politico è quello dell’amico-nemico schmittianamente inteso. Metto in conto la possibilità che questo criterio del politico possa essere superato e potrei affidarmi alla creatività di altre forme della politica. Discuto molto con l’orizzonte del femminismo, soprattutto con quello italiano, con il pensiero della differenza. Loro mi rimproverano sempre questo accanimento sul criterio amico-nemico del conflitto, e ripropongono una concezione della politica come aggregazione, come rapporto di scambio. Forse questo potrebbe valere anche per il lavoro, nella misura in cui bisognerebbe ritessere le fila di questa struttura del lavoro diffusa e recuperare una forza maggiore perfino di quella che aveva la classe operaia. I lavoratori, in quanto lavoratori, sono una struttura sociale collettiva dentro cui riconoscersi, che, se messa insieme e organizzata politicamente, può esprimere un’altra idea di società, di mondo e forse, mettiamo in conto anche questo, un’altra idea di politica.
Abbandonare l’orizzonte del conflitto, della contrapposizione, non rischia di essere un’opzione politica fallimentare nei confronti del capitale?
Bisognerebbe avere la capacità di una trasformazione rivoluzionaria nei tempi lunghi. La rivoluzione non è più pensata come un salto immediato, ma come un processo. Qui ritorniamo all’universo di una politica che non è soltanto quella schmittiana, ma ad un’idea della politica moderna più articolata, quella machiavelliana.
Mi riferisco all’idea che bisogna stare nella contingenza, nella congiuntura e nello stesso tempo bisogna essere liberi dalla contingenza e dalla congiuntura. Bisogna stare dentro e fuori contemporaneamente, anzi “dentro e contro”, come si diceva una volta. Questa mi sembra proprio la dimensione globale e orizzontale che il lavoro può esercitare. Che cos’è questo modello alternativo di società se non un rovesciamento del rapporto capitale-lavoro? Io non credo che sia possibile un compromesso, un equilibrio tra le due potenze. Un modello sociale alternativo è l’idea che il lavoro comanda e l’impresa ubbidisce, cioè un rovesciamento che ponga fine allo sfruttamento.
La sinistra dovrebbe riuscire a narrare questo modello, a farlo emergere, a farlo vedere. Le cose bisogna farle vedere, non si vedono da sole, perché Marx ci ha insegnato che c’è la realtà e c’è l’apparenza, il reale e l’ideologico, si tratta di squarciare il velo ideologico, narrare il reale. Narrare il reale lo può fare soltanto la sinistra politica. Torniamo sempre al dunque, finché non ci sarà una sinistra politica, non ci sarà nessuna possibilità di liberazione del lavoro. Questo è il punto essenziale della cosa.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.