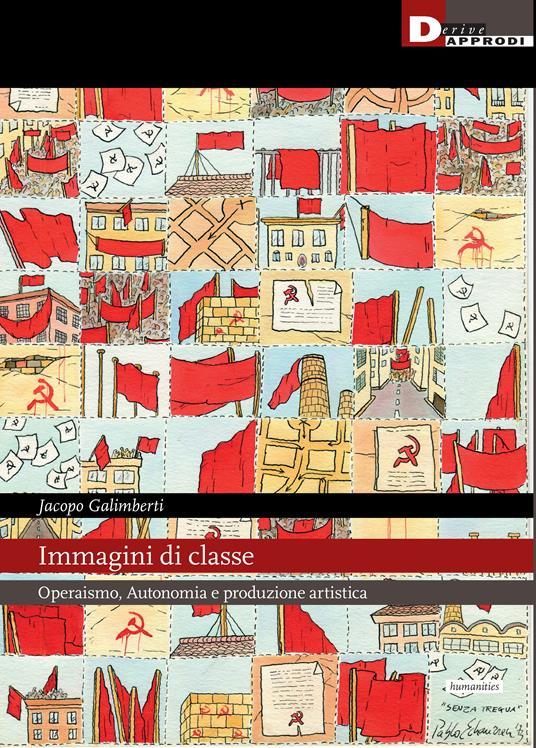Quale operaietà oggi?

Intervento introduttivo al tavolo Lavoro/non-lavoro a cura della redazione d’Infoaut Torino durante il seminario Autonomia Contropotere a Chianocco, Val di Susa, 15-16 Luglio 2017.
Porre oggi la questione dell’operaietà significa interrogare l’attualità di una particolare forma organizzativa del rapporto di capitale. Una questione che può sembrare bizzarra e anche in contro-tendenza. Negli ultimi trent’anni, al termine industriale ci si è affrettati ad aggiungere il prefisso “post” mentre si festeggiava l’abbandono del cosiddetto “feticcio della classe operaia”. Una convergenza parallela tra teoria critica e pensiero dominante decretava la fine di un’era. Si tratta del corollario inevitabile di una concezione dell’industria che la fa coincidere con un settore particolare della produzione, quello della manifattura. La proposta che facciamo è invece quella di vedere l’industria non come un settore ma una modalità di organizzazione capitalistica trasversale ai diversi settori di attività che non si è attenuata ma si è anzi approfondita.
Cercheremo quindi innanzitutto di delineare alcune invarianze di questa forma organizzativa attraverso una sua genesi, mettendo in evidenza come essa qualifica l’operaietà per poi arrivare alla società in cui viviamo.
Tra la fine del 700 e l’inizio dell’800 emerge rapidamente un fenomeno battezzato poi dagli storici “la rivoluzione industriale”. In realtà abbiamo assistito a diversi salti tecnologici nella manifattura ben prima di questo momento storico al punto che cicli di produzione complessi in stabilimenti concentrati esistevano già da molto tempo, almeno dal ‘300, come d’altronde esistevano conflitti “industriali”, pensiamo ad esempio al famoso tumulto dei Ciompi a Firenze. Teniamo quindi a mente che a livello della tecnica, la rivoluzione industriale è piuttosto una rivoluzione industriale che delinea però effettivamente quella modalità organizzativa particolare del capitalismo da cui, ci arriveremo in seguito, ancora non siamo usciti. Ciò che caratterizza questa particolare rivoluzione industriale è il fatto che durante un certo ciclo sistemico di accumulazione, quella dominato dall’Inghilterra, si delinea la volontà di internalizzare al capitalismo una nuova sfera, quella della produzione. Prima il rapporto capitalistico era un rapporto puramente commerciale e quindi la sfera della produzione veniva delegata agli artigiani nel quadro dell’economia corporativa, ai contadini nelle forme di proto-industria nelle campagne o agli intermediari coloniali. La prima cosa che è importante capire quindi è che nascita dell’operaio è il frutto innanzitutto di una gigantesca opera d’incorporazione del proletariato al capitale e l’industria è la forma in cui si dà questa integrazione, questa sussunzione effettiva. Un primo punto fermo: l’operaio non è tale perché è sfruttato o perché è povero ma perché è continuamente e direttamente inserito dentro dei meccanismi di valorizzazione.
La seconda caratteristica dell’industria è che essa organizza l’attività degli operai e non solo i flussi di merci e servizi prodotti dai lavoratori. Il rapporto tra capitale e lavoro prima della “rivoluzione industriale” era sempre mediato dal mercato della merce o dei servizi. Per esempio, un mercante ordinava a un tessitore una pezza di lana a un dato prezzo e lasciava al lavorante con le sue tecniche organizzarsi su come, quando e quale ritmo eseguire il lavoro. Lo stesso valeva per i servizi, dove il cliente si accordava per l’esecuzione di una prestazione discreta, per esempio la riparazione di una carrozza. La disciplina del lavoro non si basava quindi sui gesti o sui tempi – ossia sul lavoratore stesso – ma sul prodotto che doveva aver determinate caratteristiche. Il rapporto industriale è invece non un rapporto commerciale ma organizzativo, l’operaio è operaio perché è organizzato nella sua attività per i fini del capitale fin nei suoi minimi gesti, un tratto che raggiunge il suo punto più evidente nel sistema taylorista.
Come può il capitale pretendere di organizzare in maniera così minuta gli operai? Prima segnalavamo il che il rapporto tra capitale e lavoro in epoca pre-industriale era sempre mediato dalle merci, dalle cose. Nel rapporto industriale invece l’operaio non può e non deve vendere i prodotti del suo lavoro concreto ma il suo lavoro in quanto tale, il suo lavoro astratto. Il compenso dell’operaio appare quindi come prezzo del lavoro. Marx rileva subito però la natura inevitabilmente mistificatoria della teoria borghese del valore-lavoro, “questa forma fenomenica che rende invisibile il rapporto reale e mostra precisamente il suo opposto, [su cui] si fondano tutte le idee giuridiche dell’operaio e del capitalista, tutte le mistificazioni del modo di produzione capitalistico, tutte le sue illusioni sulla libertà, tutte le chiacchiere apologetiche dell’economia volgare”. Dice infatti Marx che “per essere venduto sul mercato come merce, il lavoro dovrebbe comunque esistere prima di essere venduto”. C’è però un problema perché, come abbiamo detto prima, il lavoro venduto dall’operaio è astratto e quindi non pre-esiste al rapporto di produzione industriale: “appena il suo lavoro comincia realmente, esso ha già cessato di appartenergli, e quindi non può più essere venduto da lui”. Se il suo lavoro non può appartenergli, insomma, l’operaio non può neanche venderlo. Che cosa vende allora l’operaio sul mercato delle merci? Nel Capitale, Karl Marx usa questo termine Arbeitskraft, che è stato sempre tradotto in italiano come forza-lavoro, come se si trattasse di una questione di forza muscolare. In tedesco in realtà il termine kraft può essere tradotto non solo come forza ma anche come capacità e potenza. Sarebbe quindi più giusto dire che il lavoratore vende la sua potenza di lavoro. Questo lavoro, proprio perché in potenza, non può essere venduto dall’operaio che deve quindi vendersi in quanto persona: “in realtà, sul mercato delle merci si presenta direttamente al possessore di denaro non il lavoro, ma il lavoratore”. È qui il ribaltamento dell’industriale, non c’è più mediazione della merce perché è il lavoratore stesso che diventa merce: diventa operaio. Il rapporto salariale è sempre un furto perché ciò che vende l’operaio è incommensurabile: “il lavoro è la sostanza e la misura immanente dei valori, ma esso stesso non ha valore”. Non c’è nessun rapporto tra capitale e lavoro, il rapporto è sempre tra capitale e operai. Questo è un altro punto fermo che è importante sottolineare, l’operaio non vende la sua forza lavoro, vende sé stesso, vende tutta la sua capacità umana come merce. Per poterla vendere questa capacità dev’essere prima violentemente separata dalla persona che la detiene. L’operaietà si configura quindi da sempre come un processo di espropriazione continuamente rinnovato tra la capacità umana e la persona, separatezza che diventa poi contrapposizione: le capacità dell’operaio finiscono per ergersi contrapposte all’operaio stesso innanzitutto perché non gli appartengono più e poi perché non sono più utilizzate per i suoi fini. Che cosa rende possibile questo processo di separazione in cui le capacità vengono espropriate, selezionate e poi ricomposte per fini capitalistici? Lo rende possibile quel rapporto peculiare che l’industria intrattiene con la tecnica. Il rapporto con la tecnica dell’operaietà è il rapporto macchinico. La macchina, a differenza dello strumento, è ciò che non viene utilizzato dall’uomo ma ciò che utilizza l’uomo. L’operaio è l’appendice vivente della macchina, che prenda la forma fisica della catena di produzione, quella dell’algoritmo o dei flussi logistici. Non è più l’agente umano che agisce l’attività, ma l’operaio che viene agito dal lavoro.
La questione che ci poniamo oggi è: siamo usciti da questa modalità organizzativa che è l’industria? Ovviamente la risposta è negativa ma questi meccanismi si dispiegano senz’altro in maniera diversa.
Abbiamo parlato di operaietà come integrazione di strati proletari nel capitalismo. Bisogna tenere a mente che oggi, in un regime di accumulazione flessibile, l’integrazione coincide sempre meno con l’internalizzazione nella forma impresa e sempre più con l’interiorizzazione di quella stessa forma. La rivoluzione manageriale partita dagli USA che si dispiega dalla fine del XIX secolo fino agli anni ’60 ha favorito meccanismi d’integrazione verticale e diretta di un numero crescente di operazioni, di filiali e di lavoratori dentro la stessa azienda. Con la crescente finanziarizzazione, la forma impresa cambia e si scompone, assistiamo quindi da ormai trent’anni a un ritorno della mediazione attraverso i meccanismi del mercato e della concorrenza all’interno dell’industria. Si tratta di un movimento visibile a diversi livelli, pensiamo ai meccanismi di appalto e subappalto che regolano ormai ogni settore della produzione sia di merci che di servizi sia nel settore pubblico che in quello privato in campi tanto diversi quanto la componentistica dei microprocessori, le cooperative di aiuto agli anziani o i servizi di movimentazione delle catene logistiche globali. Questo ritorno della messa in concorrenza attraverso il mercato all’interno della stessa forma impresa tocca ormai in maniera sempre più chiara anche la forza lavoro. Basti pensare a forme di operaietà uberizzata in cui i vari uber, delivroo, foodora non sono altro che una macchinetta d’intermediazione il cui scopo è fornire stimoli e parametri di messa in concorrenza (rapidità, efficienza, prontezza, resistenza etc.) che determinano l’accesso e l’entità della remunerazione. Questa ritorno della mediazione attraverso il mercato implica chiaramente anche un ritorno alla disciplina attraverso il prodotto, d’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che lo spazio panottico della fabbrica è ormai dissolto portando con sé la possibilità di una sorveglianza diretta e continua del lavoratore. I prodromi di questa tendenza erano già presenti nella forma organizzativa toyotista ma hanno oggi colonizzato ogni campo industriale, pensiamo alle pratiche di public management in cui il funzionario viene giudicato sul numero di poveri che riesce a far uscire dal sistema assistenziale, al lavoro “a progetto” in cui a giovani “creativi” viene commissionato un lavoro con determinate caratteristiche e tempi strettissimi. Apparentemente assistiamo quindi una rinuncia ad “organizzare” gli operai nella minutezza del loro lavoro. Ovviamente si tratta soltanto di un’illusione resa possibile dalla dimensione cumulativa del processo di impoverimento dell’agente umano proletario ormai privato di ogni esteriorità (ma non estraneità!) rispetto al capitale e quindi lasciato formalmente “libero” nei gesti in contesto di continua ingiunzione all’auto-valorizzazione.
C’è però inevitabilmente un irrisolto e quindi una possibilità di rottura in questo salto. Essa si trova nella natura stessa di quella merce particolare che è la forza lavoro, l’unica merce che, com’è ben noto, quando viene utilizzata nel processo di produzione produce più del suo valore. È questa l’unica merce che il capitale deve preservare e di cui deve continuamente assicurarsi di ri-produrre le condizioni di separatezza e subordinazione. Proprio per preservare questo valore che produce più valore, il capitale non può vivere di un’operaietà completamente impoverita che deve essere ciclicamente ri-arricchita al di là di ciò che serve ai fini strettamente capitalistici (l’attenzione spasmodica alla formazione del capitalismo contemporaneo è in questo senso indicativa). I momenti alti della lotta operaia coincidono coi momenti in cui alla separazione tra capacità e attore umano non segue una ricomposizione nel senso del capitale, pensiamo ad esempio agli anni ‘60/’70 e allo scollamento tra la scolarizzazione di massa e la disciplina fordista. Dove si situa nell’operaietà contemporanea questo scarto? Ecco una questione che vale la pena porre.
Abbiamo anche parlato di operaietà come un inserimento proletario dentro meccanismi di valorizzazione lavorizzata. Questi meccanismi di valorizzazione oggi sono estremamente diversi dall’industria anche solo di venti o trent’anni fa e prendono sempre più raramente la forma del rapporto salariale esplicito. Le espulsioni di strati proletari sempre più ampi da ogni tipo di forma lavorativa o di welfare non significa però una loro espulsione da processi di valorizzazione capitalistica che anzi continuano ad espandersi. Prendiamo un caso estremo ma abbastanza esemplificativo. Nel 2015 Google e Facebook hanno lanciato due progetti concorrenti per portare connessione internet a centinaia di milioni di potenziali clienti che si trovano in zone remote del continente africano. La prima attraverso giganteschi palloni di elio la seconda grazie a droni a energia solare che rimangono sospesi in aria. Una connessione che ovviamente non permetterebbe l’accesso al world wide web ma sarebbe limitata al recinto dei network delle rispettive corporation. Un caso che parla di una crescente centralità del lavoro di consumo, lavoro che crea valore e che diventa quindi campo di una contesa capitalistica che cerca di imbrigliarlo e incanalarlo in determinati circuiti che devono essere controllabili e mappabili per poter essere messi a valore. È la stessa tendenza che vediamo all’opera per quanto riguarda il consumo riproduttivo nel campo del welfare statale o aziendale. Nell’ultimo contratto dei metalmeccanici quasi la metà dell’aumento è rappresentato da “flexible benefit”, in sostanza buoni da utilizzare in determinati esercizi per la benzina, per la spesa etc. mentre le prestazione nel campo del fu stato sociale sono sempre meno erogate come denaro e sempre più in forma di buoni da spendere per esempio in un numero limitato di supermercati, fino ad arrivare a veri e proprie industrie della povertà come per esempio i magazzini gestiti dalla Caritas o altri enti in cui non a caso stanno massicciamente investendo le fondazioni bancarie. La crisi è innanzitutto una crisi di valorizzazione del capitale e dobbiamo quindi essere attenti nello scorgere quelle dinamiche che permettono di re-inserire e organizzare strati proletari dentro circuiti di lavoro che possono prendere forme estremamente diverse, in cui consumo e produzione, produzione e riproduzione spesso collassano l’uno sull’altro. Lo segnalavamo poc’anzi rispetto al welfare, in queste nuove forme di operaietà la mediazione monetaria sembra giocare un ruolo sempre più marginale, come dimostrato anche dalla centralità del lavoro gratuito nel campo della formazione (parleremo poi di alternanza scuola lavoro ma ormai la tendenza è sempre più generalizzata investendo ogni strato non giovanile ma semplicemente che è entrato nel mercato del lavoro negli ultimi vent’anni). Significa che lo scontro capitale-lavoro non si gioca più sul salario? Sono piuttosto le nostre forme rivendicative che non riescono oggi a imporre uno scontro che si misuri con la natura polimorfa e plurale del salario. Salario che è da sempre non una variabile tecnica per misurare il lavoro ma una variabile politica fatta per occultare il plus-lavoro, per pagare il meno possibile il valore creato dall’operaio.
Ancora qualche parola sulla tecnologia. La tecnologia come strumento del capitale è ciò che struttura l’organizzazione del lavoro vivo dell’operaio e quello morto delle macchine. Che ne coordina l’agire e ne progetta il divenire. La tecnologia capitalista ha una missione politica di organizzazione sociale: incorporare la maggiore parte possibile di lavoro vivo dentro la macchina, controllare, codificare e disciplinare il rimanente lavoro vivo operaio per massimizzare la valorizzazione, la produzione e dunque il profitto. La tecnologia è dunque innanzitutto codifica del comportamento operaio. Apprendimento per l’automazione delle capacità umane che esso contiene. La codifica però come ogni modello matematico è una semplificazione, una razionalizzazione di quei comportamenti, non è in grado (ancora e forse mai) di riprodurli in toto, di sussumerli interamente dentro la macchina. Dunque sussiste il problema della forza lavoro, delle sue prestazioni e della sua capacità di eludere le codifiche, di agire sul processo produttivo, di agirne contro. La tecnologia, lo ripetiamo, è uno strumento di organizzazione politica e sociale prima di tutto e in quanto tale, anche in risposta alla lotta operaia, prescinde la fabbrica a grande concentrazione, si riversa su tutta la società. E dunque anche l’operaietà, la condizione operaia, esce da quelle mura. Il capitale nel suo mantra di massimizzare i profitti ha bisogno di estendere l’incorporazione del lavoro vivo in ogni ambito della produzione e della riproduzione e la tecnologia è lo strumento che utilizza per farlo. Per fare questo il capitale è disposto a concedere anche una quantità di capitale fisso all’operaio (possibilmente sotto il ricatto del debito), e cioè che sia l’operaio stesso a possedere la macchina del suo sfruttamento (Computer, cellulari, automobili, camion ecc… ecc…). In tal modo sostiene anche l’offerta della sua produzione. L’umano quindi incorpora la macchina per potersi vendere meglio come forza lavoro, per generare nuove capacità, per potersi emancipare dai lavori più pesanti e migliorare la propria posizione economica, ma mentre fa questo offre alla tecnologia maggiori possibilità di codificare il suo lavoro vivo e di incorporare un’ulteriore quantità di lavoro vivo.
Non esiste più dunque un fuori dal rapporto di capitale e l’operaizzazione della società, o meglio della parte che vende la propria forza lavoro in cambio di un salario per sopravvivere, è pervasiva. Il rapporto di capitale globalizzato avendo colonizzato ogni anfratto possibile si trasforma da estensivo in intensivo e lo farà sempre di più. Ri-estraendo ricchezze da territori già saccheggiati ma anche aumentando la quantità di lavoro vivo trasformato in automazione. Ma la crisi del capitale in tendenza è anche crisi di caduta del saggio di profitto: i sempre più frequenti salti tecnologici atti a incorporare nuovo lavoro rendono obsoleti strumenti e saperi codificati in fretta mentre i salari e dunque il potere d’acquisto della forza lavoro si riducono. Contemporaneamente l’automazione espelle sempre più forza lavoro dal processo produttivo amplificando l’effetto di questa tendenza. Finora il capitale ha risposto attraverso i meccanismi di credito/debito a questo problema, ma con le bolle del 2008 si è dimostrato che è insostenibile al sistema questo strumento. Dunque come ne uscirà?
D’altro canto l’automazione non è arrivata e probabilmente non arriverà mai al suo totale compimento (al Matrix per intenderci!) e dunque continuerà ad esistere un rapporto antagonistico tra l’uomo e la macchina, un irrisolto dell’umano che sfugge alla codificazione e che può metterla in crisi. D’altronde la tecnologia stessa è una menzogna lì dove con presunzione crede di poter riprodurre perfettamente la natura, come lo è il neoliberismo che la utilizza cosciente della sua inadeguatezza per organizzare il proprio sistema.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.
AUTOMAZIONE DEL LAVOROlavoro gratuitooperaismoSEMINARIO AUTONOMIA CONTROPOTERE 2017