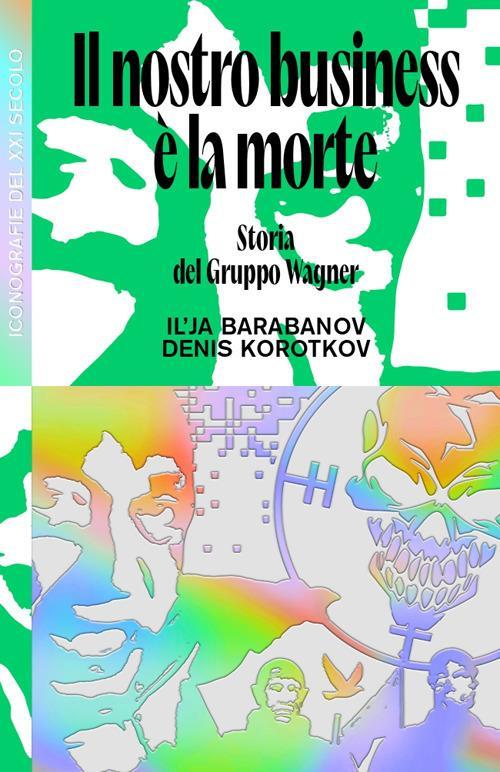Poggioreale: la cella zero è un sistema

Violenze gratuite, percosse, abusi ad opera di una squadretta di agenti di polizia penitenziaria che di notte si scatena sui detenuti al piano terra del carcere, in una stanza chiamata “cella zero”, priva di telecamere, macchiata del sangue dei malcapitati. Ma se Poggioreale fosse solo una spia, un campanello d’allarme, seppur gravissimo, di un “modus operandi” che appartiene a diverse realtà carcerarie italiane? È il sospetto che emerge dalle interviste, rilasciate in esclusiva a Popoff, da alcuni ex-detenuti che hanno conosciuto l’orrore di Poggioreale e non solo.
Reparto del carcere Carmelo Magli di Taranto chiuso perchè dichiarato non agibile e in attesa di fondi europei destinati alla ristrutturazione e messa in sicurezza.
«Sono finito in carcere per la mia prima volta nel 2009 e sono tornato in libertà solo nel 2013. Una pena di quasi cinque anni per minaccia con metodo mafioso. È successo dopo la perdita di mio fratello, due mesi prima che fossi arrestato, morto in seguito ad un agguato in auto, dove era con la moglie e la figlioletta di un anno. Quest’episodio mi portò a minacciare gente malavitosa, che pensavo fosse coinvolta nell’assassinio di mio fratello». Ciro, attualmente sorvegliato speciale, titolare di un bar a Maddaloni nel casertano, così ricorda il suo ingresso nel mondo penitenziario, gli occhi ancora colmi di rabbia.
«Un giorno a Poggioreale presi un rapporto, non ricordo nemmeno il motivo, e così mi portarono al piano terra in una cella di isolamento. A pochi metri dalla mia stanza ce n’era un’altra. La chiamavano “cella zero”. Una sera vidi trascinare lì un detenuto e lo sentivo urlare. Mi colpì il rumore lancinante delle percosse inflitte sul suo corpo. Poi grida sempre più forti. Uno strazio. Io mi allarmai al punto che cominciai ad inveire verbalmente contro gli agenti di polizia penitenziaria che erano lì. Mi sentivo impotente. Il detenuto subì l’aggressione per circa quindici minuti, che mi sembrarono lunghissimi. Poi uscirono da quella stanza e due agenti mi si avvicinarono. Avevano ancora i guanti di lattice, che usavano per percuotere in modo da non lasciare tracce e difendersi da possibili infezioni. Insieme ai due agenti c’era anche l’ispettore. Mi intimarono di dormire e dimenticare quello che aveva visto e sentito quella sera». La voce tremula, ma carica di amarezza di chi ha visto con i propri occhi l’indegnità e la vigliaccheria umana. Odori, suoni, visioni, che difficilmente Ciro riuscirà a cancellare dalla propria mente.
«La sera stessa in cui portarono il detenuto nella “cella zero” io vidi arrivare un’infermiera per medicarlo. Sentivo il giovane lamentarsi e chiedere aiuto alla donna, ma lei non rispondeva. Restò tutto il tempo in silenzio. La mattina dopo quell’episodio io ero ancora nella cella d’isolamento. Passarono per i corridoi l’ispettore e la direttrice. Io lo guardai dritto negli occhi, ma non dissi niente. Il pomeriggio venne da me l’ispettore, soprannominato “piccolo boss”, e mi chiese perché lo avevo guardato con aria minacciosa la mattina, quando era passato nel corridoio con la direttrice. Io gli risposi che non accettavo il suo sistema crudele e violento. Le mie parole lo turbarono visibilmente. Così fece aprire la mia stanza e mi portarono nella “cella zero” dove c’erano due agenti, sempre gli stessi, con i guanti in lattice alle mani. L’ispettore mi fece perquisire, e mi disse che dovevo spogliarmi nudo. Io però gli feci presente che ero un pugile professionista e che se mi avessero anche solo toccato io avrei reagito immediatamente. Ricordo i suoi occhi fissi sui miei per quasi un minuto. Uno sguardo gelido e impietoso. Poi si rivolse all’agente e gli ordinò di riportarmi nella mia stanza. Credo di essere stato molto fortunato quel giorno. Cercai di comunicare quanto accaduto alla direttrice, ma c’erano sempre gli agenti vicino. Lo stesso avveniva con la psicologa o la psichiatra. Parlai allora con il sacerdote, il quale mi consigliò di denunciare tutto. Ma io non lo feci». Ciro parla per la prima volta di quanto ha visto e subito nel carcere di Poggioreale. Non ha mai voluto denunciare perché ha perso fiducia nelle istituzioni.
«Il penitenziario è un mondo corrotto, marcio nelle fondamenta, malato. È un sistema di soprusi che si poggia sulle coperture e sul “tacito assenso”di tutti. In questo modo gli aguzzini si sentono inviolabili», continua rammaricato. «La cosa più disumana è che coloro che dovrebbero tutelare la legalità diventano fautori di violenza. Io se non lo avessi visto con i miei occhi non ci avrei mai creduto che fosse possibile tutto ciò. Molte persone, che il carcere non l’hanno conosciuto, a queste storie non credono. Questo mi fa ancora più paura».
Interno di una cella base del carcere Carmelo Magli di Taranto.
Ciro non è stato solo rinchiuso nel carcere di Poggioreale. Ha conosciuto anche la realtà della casa circondariale “Carmelo Magli” di Taranto, dove dichiara di «averne viste di cose terrificanti». «Prima di Poggioreale ho scontato parte della mia pena nel penitenziario di Taranto, dove lavoravo nell’infermeria, in quanto considerato un soggetto non pericoloso e di buona condotta. Anche lì ricordo una cella di isolamento al piano terra, dove portavano chi riceveva un rapporto o chi doveva essere “punito”. Era una cella vuota, senza tavolo, né materasso. C’era solo una branda di ferro. Mi capitava sempre di vedere i detenuti passare dalla cella di isolamento all’infermeria. Erano in pessimo stato, pieni di lividi, ematomi, sangue. Anche lì c’era la “squadretta” e l’ispettrice che, come ogni altro membro del carcere, sapeva tutto e appoggiava quel sistema. La cosa che più atroce, a cui mi capitava di assistere era quando arrivava in carcere qualcuno malato di mente destinato all’Opg (Ospedale psichiatrico giudiziario). Lo lasciavano in infermeria in attesa di trasferimento. Lo facevano svestire e lo legavano. Mi ordinavano di entrare prima che mettessero il detenuto e di svuotare la stanza, compresi gli sgabelli, il tavolo, le coperte. Poi mettevano i suoi vestiari in una busta fuori la cella. Così iniziavano a picchiarlo e io sentivo le grida, ma non potevo fare niente. Di nascosto, dopo le percosse, cercavo di passargli quello di cui aveva bisogno, come gli indumenti. Non riuscirò mai a dimenticare il lamento di quelle persone, completamente indifese. Anche a Taranto comandano gli agenti di polizia penitenziaria, e si scagliano contro i più deboli, contro coloro che non posso difendersi e non reagiscono. Se un detenuto è più forte e può avere una reazione nei loro confronti si dotano di cinque, sei scudi e non risparmiano nessuno. La maggioranza dei detenuti subisce i maltrattamenti in silenzio perché non vuole essere trasferita. Il tribunale di sorveglianza è abbastanza clemente e i reclusi sperano nei permessi-premio per uscire. Ricordo la rabbia che mi assaliva quando si svolgevano le visite istituzionali nel carcere. Avevamo ordine di ripulire tutto e loro nascondevano le celle di isolamento, dove spesso avvenivano le torture. I luoghi delle violenze erano inavvicinabili per i politici o altri rappresentanti istituzionali che visitavano la struttura». «Il carcere è un mondo a parte», conclude Ciro, senza nascondere un’amara constatazione che ha il sapore della rassegnazione.
Un uomo, sicuramente non l’unico, che porta nello sguardo un orrore incancellabile, che non si è arrestato una volta fuori, che ha varcato la soglia delle sbarre di Napoli come di Taranto. Duemila e ottocento detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di milletrecentottanta, stipati in meno di tre metri quadrati. L’attività di formazione è assente. Gli educatori carcerari sono diciannove a fronte di circa settecento agenti di polizia penitenziaria. Il lavoro interno è destinato solo a duecento detenuti, che sono coinvolti in progetti di rieducazione. Due le ore di aria concesse: una la mattina e una la sera. Queste le cifre di Poggioreale.

Veduta del carcere di Poggioreale, a Napoli, da via Nuova Poggioreale.
Dall’altra parte il penitenziario di Taranto, entrato in funzione a metà degli anni Ottanta. Molte le problematiche strutturali che lo rendono, in alcune aree, pericolante. Un carcere costantemente sovraffollato, con cinquecentoventicinque detenuti a fronte di una capienza regolamentare di duecento posti. I detenuti in attesa di primo giudizio sono centocinquantatré, mentre coloro che scontano una sentenza definitiva di condanna sono trecentodiciotto. Il quaranta per cento degli ospiti sono tossicodipendenti. In un’interrogazione parlamentare presentata dalla radicale Rita Bernardini a Paola Severino, ministro della Giustizia, nel mese di settembre del 2012, per chiedere notizie sulla struttura di Taranto, si fa riferimento all’atavico sovraffollamento presente nel carcere, alle pessime condizioni di vivibilità e all’alto tasso di suicidi tra i detenuti. Ad oggi nessuna risposta.
A Taranto come a Poggioreale esiste un margine molto sottile tra il sovraffollamento e l’acuirsi di episodi di violenza, che trovano così terreno fertile. «Nel carcere di Poggioreale eravamo anche in dodici, tredici in una cella. Mancava l’aria. Compiere anche i più elementari movimenti diventava complicato ed eravamo tutti particolarmente irritabili, specie durante il periodo estivo». Piero (nome di fantasia), originario dell’hinterland partenopeo, ha trascorso in carcere circa dieci anni, dal 1999 al 2009, per reati di rapina e spaccio. Ora vive a Roma e ha famiglia, ma quei giorni passati tra le fredde mura di Poggioreale ancora lo tormentano. «È tutto vero quello che altri detenuti hanno denunciato riguardo alla “cella zero”. Esiste davvero la camera delle torture. Posso aggiungere, però, che non è un’unica cella. Ce n’è una per ogni padiglione, e si tratta di sale d’attesa in cui di notte si scatena la violenza degli agenti penitenziari». Si apre quindi un’ulteriore ipotesi: più stanze degli orrori, tutte, però, al piano terra.

Celle di isolamento del penitenziario Carmelo Magli di Taranto.
«A me non è mai capitato, ma bastava un banale pretesto per essere scaraventati nella “cella zero”. In carcere esistono delle regole da rispettare: è vietato passare qualsiasi cosa da una cella all’altra. Ci sono poliziotti che chiudono un occhio e permettono di passare sigarette o anche vestiti, scarpe. I problemi sopraggiungono quando tra i sei, sette agenti di polizia penitenziaria in servizio c’è anche la squadretta: “ciondolino”, “melella” e “piccolo boss”, il più pericoloso, perché picchia forte. Allora un errore, come passarsi una sigaretta da una cella all’altra o uno sguardo sbagliato, possono costare caro. La punizione arriva impietosa. Si spalanca l’orrore della cella zero. Chi è in carcere da molto tempo queste cose le sa, ma per i nuovi arrivati il pericolo è maggiore e diventano più facilmente le vittime delle belve umane». Piero non rivela la sua identità: «Non si sa mai se nella vita dovessi ritornarci e la “squadretta” potrebbe riempirmi di botte».
Analoghi inquietanti scenari anche nelle parole di un altro detenuto, che lasciano trapelare una realtà infernale, fatta di corpi violati e abusi di potere. «Sono uscito a fine marzo dal carcere di Poggioreale. È uno schifo. È peggio di un canile». Queste le prime, drammatiche parole di Tony Sciarra, emigrato in America all’età di dodici anni per raggiungere i suoi genitori che avevano lasciato l’Italia quando lui aveva due anni, mentre lui era rimasto in collegio. Il suo ritorno in terra natia, nell’agosto del 2004, per curare le proprietà agricole della famiglia. Poi il carcere. La prima volta nel 2006, nell’istituto di Santa Maria Capua Vetere, nel casertano. A Poggioreale Tony arriverà solo nel marzo del 2013 per uscire esattamente un anno dopo.
«Negli Stati Uniti la “bella vita” per me non è durata a lungo. Mio padre me lo diceva. E da un giorno all’altro i soldi facili, la droga, mi hanno portato dietro le sbarre. Sono stato rinchiuso nel Federal Correctional Complex Allenwood, la prigione federale della Pennsylvania. Poi è stata la volta del penitenziario di New York. «La ferocia che ho visto a Poggioreale non l’ho vista da nessuna altra parte. Solo una volta mi dissero di andare nella “cella zero”. Era dicembre scorso. Avevo avuto un problema con un agente di polizia penitenziaria. Ero nel padiglione Salerno. Quella stanza è un luogo atroce, dove cominciano a picchiarti e inveire su di te con tutta la loro rabbia e violenza. Non auguro a nessuno, neanche al mio peggior nemico, di finirci. La mattina dopo, ricordo, alle 7.30, dovevo, insieme ai miei compagni di cella, stare in piedi vicino la mia branda, in onore del passaggio della direttrice, del “piccolo boss” e dell’ispettore. È vero, abbiamo sbagliato e dobbiamo pagare, ma dovremmo essere trattami come umani».
Ed è proprio l’umanità violata, offesa, quella che emerge dai racconti delle vittime di un sistema di sopraffazione, che continua a perpetrarsi. Ex-detenuti che parlano per la prima volta e raccontano la loro esperienza quali protagonisti diretti di una realtà che si fatica a pensare possibile. Loro non si fidano più delle istituzioni come garanti dei loro diritti ed hanno scelto di non denunciare agli organi competenti quanto visto e subito. Ci sono altri loro compagni che vivono nella paura di denunciare.
«Nella maggior parte delle carceri italiane l’amministrazione penitenziaria e gli stessi agenti fanno di tutto perché non si sappia che all’esterno ex-detenuti hanno denunciato quel “modus operandi” fatto di violenza interno al carcere. Non si fanno circolare nemmeno giornali che possono parlare di detenzione e di quello che avviene nei penitenziari. Lo fanno per non alimentare possibili reazioni nei detenuti, che potrebbero acquisire coraggio e prendere coscienza dei loro diritti». È la testimonianza di Florisbela Inocencio de Jesus, cinquantotto anni, brasiliana, ex-detenuta nel carcere di Capanne a Perugia, dove si trovava per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Florisbela è autrice del libro autobiografico “Passeggiando con Amanda”, che racconta la vita dietro le sbarre della giovane americana Amanda Knox, accusata in primo grado di essere concorrente nell’omicidio, insieme a Raffaele Sollecito, della studentessa inglese Mederedith Kercher, avvenuto la notte del primo novembre del 2007.
Florisbela ricorda con orrore e sdegno la realtà carceraria: «Il carcere è un mondo a sé. Gli agenti di polizia penitenziaria fanno quello che vogliono e alcuni se ne approfittano e abusano del loro ruolo. Hanno le loro regole e nessuno dice niente. È uno schifo». Ancora parole taglienti, parole dure verso un sistema scandito da regole ben precise, che non sono quelle della legalità.
Un copione che sembra ripetersi a qualsiasi latitudine geografica, da Taranto a Poggioreale, a Perugia. Tra ombre, smentite e conferme. Sono più di novanta le denunce per maltrattamenti subiti nel carcere di Poggioreale rilasciate alla Procura partenopea da Adriana Tocco, la garante dei diritti dei detenuti. Testimonianze scritte, di detenuti ed ex-reclusi, che hanno portato all’apertura di un’inchiesta condotta dal pm Pietro D’Avino nel mese di gennaio per far luce sui presunti aguzzini di Poggioreale e sulla famigerata “cella zero”.
È un dato inconfutabile che i racconti dei detenuti si assomigliano tutti e disvelano una trama dell’orrore, che potrebbe costituirsi di più livelli, oltre quelli più apparenti e tangibili. Una trama ancora più pericolosa, perché ben radicata e articolata in tutti gli ambienti amministrativi. Trapela dalle parole degli ex detenuti una “cupola” del sopruso che avvicina tutti i vertici della gerarchia istituzionale e perciò più difficile da smantellare.
da PopOff
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.