
La parola all’Internazionale
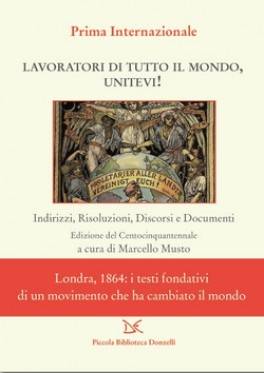 Saggi. I discorsi e le soluzioni nei diversi mondi del lavoro, a partire dalla storia della più grande esperienza collettiva. In un libro pubblicato da Donzelli, a cura di Marcello Musto
Saggi. I discorsi e le soluzioni nei diversi mondi del lavoro, a partire dalla storia della più grande esperienza collettiva. In un libro pubblicato da Donzelli, a cura di Marcello Musto
Fra le iniziative assunte in occasione del 150° anniversario della fondazione dell’Associazione Internazionale dei Lavoratori, questo volume, Prima Internazionale, Indirizzi, Risoluzioni, Discorsi, Documenti, a cura di Marcello Musto (Donzelli, pp. XVI-256, euro 25) si distingue per due obbiettivi, entrambi raggiunti. Una messa a punto della ricerca attuale su questo fondamentale episodio della storia dei mondi del lavoro e una sua riproposizione come esperienza esemplare che ritrova nel presente una nuova attualità.
Tra gli anni ’50 e la fine dei ’70 infatti la storiografia aveva infatti raggiunto una compiuta conoscenza delle fonti della I e della II Internazionale, anche grazie agli archivi di fondazioni europee fondamentali quali l’International Institute of Social History di Amsterdam e la Fondazione Feltrinelli di Milano. A lungo questa conoscenza si è concentrata – come ricorda Musto – sulla centralità del marxismo, sull’adeguamento o l’allontanamento da una presunta o reale ortodossia con, sullo sfondo, un rapporto finalistico con la formazione dell’Internazionale comunista.
OLTRE L’ILLEGALITÀ
Partendo dalla conoscenza approfondita di quella preziosa massa di ricerche, il lavoro di Musto mette in luce il ruolo dell’Internazionale come esperienza collettiva e sociale. Ed è significativo che anche la ripresa di interesse per la II Internazionale stia prendendo strade che non hanno a che fare con il «fallimento» o il «tradimento» del ’14 ma individuano sulla scorta del vasto e fondamentale cantiere aperto da Georges Haupt le continuità fra le cosiddette I e II Internazionale proprio come luogo di incontro di esperienze collettive. Musto è docente di sociologia teorica e questa conoscenza della densità sociale delle organizzazioni politiche e delle loro teorie è all’opera nel volume e nella sua bella introduzione.
L’Internazionale sorge in anni di grande espansione economica, ma in cui questa fiduciosa vitalità non si era ancora tradotta in conquiste stabili dei lavoratori. Molto lentamente le organizzazioni rivendicative usciranno dall’illegalità negli anni ’60-’80 con l’eccezione del Regno Unito (in cui esse erano legali dal 1824, ma in cui le pratiche di difesa degli scioperi erano ancora punite con carcere e deportazione). In molti paesi europei lo sviluppo della grande industria aveva reso satelliti e subalterne le manifatture e le piccole imprese creando le condizioni per l’affermazione di una vera e propria classe operaia moderna, ma la fonte delle sue capacità contrattuali restava il mestiere. Le sole organizzazioni quasi sempre legali erano le società di mutuo soccorso e le cooperative.
LE LOTTE SOCIALI
Anche se Marx ed Engels semplificavano dicendo che nessun operaio era stato owenita o sansimoniano, certo non furono i circoli di studio e i fantasiosi progetti di riforma «socialista» a dare voce ai lavoratori, ma quelle organizzazioni mutualistiche e cooperative che molto spesso diventavano anche luoghi di finanziamento e organizzazione clandestina degli scioperi. L’intreccio di tutte queste pratiche che coesistevano nella vita quotidiana dei lavoratori insieme alla centralità dello sciopero caratterizza la vita dell’Internazionale e ne costituisce la ricchezza.
Fra i gruppi aderenti all’Internazionale ci sono, su un piano di parità, cooperanti, mutualisti, sindacalisti, gruppi di studio, e anche i nascenti partiti operai. Il volume ricostruisce l’intelligente opera di Marx nell’associare la radicalità nell’analisi della società e nelle prospettive ultime a una grande capacità di tenere insieme queste esperienze diverse a patto che rifiutassero le pratiche delle sette clandestine.
Negli anni «senza l’Internazionale», dopo il 1872, e nella stessa II Internazionale che pure nelle intenzioni dei suoi fondatori doveva formare dei dirigenti che sapessero distinguere le diverse funzioni (sindacato, cooperativa, partito, gruppo parlamentare di un partito socialista) i militanti continueranno a «sovrapporre» queste funzioni, fondando una cooperativa per finanziare uno sciopero, chiedendo al Bureau socialiste international di occuparsi di evitare le migrazioni in luoghi dove era in corso uno sciopero… le carte del Bureau attestano questa feconda continuità.
La raccolta di testi documenta proprio la vastità dell’impegno degli internazionalisti: il lavoro e le sue trasformazioni, il ruolo delle lotte sindacali, la cooperazione, la guerra, la questione irlandese e gli Usa, il ruolo dello stato e e quello dell’autorganizzazione politica per il presente e per la costruzione di un futuro di collettivizzazione dei mezzi di produzione.
Come osserva Musto, non è (solo) la rigorosa critica di Marx ma gli operai stessi a mettere in scacco il proudhonismo con una tenace attività di organizzazione degli scioperi che sono il segno distintivo dell’Internazionale. Il volume segue le vicende dell’AIL dopo la Comune e la conclusione della sua storia organizzativa provocata più dalle trasformazioni oggettive, l’inizio della lunga depressione, il ruolo crescente dei partiti nazionali, che dalla volontà di Marx di contrastare l’affermazione di forme associative settarie e del bakunismo.
VECCHIE E NUOVE STORIE
Ma il volume vuole anche suggerire un’attualità di quelle vicende. Secondo Marx il sindacalismo, essenziale perché gli operai imparassero ad autorganizzarsi, non avrebbe potuto migliorare stabilmente le loro condizioni all’interno del modo di produzione capitalistico. Oggi dopo un secolo di compromessi avanzati i processi che semplificando chiamiamo di mondializzazione ci ripropongono – certo in forme nuove — l’identificazione della condizione di salariato con quella di povero e di precario.
Queste non sono dunque «vecchie storie» ma esempi di un percorso di emancipazione la cui attualità è indicata da Musto nella conclusione del volume – insieme e filologico e militante – con l’inno dell’Internazionale nella versione di Franco Fortini: «non vogliam sperare niente/il nostro sogno è la realtà».
Maria Grazia Meriggi – il manifesto
Fonte
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.


















