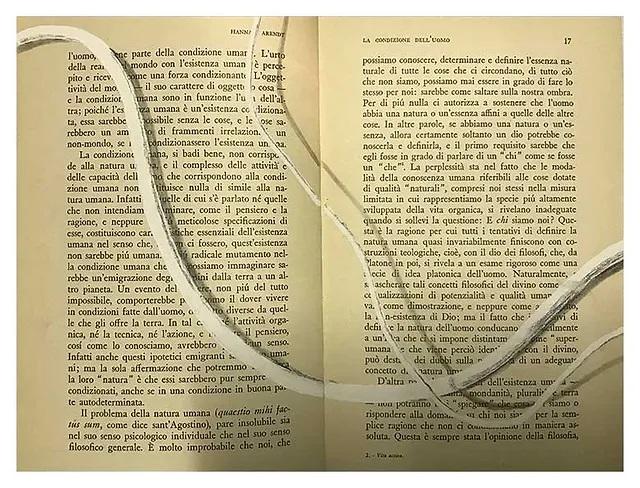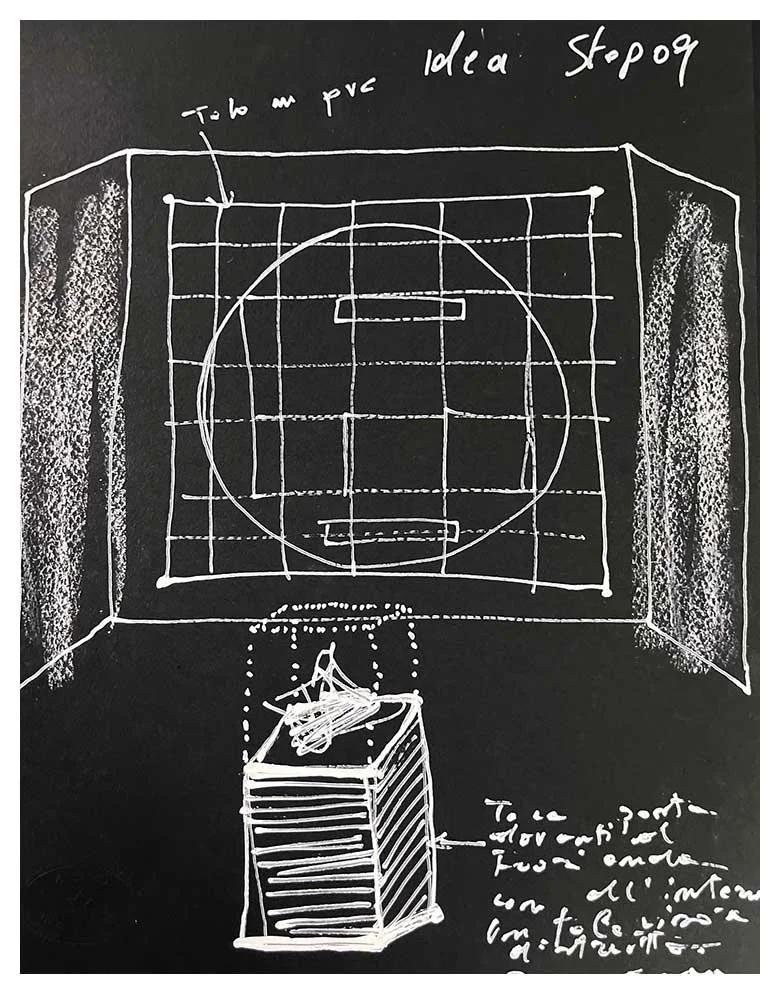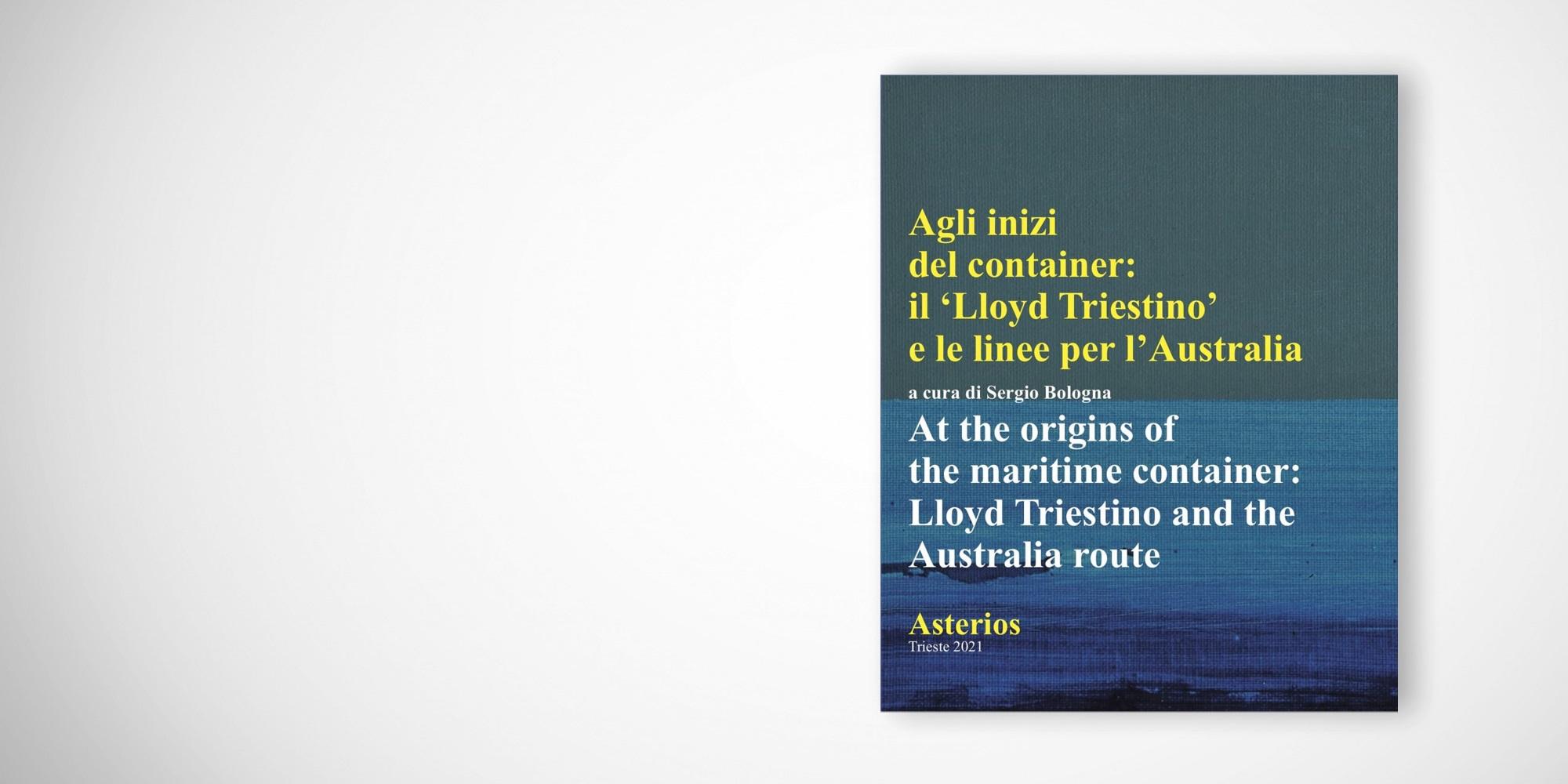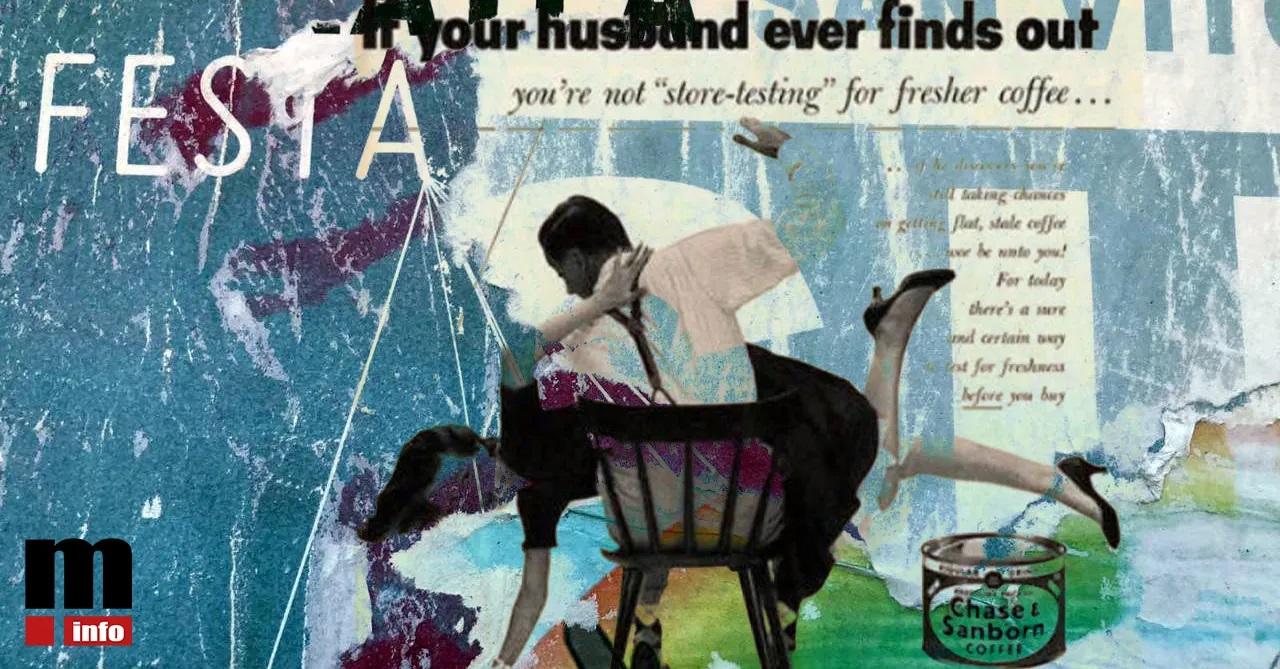
Sulla figura di Danilo Montaldi
Sulla singolarità intellettuale e politica di Danilo Montaldi è stata dedicata, nel maggio del 2003, una giornata di studi a Cremona, sua città natale.
Gli atti di quel seminario, curati da Gianfranco Fiameni, sono stati pubblicati nel 2006 nella collana edita dalla Biblioteca Statale della stessa città. Nel volume, dal titolo “Danilo Montaldi (1929-1975): Azione politica e ricerca sociale”, sono raccolti molti contributi che spaziano da semplici ricordi di compagni a ricostruzioni di alcuni aspetti del pensiero e della pratica militante di Montaldi. Tra questi, abbiamo scelto di pubblicare il saggio di Sergio Bologna dal titolo “Sulla figura di Danilo Montaldi come crocevia di generazioni” (pp. 35-46) nel quale viene posto l’accento sul valore politico del suo agire militante e sulle sue intuizioni e sperimentazioni condotte attraverso le inchieste sulla «nuova classe operaia».
Danilo Montaldi è stata una figura complessa di militante comunista. Negli anni Cinquanta è stato un punto di riferimento e di contatto fra la realtà italiana e l’esperienza francese di Socialisme ou Barbarie e quella olandese Spartacus. I suoi lavori hanno un carattere pionieristico nel campo della storia orale del sottoproletariato e degli emarginati e hanno contribuito alla riscoperta della centralità e della vita quotidiana delle classi subalterne.
Attraverso il suo originale metodo d’inchiesta – che sarà poi meglio definito da Romano Alquati «conricerca» – e il suo rapporto diretto con «la classe», riuscì a dare voce e volti agli invisibili. Nel caso di Montaldi però, la «conricerca» è strettamente legata all’oralità e ad una dimensione autobiografica, una metodologia che lo avrebbe avvicinato a Gianni Bosio nel campo della storia orale. La sua è una ricerca dal basso sulla soggettività dei subalterni.
Per la casa editrice Feltrinelli pubblicò nel 1960 il suo primo libro “Milano, Corea”, un’inchiesta sull’immigrazione interna e sulla condizione operaia. Si tratta di 32 storie di «sottoccupati», immigrati a Milano. Le interviste sono raccolte da Franco Alasia, operaio alla Breda. Gli intervistati vengono dai disordinati insediamenti spontanei delle periferie milanesi, in gergo chiamati «coree», quartieri (chiamati così perché erano comparsi al tempo della guerra di Corea) che gli immigrati si costruivano da sé nelle aree rurali dell’hinterland. Le Coree venivano tirate su senza seguire i regolamenti edilizi, e nei primi anni mancavano dei servizi fondamentali: strade, elettricità, acqua. Agli inizi degli anni ‘60 c’erano circa 70.000 persone che vivevano nelle coree di Bollate, Cinisello Balsamo, Limbiate, Quarto Oggiaro e altre zone dell’hinterland milanese. Le storie, trascritte quasi alla lettera, sono di ogni tipo: manovali in transito da un’impresa all’altra, braccianti del Sud prestati all’edilizia, ambulanti abusivi, ma anche prostitute e pederasti. Si tratta di una marginalità figlia della modernità e dello sviluppo capitalistico dell’Italia del boom economico del dopoguerra.
Montaldi nel fare «conricerca» con operai, braccianti, ex carcerati, ladri, prostitute, militanti politici di base, aveva saldo un riferimento, quello del pensiero marxiano che oggi sembra venuto meno e che dava un indirizzo a quel suo semplice metodo di isolarsi a due, con un quaderno e una penna, oppure con un registratore, e tirarci dentro, fuori dai denti, da compagni, senza censure interiori, né scrupoli di venire censurati da altri.
* * * * *
Cercherò di spiegare le ragioni e le dinamiche che hanno portato Danilo Montaldi a rappresentare una figura nella quale viene a compimento una certa cultura comunista e dalla quale si dipartono le molte strade della «nuova sinistra» occidentale. Perché la figura di Danilo rappresenta questo crocevia e dunque è in grado di comunicare con la generazione della Resistenza e con quella degli anni Sessanta con eguale naturalezza e ricchezza di spunti? Perché la figura di Danilo è vissuta come quella di un «fondatore», come qualcuno che ha indicato nuove direzioni di pensiero politico pur non avendo costituito lui mai un’organizzazione, essendosi rifiutato di aderire a gruppi o riviste come «Quaderni rossi» o «Classe operaia» o altri, avendo sempre preferito agire nei ristretti confini di una cerchia di amici?
Una prima risposta è quasi ovvia. Danilo aveva un profondo senso della storia e sapeva che non può esservi coscienza del presente senza un paziente e appassionato filtraggio degli eventi storici. Sapeva che non possiamo ordinare il nostro assetto mentale in modo da affrontare il presente se prima non abbiamo trovato una convincente lettura del recente passato. In realtà non si tratta di un prima» e di un «dopo», ma di una tensione permanente tra ieri e oggi. Leggiamo un documento storico, un libro di storia e di colpo qualcosa ci riporta al presente, ci rende chiaro un aspetto della realtà, ci scopre angoli nascosti oppure viviamo un’esperienza e di colpo una piega del passato, una ruga della storia che nor riusciti a distendere ci appare chiara. Quando abbiamo fondato la rivista «Primo Maggio» e sulla quarta di copertina abbiamo riportato quelle frasi che volevano esplicitare il nostro punto di vista, frasi come «una rivista di storiografia militante non solo sceglie i temi entro periodi ben definiti della lotta di classe, ma scopre in quelli un filo conduttore che riporta immediatamente ai problemi del presente» e simili – pensavamo all’insegnamento di Danilo.
1.
Ma dire storia non dice nulla. il passato recente con cui Danilo intendeva fare i conti era quello del comunismo. «Fare i conti», «regolare dei conti», non ricostruire. L’intenzione di Danilo non era di tipo storiografico, non era una nuova «scuola storica» che egli intendeva costituire o un cenacolo di giovani storici che riscrivessero la storia del Pci. Non confondeva il mestiere dello storico con quello che è invece il bisogno vitale del militante, intendendo per militante quella persona che ritiene di poter stare bene al mondo solo se sta in mezzo ai desideri di liberazione o di autonomia degli altri, in mezzo ai conflitti, dalla parte di quelli che di solito perdono ma talvolta possono anche avere la meglio. Qual è la cosa importante che Danilo è riuscito a fare? È riuscito ad avvicinare queste due figure deontologicamente assai distanti tra di loro, quella dello storico e quella del militante, al punto di toccarsi e a rendere sottile sottile, ma non impercettibile, la linea che le separa. «Fare i conti» significa ritornare su avvenimenti noti e provare a leggerli con occhi diversi; non è quindi in prima istanza un lavoro di «scoperta» o un lavoro sulle fonti, è la ricerca di un quadro mentale coerente composto di pezzi di esperienza vissuta e di lettura del passato. «Fare i conti» e in particolare fare i conti con il comunismo significa innanzitutto prendere distanza dalla lettura che il comunismo ha dato di se medesimo, quindi dalla storiografia comunista. Questo è il passaggio più delicato ma anche quello decisivo. Per «fare i conti» sia con una storia – cioè con una serie di eventi noti – sia con una storiografia occorrono categorie di pensiero sofisticate, occorre possedere già strumenti analitici e visioni d’insieme, per non dire quadri ideologici. Il modo con cui Danilo si scosta dalla storiografia comunista è molto semplice, quasi banale. Per lui non esiste «il comunismo» ma «i comunismi». Il documento del gruppo bordighista di vattelapesca acquista per lui lo stesso valore storico-politico di una risoluzione del Comintern, ambedue fanno parte del grande fiume della storia del comunismo.
Danilo non si schiera, dà cittadinanza a coloro cui era stata negata e con questa semplice mossa spiazza una storiografia che prigioniera dell’alternativa ortodossia-eresia – aveva di fatto cellato uomini ed eventi dalla memoria, lasciando dietro di sé una lunga fila di tombe senza nome. A questo punto la narrazione di Danilo si anima di figure nascoste, dando dignità ai gruppi considerati «eretici», alle correnti che erano state espulse dall’organizzazione, ai ribelli che pur avevano continuato a considerarsi comunisti e a lottare contro il nazifascismo benché considerati «traditori». Si fosse fermato a questo, Danilo sarebbe stato classificato come uno storico «scalzo» appartenente a una delle tante correnti «eretiche» del comunismo. Il punto, a mio avviso decisivo, è un altro, il suo percorso non finiva qui. Per questi sentieri, non praticati dagli storici, egli è riuscito a strappare dall’oblio «i militanti di base», è riuscito a guardare dentro le viscere del Partito e a ricostruire una storia nella quale il Partito e la sua Direzione vivono in una tensione permanente con gli uomini e le donne che ne formano la cosiddetta «base». Questo, molto schematicamente, è il per corso originale di Danilo. Se si fosse limitato a rileggere la storia del comunismo o semplicemente del Pci con schemi di interpretazione, per esempio, internazionalisti sarebbe stato classificato come uno che aveva preso partito nella disputa tra Lenin e Bordiga, come un epigono della storia del comunismo della prima metà del Novecento. Danilo invece era uomo della seconda metà del Novecento, a lui interessava capire fino a che punto il comunismo, preso nel suo insieme, ortodossi ed eretici compresi, fosse o meno riuscito a dare risposta alle istanze di liberazione di quella gente alla quale lui teneva più di tutto, della quale si sentiva parte, gente che continuava a esistere con le stesse speranze e avrebbe dovuto continuare a lottare per vederle compiute. Era lì che Danilo voleva arrivare, non perché trascurasse i grandi eventi o fosse così ingenuo da considerare secondari i gesti e le decisioni dei gruppi dirigenti, ma perché alla fine tutto il lavoro di rilettura del passato, lo scavo dentro la razionalità di quell’artefatto umano che è il Partito, a questo dovevano servire, a dare una risposta al militante di base che più di una volta si era chiesto se quel Partito al quale aveva sacrificato parte della sua vita in realtà non lo stesse fregando.
2.
Abbiamo detto che Montaldi non era uno storico, nel senso che non aveva le intenzioni dello storico, non era così superficiale da confondere il lavoro di costruzione di una «mente politica» con il lavoro di chi cerca negli archivi ciò che altri non hanno trovato. Abbiamo detto che in prima istanza Montaldi si misura con fatti noti, anzi con eventi che sembravano aver trovato una sistemazione definitiva nella memoria politica, sui quali non valeva la pena di tornare, eventi e giudizi che non era il caso di rimettere in questione. Il metodo che lui applica, passando prima dai «comunismi» e arrivando poi allo strato dei «militanti di base», gli consente invece di giungere a vere e proprio «scoperte», cioè di trovare una serie di eventi non noti, di mettere allo scoperto figure nascoste, introducendo in tal modo nella storia del comunismo un’altra dimensione. ll suo approccio quindi, volutamente non storiografico ma politico, lo porta a risultati più fecondi di quelli dello storico tradizionale, perché gli consente di aprire una nuova dimensione dell’interpretazione storica e quindi di suggerire un programma di ricerca. È caratteristica di figure come quella di Montaldi quella di saper aprire una pista, indicare una direzione, suggerire un orizzonte mentale, stimolare una nuova narrazione. Questa è la caratteristica che affascina i giovani degli anni Sessanta. Poter dire la loro su una storia, quella del comunismo, che veniva offerta come paradigma modificabile solo nei dettagli. In questo modo Montaldi li coinvolge in questa storia, li tira dentro, non permette a loro di sentirsi figli dell’«Anno zero» (tentazione comune a tutte le generazioni che non vogliono assistere passivamente al trascorrere della loro esistenza). Montaldi getta sulle loro spalle un’eredità non voluta. Ora dobbiamo sottolineare però l’altra faccia di questo procedere. Danilo non solo restituisce voce e identità a figure che la storiografia di Partito aveva reso irriconoscibili ma consente a queste figure di porsi come modelli, sia pure parziali, da imitare. Assegna a queste figure un ruolo di detentori di patrimoni di esperienza rispetto ai quali le giovani generazioni non possono essere indifferenti. Cerco di spiegare così il ruolo di crocevia, di ponte, che la figura di Montaldi ha svolto.
3.
Siamo arrivati a mettere a fuoco due terreni sui quali Montaldi riesce a coinvolgere le nuove generazioni nella storia del comunismo. Il primo terreno è quello di un «programma di ricerca» sul Partito e sulle lotte dei suoi militanti, l’altro terreno è quello dei patrimoni di esperienza politica incorporati in certe figure. Sono due piste da seguire, due orizzonti culturali, che si offrono a chi vuole ristabilire con il passato un rapporto coerente con le sue scelte nel presente. Danilo quindi non elargisce un sistema di convinzioni politiche, non è un «cattivo maestro», non è un ideologo, non è un maitre à penser, non dà la linea, non battezza discepoli, non consacra adepti, non mette sul piatto una vivanda da trangugiare – fosse anche la più genuina. Eppure è riuscito a esercitare un’influenza che molti personaggi che si sono prefissi ruoli di leadership non sono riusciti ad avere. Danilo ti apre una pista e ti lascia libero di seguirla, non ti dice nemmeno che quella è la pista giusta se vuoi farti una«mente politica», ti dice solamente che la dimensione nuova con cui lui ha letto la storia del comunismo gli ha consentito di acquistare un’autonomia di giudizio e una possibilità di pratica politica non eterodiretta. Se t’interessa, puoi provarci anche tu. In pratica significa che puoi fare politica, puoi agire pensando di cambiare l’ordine delle cose, anche senza un Partito alle spalle Questo suggerimento, questa «imbeccata» che Danilo ti dava, non potevano non trovare un terreno fertile in una generazione che rifiutava la delega, che chiedeva di porre la soggettività al primo posto. La grande differenza con concezioni «spontaneiste» consisteva però nel fatto che Danilo non ti diceva di partire da una condizione di «tabula rasa», da una assenza di memoria, da una verginità politica artificiosa. Al contrario, ti diceva che non facevi un passo avanti se non avevi fatto i conti con la storia del comunismo, anzi, dei comunismi, meglio, dei comunisti. Non era quindi, il suo, un rifiuto anarchico del Partito, un gesto di ribellione verso sistemi gerarchici, era la ricerca di una strada all’apprendimento della pratica politica senza frequentare i corsi del Partito. Erano precetti di autoformazione. Chiedersi pertanto se Montaldi avesse o meno una sua idea di Partito o di organizzazione politica formalizzata è porsi una domanda sbagliata. Il problema della storia del Novecento, dal lato della rivoluzione o più semplicemente del conflitto di classe o, ancor più genericamente, delle lotte sociali, troppo spesso viene identificato con il problema della «giusta linea» del Partito e questo non solo nella storiografia dell’ortodossia comunista ma molto di frequente anche nella storiografia o più in generale nella letteratura politica dei gruppi di sinistra radicale. «Se la strategia fosse stata diversa…», «se il gruppo dirigente avesse deciso altrimenti…», «se Togliatti fosse stato un rivoluzionario…». La metodologia dei «se» non interessa Montaldi perché è al di fuori del suo orizzonte mentale concepire il Partito come un aereo o un treno che ti porta a destinazione, se guidato da piloti determinati ad arrivare alla méta (oppure viceversa un aereo o un treno che ti porta dove non volevi andare, perché i piloti hanno cambiato idea o non se la sentivano di affrontare un passaggio rischioso). Dopo Trotsky, dopo Rizzi, ogni persona di buon senso – ma ahimè è proprio questo che sembra merce rarissima in certi ambienti che abbiamo conosciuto – considera il Partito non come una macchina da guerra, un Leviatano, o, viceversa, una somma di speranze e attese collettive, ma – laicamente – come una «formazione sociale» dentro la quale ci sono interessi diversi per ruoli diversi e strati sociali diversi che non parlano un linguaggio esplicito e pertanto non si rivelano per quello che sono, con progetti divergenti e aspettative differenti, ma parlano un metalinguaggio che copre le differenze, comunicano per codici che cancellano l’espressione della soggettività. Il Partito quindi può «simulare» l’interesse collettivo, può «apparire» come la manifestazione di questa collettività, ma nei fatti non può che rispondere alle sollecitazioni di chi aspira a un potere personale, non puó che trovare dei compromessi tra le aspirazioni di potere del gruppo dirigente e il soddisfacimento di certi bisogni della cosiddetta «base». Danilo Montaldi, a me pare, non aveva un’idea di Partito, non si chiedeva se la forma Partito della tradizione comunista fosse quella buona, non credeva che la rivoluzione fosse possibile azzeccando il Partito giusto, non confondeva la tessera d’iscrizione con un biglietto aereo, non credeva che il Partito fosse una roba che ««porta» da qualche parte. Leggeva i destini e le scelte del Partito oltre i suoi metalinguaggi, i suoi codici, le sue formule rituali, badava al sodo, si chiedeva «cosa dà il Partito alla gente che ci sta dentro?», A dirla con le buffe espressioni in voga oggigiorno «che valore aggiunto ti dà il Partito?». E ti sapeva dimostrare che dietro una domanda del genere, che può sembrare espressione di puro gretto egoismo, ci stanno in realtà dinamiche complesse, e ti insegnava che in definitiva solo il comunismo ha saputo esplicitare l’enorme complessità che sta dinanzi al semplice voler star meglio della gente (o alla semplice aspirazione di potere di un gruppo dirigente). Il Partito quindi come un artefatto complicato, una formazione sociale che necessita di chiavi di lettura sofisticate se vuoi starci dentro senza restarne schiacciato o impoverito o se vuoi starci fuori praticando una militanza dove te lo trovi tra i piedi ogni momento a dichiarare la sua unica (e indiscutibile) legittimità a fare politica. Danilo Montaldi, a me pare, non si è mai posto il problema del Partito nel senso «qual è il Partito giusto?», non ha mai perso tempo a pensare a una «teoria del Partito» – come purtroppo è accaduto a tanti imbecilli che sono finiti tutti male ed hanno fatto fare brutta fine a molti di più che li avevano seguiti.
4.
Prima di passare al secondo punto, ai militanti politici di base come detentori di patrimoni di know how politico, è opportuno porsi un’altra domanda, questa a mio avviso ben giustificata e pertinente: «Se Montaldi non aveva un’idea o una teoria del Partito, aveva un’idea o una teoria della classe operaia?» La risposta qui non si presenta facile. Pertanto quella che propongo è piuttosto una pre-risposta. Punto primo: chiunque abbia fatto propria la teoria di Marx, chiunque abbia fatto degli scritti di Marx una piattaforma fondamentale del suo modo di pensare, chiunque l’abbia capito e interpretato come un pensatore politico (e non come un economista) e penso che Montaldi fosse tra questi – un’idea ben precisa della natura, del ruolo e della struttura interna della classe operaia non può non averla, anzi ne ha un’idea così completa che è in grado di comprendere anche le forme moderne di lavoro flessibile, indipendente, cognitivo e che dir si voglia. Non riesco francamente a trovare un pensatore che abbia colto in maniera così lucida e analizzato con tanta profondità il problema del lavoro subordinato quanto Marx. Molte delle sue teorie sulla dinamica del capitalismo possono essere superate o imprecise, la capacità del capitalismo d’innovare e di cambiare forma è tale che non poteva che essere così ma il rapporto tra capitale e lavoro è solo quello che Marx ha decodificato, l’essenza di questo rapporto è quella che Marx ha fissato nelle sue opere, altri dopo di lui potranno aver aggiunto specificazioni di straordinaria perspicacia, si pensi alla sociologia di lingua tedesca degli anni Venti e Trenta, ma nessuno ha intaccato la sostanza delle tesi marxiane sul lavoro. Ma dire lavoro e dire classe operaia non è la stessa cosa. Potremmo ricostruire la storia del Novecento come la storia della continua tensione tra un processo di formazione di un gruppo sociale omogeneo chiamato classe operaia e un parallelo processo di disgregazione e frammentazione di questo gruppo sociale, tra uno sforzo di ricomposizione e di acquisizione di un’identità politica e una continua ricerca d’ingabbiamento e/o di de-composizione da parte dello Stato e da parte delle forze economiche dominanti. Montaldi lo aveva ben presente questo elemento, sapeva quindi che con il Novecento si assiste, è vero, ai momenti più alti di autonomia e unità interna alla classe operaia, ma si assiste anche ai momenti più cupi di passività, di perdita d’identità, di rottura interna. La classe operaia, nei primi trent’anni del Novecento è il soggetto principale delle invenzioni istituzionali. Il welfare state, l’apparato previdenziale – messi in atto da tutti i regimi politici, dagli Stati Uniti all’Unione Sovietica agli Stati fascisti – sono risposte all’assunzione di identità politica della classe operaia. Ma le tre grandi correnti di pensiero politico di quell’epoca – la corrente democratica social-liberale, la corrente comunista e la corrente nazifascista – entrano nel corpo della classe operaia e la dividono, la spezzano e la tragedia della Seconda guerra mondiale vede operai massacrarsi a vicenda, a milioni. L’idea di classe operaia che Danilo Montaldi può avere, dunque, è quella, realistica, di una corpo sociale diviso al suo interno, ferito, incapace di agire come collettività. Quindi una teoria della classe operaia non gli serve, lui guarda a quei territori rimasti ancora integri, a quei militanti politici di base che detengono il patrimonio più prezioso, ossia la consapevolezza che se ce un’azione da fare, un programma politico da perseguire, al quale dedicare tutti i propri sforzi come persone e come lavoratori, è quello di ricomporre un tessuto sociale operaio, di ristabilire una solidarietà, uno stesso modo di pensare, di interpretare il mondo, è quello di riacquistare l’identità perduta, di riprendersi l’autonomia non solo dallo Stato e dal capitale ma anche dal Partito. Pertanto io non credo che Montaldi avesse in mente una teoria della classe operaia. In generale il suo stile di scrittura, i generi letterari che egli predilige, non sono propri del «teorico», il suo linguaggio è diverso, è piuttosto un saggista con forte senso della storia, quindi la sua attenzione è concentrata sulla razionalità degli eventi e sulla profondità dell’esperienza umana. Se sceglie di occuparsi dei militanti politici di base e non di teorie astratte sulla classe operaia significa che pone al primo posto di ogni ragionamento politico la persona umana, in carne e ossa, non un’astrazione concreta. Egli cerca prima il volto di un uomo, la sua parola, la sua storia e poi cerca in quell’uomo la funzione politica. Anche questo aspetto lo rese molto vicino alle aspirazioni dei giovani degli anni Sessanta, non solo per il rilievo dato alla dimensione soggettiva e individuale, come ho già detto, ma perché rendeva accessibile e palpabile una tradizione, una memoria che altrimenti avrebbe dovuto essere recuperata attraverso delle formalizzazioni storiografiche e politiche. Questa «presa diretta» con un passato che poteva essere ancora «fonte di molto presente» rendeva la metodologia montaldiana convincente agli occhi delle nuove generazioni.
5.
La ricerca di patrimoni di sapere politico presso militanti che le avevano viste tutte, soprattutto presso i «minoritari», i fondatori o appartenenti a gruppi marxisti o a gruppi comunisti «eretici», a gruppi anarchici, a gruppi consiliari, è stata costante in Montaldi. Era riuscito in tal modo a costruire una fitta ragnatela di rapporti internazionali. Da questo punto di vista è stato uno dei primi praticanti della globalizzazione. Quale poteva essere la logica di questa ricerca? Che senso aveva pescare un tizio in una landa sperduta dell’Idaho – faccio per dire – che aveva partecipato a uno sciopero memorabile trent’anni prima o aveva fondato una rivistina dove si dicevano cose intelligenti? Che senso aveva questa ricerca di fossili delle lotte operaie: Aveva, a mio parere, un senso ben preciso. Il movimento operaio nei primi vent’anni del secolo era stato un movimento internazionale, il movimento comunista era stato un movimento mondiale. Occorreva recuperare questa dimensione se si voleva avere una «mente politica» in grado di muoversi. Dimensione che si era perduta con i regimi nazifascisti, con la spaccatura dell’Occidente tra democrazia e dittatura e con la stessa tattica del Comintern che raccomandava ai partiti comunisti di seguire delle «vie nazionali», riservando ai vertici del Partito dell’Unione Sovietica le decisioni di carattere internazionale. Il colloquio con il militante scovato nel paese vicino, testimone di lotte contadine e operaie, che parlava il suo dialetto, era per Montaldi un’operazione che si poneva sullo stesso piano della lettera scritta ai compagni giapponesi (ricordo che fu Danilo a farmi conoscere a Milano un gruppo di militanti dello Zengakuren in visita in Italia), dello scambio di materiali, della trasmissione di conoscenze a migliaia di chilometri di distanza. Anche in questo caso si trattava di recuperare una memoria nella giusta dimensione in cui s’era formata, cioè nella dimensione internazionale. E chiaro quindi che questo approccio aveva a che fare con un’idea ben precisa di classe operaia, a conferma che Danilo Montaldi, pur non avendo formulato alcuna teoria sulla classe operaia, su questo punto la sapeva lunga. Egli tra l’altro non aveva alcun senso di «gelosia» dei suoi contatti internazionali, anche se sapeva per alcuni di essere l’unica persona in Italia ad averli. Metteva volentieri a disposizione di altri questi rapporti, che gli erano costati fatica e dedizione e, per quanto mi riguarda, ne ho approfittato. In questa fitta rete di contatti quelli con il mondo francese svolgevano però un ruolo di assoluta preminenza. Nell’epoca in cui Danilo ha operato principalmente, metà anni Quaranta, anni Cinquanta e Sessanta, la Francia era forse l’unico paese al mondo dove fosse presente in maniera massiccia una «classe intellettuale», dove gli intellettuali avessero un riconoscimento sociale e, particolare non secondario, fossero ancora in grado di produrre idee buone. Danilo trovava in Francia, per essere terra d’asilo, per l’esperienza del fronte popolare, per le vicende del comunismo internazionale che in Francia aveva trovato un punto d’incontro e di scambi e di scontri fecondi, per il sedimento di gruppi che si ponevano i suoi stessi problemi (si pensi solo a «Socialisme ou barbarie»), un habitat ideale. In Francia trovava l’osmosi tra arte, letteratura e politica, la trovava all’interno di un ceto sociale – non all’interno di un Partito, mediata da una burocrazia, come in Italia, Solo dopo gli scontri di Genova del luglio 1960, dopo il primo risveglio di lotte operaie a Torino e Milano nel 1961, si aprì una breccia anche da noi e crebbe un ceto intellettuale libero da ipoteche di Partito, disposto a pensare su nuove dimensioni, con un’industria culturale (case editrici, riviste, centri culturali) in grado di raccogliere e diffondere idee nuove. Fu un fenomeno concentrato a Milano soprattutto, che allora era una città viva, dinamica, pulsante, non lo squallido mortorio di oggi. Danilo ebbe la fortuna di gustarsi tutta la Milano dell’epoca, di viverla da una posizione d’osservazione privilegiata, quella delle case editrici, benché sempre con un piede ben piantato a Cremona.
6.
Siamo giunti quindi al punto dolente, almeno per quanto mi riguarda, di questo percorso. Dobbiamo dare una risposta alla seguente domanda: perché Danilo Montaldi, pur avendo anticipato su tanti terreni le idee e le pratiche di quello che verrà chiamato «l’operaismo italiano» non ha voluto aderire ai progetti di «Quaderni rossi» e di «Classe operaia»? Come ho già riferito in altre sedi, fummo Massimo Paci e io a chiedere esplicitamente a Danilo, nel tardo autunno del 1963, di entrare nel costituendo gruppo di «Classe operaia» dopo che un paio di mesi prima si era consumata la rottura con Panzieri. Se non ricordo male fu un incontro, per discuterne, nel quale non ci mettemmo nemmeno a sedere, la cosa fu risolta, liquidata, da Danilo in pochi minuti sul marciapiede davanti alla sede della Commerciale in Piazza della Scala durante l’intervallo di pranzo, forse Danilo veniva dalla Feltrinelli, che era a pochi passi, e aveva fretta. Eppure allora la pausa degli uffici per il pranzo era lunga, C’era tempo di andare al ristorante, quelli delle case editrici, almeno i funzionari dello staff editoriale, andavano dalle sorelle Pirovini, in via Fiori Chiari, e restavano a tavola fino alle due e mezzo, alle tre. Pochi mesi dopo sarei stato assunto alla Olivetti, Direzione Pubblicità e Stampa, con gli uffici in via Cleri e una sede distaccata in via Baracchini, dove si andava a pranzo nel locale più trendy della Milano impiegatizia e direzionale di allora, «Il dollaro», pasto completo 660 lire, com’era il cambio dollaro-lira del momento. La pausa pranzo durava un’ora e mezzo, due ore, quelle durante le quali Giovanni Giudici, che aveva l’ufficio al piano di sotto al mio, scriveva le sue poesie. Danilo non usò frasi involute per motivare il suo rifiuto, disse semplicemente che non aveva avuto fiducia in Panzieri e non ne aveva in Tronti. Perché? Perché, pur essendo persone integerrime, di grande intelligenza e cultura, non erano a suo avviso persone che perseguivano una prospettiva di rottura con il movimento operaio organizzato, non avevano in mente di creare un’alternativa, erano persone che concepivano la loro azione come un’azione di pressione esterna sul Partito e sul sindacato, pronti a rientrare nei ranghi non appena le istituzioni del movimento operaio avessero dato segni di cambiamento. Egli non credeva che questo cambiamento fosse possibile o, meglio, riteneva che se un cambiamento ci sarebbe stato avrebbe certamente preso una piega opposta a quella auspicata da questi compagni. Una simile presa di posizione non consentiva vie d’uscita o formule di ripiego. Danilo non entrò nel merito delle tesi, del linguaggio, dei contenuti dei «Quaderni rossi» e non ci chiese nemmeno quale fosse il programma di «Classe operaia». Quando uno non ci crede, non ci crede. Noi tornammo a casa un po’ mortificati e un pizzico infastiditi, «ingenui noi ad averglielo chiesto» – credo di aver detto a Paci. La previsione di Danilo si è avverata, dopo due anni «Classe operaia» si sciolse perché Tronti, Asor Rosa e altri decisero di rientrare nel Pci; ma questo non basta a chiudere la questione. La prospettiva che guidava le scelte della maggioranza dei compagni di «Classe operaia» era quella di contribuire alla ri-composizione di classe, di sollecitare e dare un contributo diretto all’autonomia delle lotte operaie, alla formazione di una «mente politica» collettiva. Montaldi non poteva non saperlo, i suoi contatti con Romano Alquati non mi pare si fossero interrotti, poteva conoscere «dall’interno» quel che era successo dentro «Quaderni rossi», non poteva non sapere che c’era sempre stata una tensione tra due anime e una di queste era molto vicina alle sue idee, al suo metodo d’indagine. Che fossimo sulla strada giusta lo abbiamo dimostrato nel ’68-69, senza Tronti e senza Asor Rosa. Le ragioni per le quali Montaldi non aderì al progetto del gruppo, che in quel momento – secondo la mia opinione era il più vicino alle sue idee, possono essere molteplici. Sono ovviamente congetture. Noi eravamo di un’altra generazione e riconoscevamo senza discussioni la leadership e l’autorità di compagni con grande esperienza come Panzieri o come Tronti. Montaldi, a mio avviso, questa leadership non avrebbe potuto accettarla, per ragioni di età e di esperienza. Panzieri era stato un dirigente di partito, aveva ricoperto ruoli di rilievo nel Psi, era stato fortemente influenzato dalle correnti trotskyste, per Dailo- è una congettura – egli forse rappresentava ancora la cultura dei gruppi dirigenti, non quella dei militanti di base. Quanto a Tronti, l’istintiva diffidenza potrebbe essere stata determinata dal modo di ragionare di Mario, tendente alla formalizzazione astratta, alla concettualizzazione dei problemi. Non ricordo che abbia espresso dei giudizi nei confronti di Negri. Ripensandoci oggi, pur comprendendo le ragioni di Montaldi, ritengo che allora abbia sbagliato a tagliare così netto. Non è riuscito a convincerci, nemmeno a metterci una pulce nell’orecchio, sapevamo benissimo che le autorità morali e politiche cui ci affidavamo potevano a un certo punto fregarci ma in quel momento ci davano un grande aiuto, contribuivano in maniera decisiva alla nostra «mente politica», eravamo più attrezzati ascoltando i loro discorsi. Ma non c’erano soltanto i leader, c’erano molte altre figure nel gruppo di «Classe operaia» con storie ed esperienze straordinarie, c’erano dei patrimoni di know how politico, diversissimi tra loro, cui potevamo attingere direttamente. E poi c’era il gruppo, c’era un minimo motore organizzativo, con i suoi effetti di moltiplicatore, con i suoi rapporti umani, alcuni dei quali sono rimasti saldi tutta la vita. Noi non potevamo, non avevamo l’età, per muoverci come «cavalieri solitari», non avevamo l’attrezzatura, avevamo bisogno di un gruppo. La selezione, qualche anno dopo, fu naturale, tra chi si accorse che un gruppo non gli bastava e aveva bisogno di un Partito e chi continuò a sperimentare vie nuove, insolite, a percorrere sentieri non battuti, a mettere in gioco se stessi senza reti di salvataggio. A fallire dicendo «Abbiamo perso» e non, come sarebbe più comodo, dicendo «Ha perso il Partito». A riuscire senza che nessuno te lo riconosca. Montaldi sbagliò quella volta, avrebbe potuto tenere un rapporto esterno, distante, un dialogo a distanza, avrebbe potuto escogitare, senza sforzo, mille modi per «starci». Non volle nemmeno tentare di farlo.
7.
Quel rifiuto tuttavia non intaccò il rapporto di rispetto e di stima che avevo per Danilo Montaldi. Dieci anni dopo, nel 1973 con un gruppo di compagni in parte provenienti dall’esperienza di «Classe operaia» e di Potere operaio, in parte provenienti da altre esperienze, misi mano alla fondazione della rivista «Primo Maggio». Danilo era ancora attivo, non gli abbiamo mai chiesto di scrivere per la rivista, non lo abbiamo – almeno a mia memoria – mai invitato a una riunione. Eppure, per usare uno stereotipo, «il suo spirito aleggiava sopra di noi». Quali affinità con il suo metodo, con il suo approccio ai problemi, c’erano nella concezione della rivista? Evidentemente è un discorso comprensibile solo a chi la rivista l’ha conosciuta, mi scuso quindi con i molti, sempre più numerosi, che non ne hanno mai sentito parlare o ne hanno sentito solo il nome, qualche volta. Volevamo essere una rivista di intervento, volevamo partecipare ai movimenti in corso, volevamo «esserci», senza adottare un tipo di comunicazione ideologica o «opinionistica», volevamo trovare un modo per intervenire che non fosse un metalinguaggio ma una metafora semmai. Scegliemmo il «modo storico». Affine con l’impostazione di Danilo era la convinzione che la conoscenza della storia delle lotte operaie e dei movimenti politici che le hanno accompagnate è determinante per la formazione di una «mente politica», Affine – se non mutuata addirittura – la convinzione che i patrimoni di memoria dei militanti protagonisti delle lotte sono anche tesori di cultura politica. Praticammo quindi una specifica forma di «storia orale». Affine – se non mutuata da Danilo Montaldi – la concezione di una dimensione internazionale dei movimenti di classe e la ricerca a livello dei paesi capitalistici avanzati delle esperienze di democrazia diretta, consiliari. Affine l’interesse per altri paesi le cui caratteristiche storico-sociali assumono valore di paradigma di un’epoca, nel nostro caso non la Francia ma gli Stati Uniti. Affine l’interesse per la storia della classe operaia e per le riflessioni teoriche nella Germania degli anni Venti. Nello spirito di Danilo Montaldi era stata scelta la composizione del gruppo cui era affidato il lavoro di preparazione e validazione degli articoli da pubblicare, una composizione mista di «intellettuali» e militanti operai. Probabilmente altri aspetti del lavoro di «Primo Maggio», che ora non vengono alla mente, potrebbero trovare nella figura di Danilo la fonte d’ispirazione. Ma questo non farebbe che confermare la straordinaria ricchezza delle direzioni di ricerca e delle regole di comportamento che egli ha saputo trasmettere alle generazioni successive. Cerchiamo di far sì che la sua opera non venga dimenticata.
Bibliografia essenziale:
F. Alasia, D. Montaldi, Milano Corea. Inchiesta sugli immigrati (1960)
D. Montaldi, Autobiografie della leggera (1961)
D. Montaldi, Militanti politici di base (1971)
Sono usciti postumi:
D. Montaldi, Korsch e i comunisti italiani (1975)
D. Montaldi, Saggio sulla politica comunista in Italia (1919-1970) – Testo rifiutato dalla Feltrinelli e pubblicato postumo dai Quaderni Piacentini nel 1976.
Nel 1994 è stato pubblicato il volume Bisogna sognare. Scritti 1952-1975, che raccoglie gli articoli pubblicati su riviste e giornali e alcuni inediti.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.