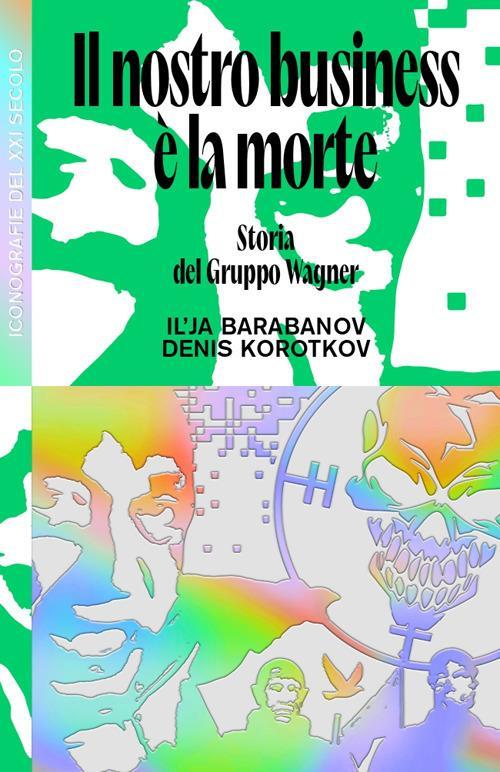12 ANNI SCHIAVO di Steve McQueen, 2013

Il film è tratto dall’omonimo romanzo autobiografico di Solomon Northup, violinista di colore, sposato, con due figli, inserito nella buona società di Saratoga, che un giorno viene rapito e venduto come schiavo a un proprietario terriero della Louisiana. L’uomo passerà 12 anni della sua vita lavorando nelle piantagioni di cotone, subendo ogni tipo di angheria, fino a quando un suo amico avvocato si presenterà nella piantagione con i documenti che attestano la sua condizione giuridica di uomo libero, affrancandolo così dalla condizione di schiavo.
Solomon è un uomo colto, educato, sa leggere, scrivere e pure suonare, ovviamente benissimo. Non è ricco, ma conduce comunque una vita agiata. Ha una moglie e dei bambini. Il suo unico vero e grave difetto è quello di avere la pelle nera. Da qui parte il film, su queste informazioni viene costruito il contesto. Quello che subito però notiamo è che questi elementi vengono utilizzati dal regista per rafforzare agli occhi del pubblico la profonda ingiustizia di cui Solomon resta vittima. E qui il discorso comincia a farsi ambiguo. Perché va bene il rispetto della verità del romanzo, ma se l’intento era quello dichiarato di realizzare un film “duro” sulla schiavitù negli USA, McQueen avrebbe potuto forzare il discorso su un piano più generale. Invece fa esattamente il contrario. Si concentra esclusivamente sul personaggio Solomon, che non per nulla è in scena ininterrottamente dall’inizio alla fine del film. Quello che così sembra volere sottolineare il regista, già nei primi minuti, è che la schiavitù è orrenda e sbagliata, ma lo è ancora di più perché chi nel film ne rimane vittima è una persona “per bene”, onesta e morigerata. Il prosieguo del film non farà che confermare tutto questo. Più la pellicola scorre, e meno ci sentiamo vicini alla condizione di Solomon.
Già dopo una mezzoretta di proiezione, la morale viene esplicitata: gli iniziali timidissimi e vaghi propositi di ribellione si spengono quando alla schiava venduta insieme a lui all’inizio della storia, Solomon spiega che non vuole ribellarsi, ma sopravvivere, perché vuole rivedere la sua famiglia, e che siccome lui è illegalmente tenuto schiavo, prima o poi troverà giustizia. Ribellarsi non serve, peggiora solo la situazione. Solomon si è infatti già trasformato in una specie di collaborazionista, e improvvisatosi ingegnere, ha appena progettato un sistema di trasporto delle merci che fa risparmiare tempo e denaro al padrone, il quale lo premia con un violino. A questo punto del film, la “simpatia” che teoricamente dovremmo provare per Solomon, svanisce. Perché è chiaro che quella ci viene indicata è una strada, un percorso da seguire. Peccato che quella strada valga solo per Solomon, che è intelligente, ha una casa, una famiglia, denaro e titoli. Gli altri sono troppo ignoranti, stupidi, poveri e disperati per poterla percorrere. Tutto questo McQueen non lo dice mai, non lo mostra mai, e nemmeno lontanamente lo suggerisce. Siamo nel pieno dell’adesione al personaggio, che infatti si guadagna verso la fine del film, quando tutto ormai sembra perduto, una lunghissima, interminabile inquadratura del suo primo piano dal basso (il tocco d’autore, o meglio, il tocco d’esteta), con lo sguardo sperduto e le lacrime agli occhi, che vaga alla ricerca di un qualcosa di apparentemente indefinito, che altro non è che la via d’uscita alla sua condizione. Ma attenzione, solo la sua, individuale, esclusiva. E soprattutto, legale.
Sarà un improbabile personaggio, che piomba nel film come il settimo cavalleggeri nei western, appiccicato con lo sputo sulla pellicola, quello che dopo tanto penare salverà Solomon. In quel momento, McQueen abbandona ogni pudore, e mette in scena un dialogo sulla giustizia che oltre a essere più didascalico di un cartello stradale, ancora una volta ribadisce la morale del film: bisogna credere nella giustizia, che per Solomon, per il suo salvatore, per McQueen e per la borghesia significa credere nella legge. Perché quello che salva Solomon è proprio la sua fiducia nella legge. Anzi, Solomon è la legge. Calpestata, umiliata, torturata, ma alla fine vittoriosa. E’ la legge che dice che lui è un uomo libero; in fondo, è per questo che la sua condizione è inaccettabile.
Quando sale sul carro che lo riporterà a casa, Solomon non saluta nessuno degli schiavi che sono insieme a lui, nemmeno la donna che gli aveva chiesto di ucciderla per risparmiarle la pena di quella vita agghiacciante, e che poi lo stesso Solomon, nei panni del Kapò tormentato, frusterà quasi a morte su ordine del padrone. Non ne ha il tempo, e nemmeno la voglia. Giusto uno sguardo all’indietro mentre parte, ma perché quella donna lo sta chiamando e lo sta salutando. Lui ormai fa di nuovo parte dell’altro mondo, o meglio, dell’altra classe, e i compagni di 12 anni di sventura sono già diventati un ricordo.
Ripulito e rivestito come un baronetto inglese, Solomon potrà finalmente riabbracciare la famiglia, moglie, figli, genero e nipote, uniti in un cerchio, nel salone di casa, e in lacrime scusarsi e ricusarsi per essere stato via tanto tempo. Quanta differenza rispetto al Tarantino di Django Unchained, che attraverso il personaggio interpretato da Samuel L. Jackson, riusciva a trasformare un fumettone western in una complessa, feroce e scomoda riflessione sul ruolo sociale del servo.
Chi si aspettava di scoprire in 12 anni schiavo un nuovo inno alla libertà non potrà dunque che restare deluso. Perché il primo ad averci rinunciato è il film stesso. McQueen ha accettato un compromesso così al ribasso che qualunque eventuale giustificazione risulterebbe solo sgradevole. E non abbiamo tenuto conto di tutta una serie di elementi prettamente filmici che proprio non funzionano, a cominciare dall’inconsistenza e debolezza nella costruzione di ogni personaggio di contorno, ognuno praticamente ridotto a semplice e vuota funzione narrativa; uomini e donne che compaiono e scompaiono meccanicamente dalla storia, senza lasciare traccia.
D’altra parte, siamo sicuri che questo film, come altri “mattoni” girati in passato, vincerà ogni premio della critica sui quotidiani e sulle riviste di tutto il mondo. Giornalisti di ogni risma e intellettuali di ogni sorta faranno a gara per lodarne la qualità della regia e della fotografia, la profondità dei contenuti, la crudezza e il realismo delle sequenze più forti. Certamente, il film finirà per essere proiettato nelle scuole superiori di ogni ordine e grado. Non resteremo sorpresi. Sarà solo la conferma che avevamo visto giusto.
Kino Glaz
Riportiamo un commento, arrivatoci alla casella di posta di Infoaut, con alcune considerazioni sullo stesso film recensito qui sopra.
Intanto vorrei ringraziare Kino Glaz per la bella recensione. In maniera un po’ didascalica e scolastica -e già mi attirerò l’ira dell’autore- vorrei iniziare il mio commento citando un passo, per me cruciale, della recensione.
“se l’intento era quello dichiarato di realizzare un film “duro” sulla schiavitù negli USA, McQueen avrebbe potuto forzare il discorso su un piano più generale. Invece fa esattamente il contrario. Si concentra esclusivamente sul personaggio Solomon”
Mi sento di dire che un “un piano più generale” non esiste; soprattutto quando si tratta di drammi, ogni dramma è personale, come ogni esperienza. Per voler rendere l’idea: l’essere è anarchico.
Nel focalizzarsi sul personaggio di Solomon McQueen compie una scelta estetica, di inclusione/esclusione, non ci vuol far immedesimare con la condizione sociale di Solomon, bensì tenta di descrivere il suo mondo psicologico, che potrebbe essere il nostro e prevede un “taglio” sulla storia che mostra sì il lato interno della sua psiche, ma allo stesso tempo esplicita tutto quello che sta fuori. Gli atteggiamenti degli altri schiavi vengono messi in luce proprio come “altro”, come tratto di un’esperienza colto solo attraverso la distanza e l’incredulità.
“la morale del film: bisogna credere nella giustizia, che per Solomon, per il suo salvatore, per McQueen e per la borghesia significa credere nella legge”
Questo mi sento di dire è il vero nodo concettuale che non condivido dell’interpretazione dell’autore.
Provo a proporre questo ragionamento speculare a quello citato.
Direi che nonostante Solomon sia un uomo libero non è immune alla schiavitù. La svolta del film si incentra non su come il protagonista esca dalla schiavitù, ma di come ci entri. E che ci entri.
Solomon avrebbe potuto anche morire nel campo di cotone, il film non sarebbe cambiato di una virgola, nel suo valore estetico.
Direi, ed il messaggio è comunque contestabile, che la “morale” -termine per me fuori contesto, ma comunque cerchiamo di porsi sulla linea di ragionamento proposta- è che la schiavitù può toccare chiunque, nessuno è immune. Puoi essere anche un borghese del nord, ma se sei nero, sei precario, a rischio deportazione nei campi di cotone del sud.
Come ho detto all’inizio la dimensione psichica del protagonista è ciò che guida le emozioni e le riflessioni dello spettatore. Ripeto anche che fa ciò sia attraverso atteggiamenti manifesti, sia al rovescio, celando alcune situazioni psichiche che ci saremmo potuti aspettare.
Vorrei quindi porre l’accento su quello che per me è il tratto psicologico caratteristico di Solomon: l’incredulità. Egli è sbigottito, incredulo del mondo in cui è stato catapultato senza sapere perché. Disorientato.
Vorrei, e me ne scuserete, porre un problema metafisico. Cosa significa essere portato-fuori dalla propria realtà? Può una deportazione come quella subita da Solomon portar-fuori un uomo da se stesso? Come ci poniamo di fronte al disorientamento del protagonista?
“Quando sale sul carro che lo riporterà a casa, Solomon non saluta nessuno degli schiavi che sono insieme a lui, nemmeno la donna che gli aveva chiesto di ucciderla per risparmiarle la pena di quella vita agghiacciante, e che poi lo stesso Solomon, nei panni del Kapò tormentato, frusterà quasi a morte su ordine del padrone. Non ne ha il tempo, e nemmeno la voglia.”
Cosa rappresenta Solomon? Chi è Solomon rispetto a noi? Cosa significa vivere 12 anni schiavo?
Non ha voglia dice Kino Glaz. Non si ha voglia, dico io… di andare a lavoro o a scuola. Non ci si gira verso la donna che si è frustato perchè non se ne ha voglia, ma perché -mi passerete la banalità- …abbiamo la morte nel cuore; perché siamo distrutti; perché abbiamo visto l’orrore e ne siamo usciti, ma sappiamo che l’orrore è ancora dietro di noi, e non tutti (o forse nessuno) hanno la forza di guardare. L’orrore è il tema centrale del film. L’orrore dentro e fuori di noi.
Solomon è un simbolo. Durate tutto il film, a me pare, si comporta come se fosse trasognato, un essere inconsapevole, che agisce quasi meccanicamente. È l’annientamento della volontà.
Solomon si salva? Come ci si può salvare dall’orrore? Una volta che penetra nella mente umana ci sveglia di notte e urla. E non si placa. Siamo tutti schiavi finché un uomo sarà schiavo. Questo è il messaggio del film?
Dovrebbe, ma il film non osa tanto. Quello che Solomon fa, stigmatizzato nel collaborazionismo, non si identifica però con via per uscire dalla schiavitù, ma è il simbolo del disvelamento del metodo della schiavitù. L’annientamento dell’essere umano per mano di se stesso. Ciò che il film mostra è come la schiavitù annienti oltre alle vite umane, anche lo spirito umano e questo è ciò che la rende spaventosa perché distruttrice delle speranze e della solidarietà umana.
L’umanità è annientata quando l’uomo perde il minimo di dignità che gli impedisce di frustare un altro uomo. Questo è l’orrore, questo è la schiavitù.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.