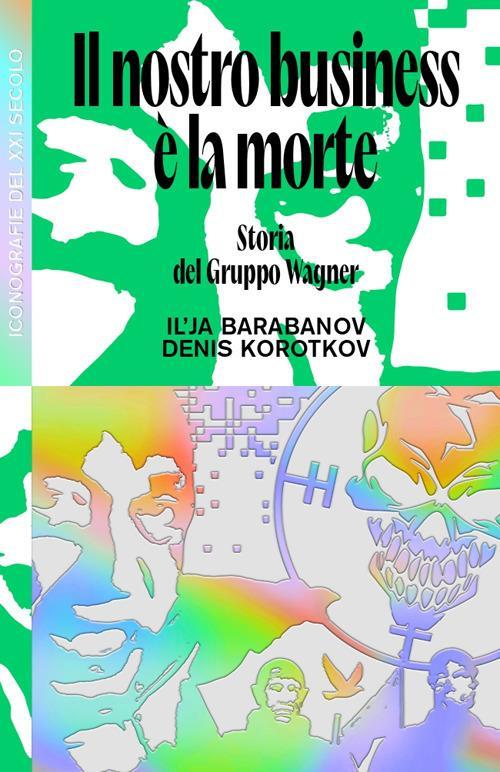Our War: che cos’è la “nostra guerra”?

Quando ho visto per la prima volta il trailer di Our War condiviso su facebook, mi trovavo in una delle rare situazioni in cui, nella Siria del Nord in guerra e sotto embargo, riuscivo ad avere una connessione. Inutile dire che il soggetto del film mi aveva intrigato: tre “foreign fighter al contrario”, come ci chiamano talvolta i giornalisti, che avevano fatto la mia stessa scelta, prima di me: lasciare le loro pacifiche città in occidente per andare in Siria, e prendere parte al più sanguinoso conflitto contemporaneo. Uno dei tre protagonisti lo conoscevo già, sebbene soltanto di fama: Karim Franceschi, il cui libro Il combattente mi aveva accompagnato nelle settimane prima di partire – ed anche spaventato, se devo essere sincero.
Qualche mese dopo, avevo abbandonato ogni irriflessa e ottimistica reticenza sulla veridicità del resoconto di Karim. Ero passato attraverso quelle esperienze che, in un modo o nell’altro, ti segneranno per tutta la vita. Anche i particolari più duri erano reali, sebbene nessun libro possa restituire la profondità dell’orrore di una guerra. Ora mi trovo consegnato alla condizione di un altro tipo di reticenza, e sono esposto alla stessa reazione di incredulità. Possibile che questa persona, che siede di fronte a noi e parla, o prende con noi un caffè, è stata in mezzo alle bombe, alle esplosioni, ai proiettili? Dubbi possibili in Italia, non in Siria. Possibile, si chiede ed anche mi chiede qualcun altro, che tu vi sia andato volontariamente, per combattere una guerra non tua, in un paese non tuo?
Questo il tema del film: non il nostro paese, eppure la nostra guerra. Guerra globale, che sembrava guerra di coalizioni e stati, ed è stata raggiunta da una folta schiera di rivoluzioni, smembramenti, migrazioni – fino a tracimare nelle scariche di kalashnikov sulle movide e sui lungomare europei, o tra i mercatini di Natale dell’inverno tedesco. Ora finalmente ho visto Our War e grazie a quest’opera ho “conosciuto” Rafael Kardari, giovane dj e bodyguard svedese, sebbene di origine curda, partito a sua volta per la Siria. Perché? “Perchè li odio”. Lo dice all’inizio e sembra quasi sentirsi in colpa, con un’espressione da bambino. Chi odia? Loro, naturalmente: l’Isis, Daesh, quelli che ammazzano, lapidano e incatenano in nome di Dio, i piccoli preti mascherati e armati di mitra o coltello.
Spostarsi nel mondo andando a cercare qualcuno: questo è a sua volta un tema del film. Farlo perchè lui è venuto – geograficamente e moralmente – a cercare te. Quando il film è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia stavo conoscendo Ryan Lock e Nazzareno Tassone. Michael Israel e Anton Leschek li avevo conosciuti poco prima: giungevano mentre io mi apprestavo a ripartire. Volenterosi, sorridenti, pieni di determinazione per combattere, toccando un’arma per la prima volta (tranne Michael, che era già stato in Rojava), nella “loro guerra”. Sarebbero morti tutti nelle settimane successive, per fuoco turco o dello stato islamico, mentre io rimettevo piede in Italia e cercavo di riambientarmi, e anche di capire che fare della vita che mi era stata risparmiata.
Durante la proiezione di Torino, qualcuno ha chiesto a Bruno Chiaravalloti e Claudio Jampaglia, registi del film assieme a Benedetta Argentieri, se non temessero di aver fatto passare i volontari internazionali delle Ypg per eroi. Trovo che la mia generazione abbia una malsana, e al tempo stesso stranamente disincarnata, ossessione per il tema dell’eroismo. Chi ha combattuto l’Isis (o, nel caso di Karim, lo combatte tuttora) non è un eroe. In generale, gli eroi di piompo o di carta chiamano soltanto guai. Semmai occorrerebbe sforzarsi di capire dove nasce la rabbia di Rafael, dove è nata quella di Karim e tanti altri, cosa spinge persone che vivono nella pace, e in molti casi amano la pace, a prendere in mano un’arma. Michel, Anton, Ryan, Nazzareno erano ragazzi tranquilli per come li ho conosciuti io. Tuttavia, avevano deciso che contrapporsi allo stato islamico era anche una loro responsabilità.
Ho letto nel suo libro che Karim era stato colpito in Turchia dai volti dei bambini provenienti da Kobane, traumatizzati dalla guerra, e per questo aveva deciso di combattere. Kobane era parzialmente invasa dai miliziani del califfato, allora. Era la fine del 2014. Per me la svolta determinante fu quando appresi cosa stava accadendo a Parigi, la sera del 13 novembre di un anno dopo, nel 2015. Lo stato islamico ha portato morte, ha ricevuto morte in cambio. Tuttavia, c’è più di questo. Il mondo delle frontiere che determinano le appartenenze è finito. Oggi le frontiere vengono bucate o distrutte, ignorate o negate; sono luoghi di attraversamento per migrare, fuggire, aiutare, combattere, e le identità si disegnano spesso altrimenti. Nel lungo periodo, la reazione di filo spinato e cemento che mette in atto il vecchio mondo, quello degli stati-nazione, potrebbe non prevalere. Tanto vale pensare al nuovo mondo, anche affinchè non prevalga come alternativa l’incubo. Più che utopia, mi sembra realismo. Credo che in questo senso i pochi che ad oggi riescono a informarsi, pur senza andare a combattere, non esitino a considerare la resistenza del Rojava anche come la “loro” guerra.
Ci sono eventi che polarizzano i sentimenti di una generazione. Tuttavia, ancora, non è soltanto di questo che si tratta. Our War è un film pieno di silenzio. I momenti che ho più apprezzato sono quelli in cui Rafael mette in moto la sua auto ed esce dal parcheggio, oppure si infila sulla tangenziale di Stoccolma; quelle in cui Karim porta a passeggio il cane; quella di Rafael, ancora, che infila la pistola nella fondina andando al lavoro, la scena che più di ogni altra restituisce il mondo di oggi per quello che è: un mondo d’attesa. Talvolta ho trovato il film disorganico, sul piano espressivo, e tuttavia la sua forza più grande, sul piano estetico come su quello politico, è di essere straniante. La calma e il silenzio delle periferie o delle province occidentali sono imbevute di Siria, nel film come nella realtà. La Siria è una presenza-assenza, è lo spettro che ci cerca e provoca angoscia – non è più un paese. La verità dei, e non “sui” foreign fighters, è che la loro guerra se la portano dentro prima e dopo la partenza, come volontà o come fantasma, come intangibile stato di cose, realtà che produce effetti invisibili nella placidità e nel silenzio, terribile saggezza vissuta nella stessa quotidianità di chi ancora si crede in pace.
Devo ammettere che, tra tutti, sono uno di quelli che più ha apprezzato il circo multicolore dei combattenti internazionali delle Ypg. Meravigliosa rappresentazione della varietà e follia dell’occidente, essa racchiude il mondo pluriverso, benchè non per forza gioioso, di chi ha rotto questa menzogna surreale e ovattata della pace che ci vendono, e non ha ceduto, quantomeno non per sempre, alla tentazione dell’ingenuità. I ragazzi che ho conosciuto hanno creduto che i crimini dell’Isis contro le popolazioni della Siria, della Francia o dell’Iraq rappresentassero qualcosa di fronte a cui non era legittimo restare fermi. Perdonateli! Molti credono anche, o piuttosto, che le riforme sociali e di genere in atto nella Siria del Nord meritino di essere difese da tutto il mondo, e non soltanto dai curdi e dai siriani migliori.
Our War è un film che riesce a restituire una buona parte della verità, credo, su queste persone. Ad esempio, che queste persone non esistono per confermare le nostre aspettative o i nostri pregiudizi. Yoshua Bell, il terzo protagonista, rappresenta al meglio una tipologia caratteristica in quell’ambito: non fa sfoggio di un linguaggio sofisticato o studiato, nonostante non abbia certo complessi, e non pretende nè vorrebbe essere altro da ciò che è. Per alcuni, questo ex marine e “crazy motherfucker” (espressione sua, per un mancato epitaffio che è familiare a chi è tornato a casa) sarà sempre una figura inaccettabile. Eppure, differentemente da chi, partendo da luccicanti teoremi, tenta di raddrizzare dottrine inesatte e vi si perde, lui, partendo da un senso morale magari meno avveduto a livello politico, è finito ad affrontare la morte e a salvare vite in mezzo a migliaia di rivoluzionari veri, indossando infine, e senza curarsene più di tanto, gli stemmi di un progetto anticapitalista.
C’è un momento in cui lui, Yoshua, ricorda Anita Hoffman, la ragazza tedesca comunista caduta in combattimento a Tell Tamer nel 2015, di cui la Germania ancora vuole ignorare dignità, importanza e sacrificio. Yoshua era rimasto affranto dalla sua perdita. Con lei aveva avuto così tante “discussioni ideologiche”! Così è la Siria del Nord (non certo l’altra Siria, quella dei vari islamisti o del regime): un ragazzo che ha lasciato i marines per poter combattere senza l’ingombro di un governo pavido la “sua” guerra, si ritrova tra le fila dei suoi supposti avversari politici e culturali – gli unici che, scopre, la combattono per davvero. Avrei pagato per assistere alle conversazioni tra Anita e Yoshua. Le conversazioni che ho avuto e a cui ho assistito in Rojava, in generale, sono state effettivamente conversazioni impossibili. Personalmente sono arrivato a vedervi la prefigurazione di un mondo libero, benché su questo non pretenda di convincervi.
Yoshua non è tornato comunista dal Rojava. La martire Anita l’ha fatto soffrire, ma non l’ha convinto. Neanche le Ypg lo hanno convinto. Sebbene sia un pensiero eccellente, dice nel film riferendosi a Ocalan, “che conserva il meglio del socialismo depurandolo dai suoi lati peggiori”, non sarà mai realizzabile: “infine l’avidità umana prevarrà sempre”. Devo dire che, pur senza conoscerlo, percepisco Yoshua in qualche modo come un amico – è un heval, come ci si chiama nelle Ypg (proprio “amico” in curdo), e nulla vieta che, nella vita concreta, lo sia ben più di me. Non voglio sdoganare un identitarismo da reduci, di cui non sapremmo assolutamente cosa fare (se non del male, probabilmente). Tutt’altro: voglio dire che le rivoluzioni cambiano le persone, e anche per questo viverle è diverso dal teorizzarle.
Di cambiamenti che non serbano sorprese sono pieni i pamphlet. Chi ha preso la via della Siria del Nord preferisce il mondo e la vita anche quando sono difficili, dove però accade che migliaia di donne prendano in mano la loro esistenza, milioni di persone vedano per la prima volta le loro lingue trattate con rispetto, minoranze schiacciate da secoli sgranino gli occhi di fronte a una mano tesa e a un sorriso in chi attraversa le loro città con le armi in pugno; e i contadini e gli operai vedono “ancora una volta” (per un tentativo che non cessa, a sua volta, di cercarci) i prodotti del loro lavoro messi del tutto o parzialmente in comune. Questo cambiamento non è in Europa, o in America. È confinato, assediato e bombardato nella Siria del Nord.
Eppure, quando nel film ho sentito Yoshua affermare che, là dove i marines dovessero affrontare le Ypg a parità di armamento, queste ultime li sbaraglierebbero, ho avuto l’ennesima illuminazione che il Rojava può rendere possibile – una sorta di Rojava moment. Ho ripensato all’altra esperienza, quella precedente, che aveva cambiato la mia vita: penetrare l’esistenza e la cultura degli Stati Uniti. Là avevo appreso la bellezza di quella cultura e avevo imparato ad averne rispetto – cosa difficile per chi è cresciuto immerso nel razzismo e nell’arroganza culturale propri di noi europei. Tuttavia, avevo anche appreso che la caratteristica europea da cui la fiera America non aveva mai voluto distanziarsi era proprio, a sua volta, la pretesa di assolutezza di una “visione del mondo” a buon mercato, forse tipica di tutti i vincitori e conquistatori.
Yoshua, però, appartiene a una razza particolare tra gli statunitensi: quelli che hanno viaggiato, e hanno quindi preso atto che l’America non è tutto. Questa razza ha un sottogruppo speciale: quella di coloro che hanno visto la rivoluzione del Rojava. L’affermazione di Yoshua circa lo scontro immaginario tra marines e Ypg, e la vittoria di queste ultime, risulta incomprensibile e indecifrabile nella cornice culturale e politica americana. Indica implicitamente l’astrattezza di un’ideologia falsa circa la superiorità oggettiva di un popolo, perchè superiore è la sua tecnologia o antecedente la sua colonizzazione. I combattenti delle Ypg sono per Yoshua, veterano dell’Afghanistan e dell’Iraq, lo dice nel film, “i più coraggiosi che abbia mai visto”; e quando arriva a commuoversi descrivendo l’amore che circonda i martiri in Kurdistan, vuole forse esprimere indirettamente un disagio per l’uso che della gioventù americana ha fatto quella “politica” contro cui lui e altri ragazzi che ho conosciuto nelle Ypg hanno lasciato il corpo dei marines.
Forse quella politica ha onorato i caduti, in America, in un modo che loro hanno percepito come insufficiente, o meno sincero. È sempre doloroso rendersi conto che i propri maestri avevano tanto, forse troppo da imparare. Dalla rivoluzione non si torna intatti, questo è il punto. Ciò può rendere, eccome, nostra la guerra che accade in un altro paese. La verità è che in Siria abbiamo approfondito in modo imprevedibile ciò che siamo – e non riusciamo a smettere di farlo, una volta tornati.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.