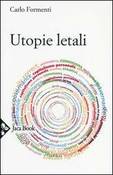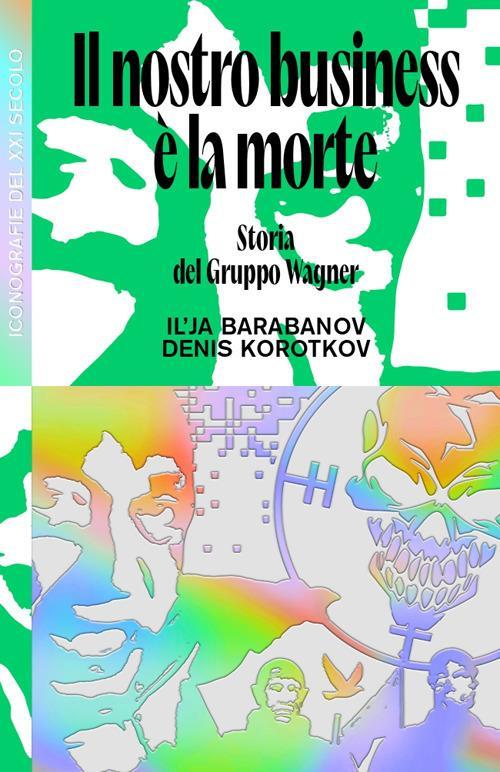Utopie Letali è un titolo spiazzante, che suscita curiosità e perplessità. Questo perché si tratta in qualche modo di un ossimoro, visto che siamo soliti associare un significato positivo alla parola utopia, usandola come sinonimo di sogni, desideri e speranze in un mondo migliore. Perché dunque affiancarle quell’aggettivo: letali? Eppure sappiamo che, a volte, le utopie producono effetti imprevedibili, se non catastrofici. Le destre, per esempio, ce lo ricordano continuamente, soprattutto dopo la caduta dei regimi socialisti dell’Est Europa: avete visto quanti orrori ha generato l’utopia comunista? Un ritornello che, in campagna elettorale, viene usato per proiettare un’ombra inquietante su una sinistra socialdemocratica che ha scontato da tempo i suoi peccati e che, della parola comunista, non ricorda nemmeno il significato, mentre, negli attacchi alle sinistre radicali, acquisisce il sapore di un esorcismo contro il vecchio spettro che non si decide sparire. Ma le utopie letali con cui polemizza questo libro sono di tutt’altro genere: anche queste sono utopie “di sinistra”, ma hanno poco a che fare con l’utopia comunista che ancora spaventa il capitale, si tratta delle utopie di quelle sinistre “movimentiste” postmoderne, postideologiche, postmateriali, postindustriali (l’elenco potrebbe andare avanti per pagine e pagine, ma ve lo risparmio) che hanno sostituito le velleità rivoluzionarie con il sogno di un crollo indolore del capitalismo che dovrebbe essere provocato da improbabili mutazioni della psicologia e dell’antropologia individuali, oppure dalle lunghe marce per i nuovi diritti, o dall’invenzione di “terze vie” che ci proiettino oltre la dicotomia fra pubblico e privato, oppure da tutto questo assieme e da altro ancora.
La lista delle ideologie chiamate in causa è lunga e, apparentemente, eterogenea: neo e postoperaisti, neo anarchici, benecomunisti, girotondini, parte dei movimenti femministi, ecologisti e pacifisti; soggetti in cerca di riconoscimento identitario; entusiasti della democrazia di Rete; paladini dei nuovi diritti, ecc. Ho detto apparentemente eterogenea perché, in realtà, le schegge di questa galassia presentano molti tratti comuni: danno per scontata la necessità di “andare oltre” (non di ripensare criticamente) la storia e la cultura politiche del Novecento (dopodiché rispolverano ideologie ottocentesche); sono antigerarchici e antiautoritari (ma si organizzano in piccole sette guidate da piccoli leader carismatici); sono più attenti ai diritti personali e individuali che ai diritti sociali e collettivi; esaltano il ruolo democratizzante dei nuovi media (ignorando il fatto che sono stati ormai colonizzati da governi e corporation); hanno occhio solo per il lavoro immateriale di knowledge workers, creativi o per il lavoro autonomo (che scambiano per una nuova avanguardia politica e culturale, in barba all’incapacità di questi soggetti di esprimere coscienza antagonista); rifiutano l’idea stessa di partito come organizzazione degli interessi di una parte sociale contro il “bene comune”, alla quale sostituiscono vaghi modelli movimentisti; infine sono radicalmente “antistatalisti”, pretendendo di condurre la lotta contro la proprietà privata in nome di un concetto di bene comune proiettato “oltre il pubblico e il privato”. La tesi di fondo che troverete nel libro che avete in mano, è che tali caratteristiche attribuiscono a queste culture politiche un alto livello di contiguità con l’ideologia liberale che vorrebbero combattere. Sono utopie letali perché, invece di canalizzare l’energia antagonista che abita in un corpo sociale martoriato da trent’anni di “guerra di classe dall’alto”, la disperdono su obiettivi illusori o marginali e, quindi, indeboliscono le possibilità di ripartenza di una “guerra di classe dal basso”.
Questa la pars destruens del libro, la parte propositiva si articola viceversa su quattro tesi di fondo che vengono argomentate in altrettante sezioni del libro: 1) la crisi in corso segna un mutamento irreversibile del modello di accumulazione capitalistica e ha provocato il definitivo divorzio fra democrazia e mercato, per cui oggi viviamo sotto regimi postdemocratici in cui gli interessi del capitale globale governano direttamente, senza mediazione politica, le nostre vite; 2) le nuove classi medie occidentali, che negli anni Novanta avevano accarezzato il sogno di una economia della conoscenza e di un superamento pacifico del capitalismo, sono state letteralmente fatte a pezzi dalla crisi; in compenso, oggi assistiamo a una controtendenza alla concentrazione del proletariato globale che ha i suoi nuclei di condensazione nella classe operaia dei Paesi in via di sviluppo, e nei nuovi poveri dei Paesi occidentali, perciò il fronte di opposizione antagonista al sistema capitalistico può e deve essere ricostruito a partire da lì; 3) le esperienze dei movimenti degli ultimi decenni insegnano che spontaneismo, orizzontalismo organizzativo e culturalismo (si parte dalle identità e non dall’appartenenza di classe) non pagano; occorre quindi tornare a riflettere sull’idea di partito come organizzazione antagonistica degli interessi di classe, un concetto che va tuttavia adeguato alle attuali condizioni di frantumazione delle soggettività, inventando nuove forme organizzative e nuove procedure decisionali; 4) il capitalismo non cade da solo, né possiamo illuderci che siano le richieste di diritti e riconoscimenti identitari a rovesciarlo, quindi non basta tornare a ragionare sul partito, occorre tornare a ragionare, con Gramsci, anche sul “farsi stato” delle classi subordinate e sulla loro capacità egemonica, se si vuole gestire la transizione a una civiltà postcapitalista.