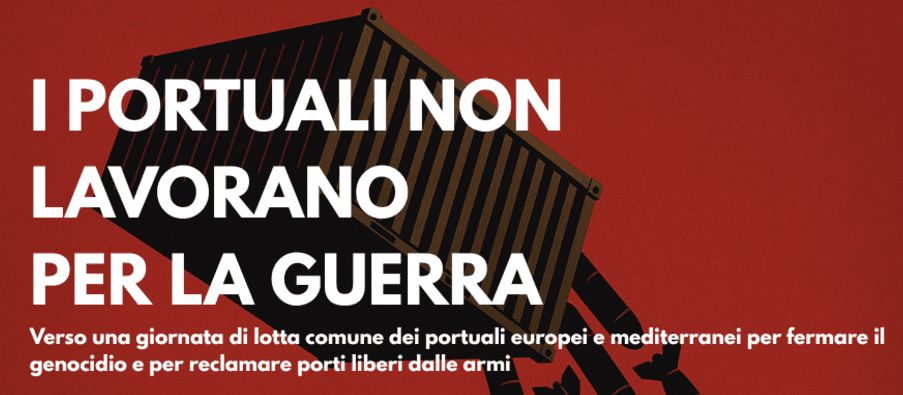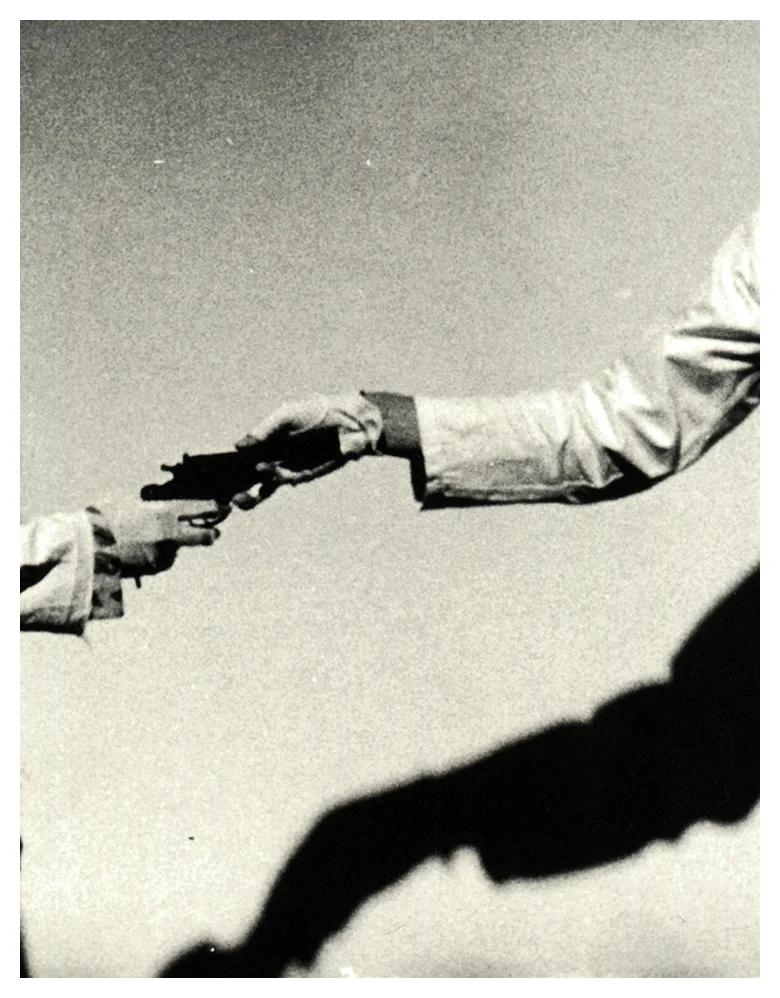
Economia e guerra
Pubblichiamo la trascrizione dell’incontro «Economia e guerra», seconda parte di un dibattito intitolato «Guerra o rivoluzione. Capire la guerra per capire come combatterla», tenutosi durante il festival di Derive Approdi di fine settembre. Gli interventi di Christian Marazzi, Rossana De Simone e Andrea Fumagalli, che dialogano con le relazioni di Maurizio Lazzarato e Cristina Morini che li hanno preceduti, si inseriscono in una riflessione che abbiamo portato avanti con Transuenze negli ultimi mesi.
Da Machina
Abbiamo chiesto ai relatori se la palese tendenza al riarmo a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi possa preludere ad un ritorno al keynesismo militare come modalità di rilancio del ciclo economico. Bisogna naturalmente intendersi sul concetto di «keynesismo militare», concetto utilizzato più per eredità storica che per correttezza formale. Quello che ci interessa capire è in che modo il «ritorno» dello Stato al centro dei processi regolativi per coniugare ciclo economico e interessi di difesa nazionale (quello che è stato definito «nuovo capitalismo politico») e il tentativo (se c’è davvero) di ricostruzione di nuovi blocchi sociali (attorno alla stessa questione della guerra?),si coniugano con le fibrillazioni geopolitiche ed una guerra scoppiata nel cuore dell’Europa.
* * *
Christian Marazzi Il capitalismo è nato come atto di guerra, la privatizzazione dei beni comuni è stata pura violenza contro coloro che fino a quel momento potevano disporne e vivere grazie ad essi. Sono d’accordo con Maurizio Lazzarato quando ribadisce la centralità della questione monetaria, nella fattispecie del dollaro, e che la globalizzazione ha camminato di pari passo con la dollarizzazione, con qualche sfumatura negli ultimi dieci anni che andrebbe tenuta in considerazione per spiegare anche lo sbocco bellico nell’Europa centrale. Cercherò di rispondere alla domanda sul keynesismo militare in modo non del tutto organico perché la questione è complicata. Siamo certamente in una situazione in cui il ciclo economico è ostaggio del ciclo bellico, tanto per mettere le cose in chiaro sin da subito. Ci troviamo di fatto in una fase di militarizzazione dell’economia, di anno in anno le spese militari crescono sempre di più. Pensiamo solo al ciclo economico e monetario di questa guerra. Andrea Fumagalli ha scritto su «Effimera» un testo molto preciso sulla speculazione in Borsa nel mercato del gas e del petrolio, che spiega il rincaro dei prezzi a cui stiamo assistendo. È una specificità della privatizzazione come parte costituente del capitalismo liberista degli ultimi 30 anni, che fa sì che oggi i prezzi delle materie prime siano in forte rialzo ciò che, di conseguenza, permette il finanziamento degli armamenti russi: la vendita del gas procura liquidità per finanziare l’industria bellica. E l’Europa, a cominciare dalla Germania, reagisce aumentando le spese militari. In questo modo il cerchio si chiude. Dunque, ciclo economico e ciclo bellico sono intimamente collegati. In questo momento ci troviamo in una fase che qualcuno ha definito come «sinergia distruttiva»: da una parte l’escalation bellica, dall’altra la recrudescenza della politica monetaria, a partire dalla Fed, due fattori che camminano in parallelo o addirittura in sovrapposizione. Le decisioni della Fed di aumentare i tassi di interesse stanno trainando tutte le banche centrali del mondo, con effetti recessivi su scala globale di cui dobbiamo avere paura perché è una sorta di guerra economica a noi tutti, alla moltitudine. È una guerra non guerreggiata, bensì monetaria contro la popolazione. È da poco uscito uno studio sugli effetti della crisi del 2008 secondo cui le fasce più povere della popolazione hanno impiegato dieci anni a riprendersi dagli effetti nefasti di quella recessione. Paradossalmente, è stata minore la durata delle problematiche economiche della crisi pandemica anche grazie alle forme di welfare corrisposte durante il dilagare della pandemia, che hanno permesso di contrastare gli effetti più negativi. Il problema è che non appena l’economia si è ripresa è arrivata la stangata monetaria che potrà avere degli effetti di lunga durata. Se vogliamo parlare di keynesismo militare dobbiamo spiegarlo ricomprendendolo nell’economia nel suo insieme. Le tensioni militari, infatti, se è vero che sono espressione delle mutate relazioni di potere sul piano mondiale, si iscrivono dentro un sicuro rallentamento dell’economia mondiale. Citando alcuni dati, ad esempio, nel 2021 le esportazioni globali rispetto al Pil sono scese al di sotto del livello raggiunto nel decennio post-crisi del 2008. Tra le motivazioni del rallentamento economico che stiamo vedendo, come già abbiamo accennato sopra, possiamo citare la stretta monetaria o la sospensione dei sostegni statali ai redditi erogati durante la pandemia. In controtendenza a tutto ciò, non dobbiamo dimenticare che negli Usa l’amministrazione Biden ha promosso con il «Biden-Harris Inflation Plan» dei nuovi investimenti anticiclici di tipo keynesiano classico, infrastrutturale, volti a favorire la produzione di semiconduttori, la riconversione ecologica, la decarbonizzazione con una carbon tax del 15% sui profitti delle multinazionali. Nella riflessione sul keynesismo militare e sul come contrastarlo, questa iniziativa americana può esserci utile perché suggerisce che sono possibili altri tipi di investimenti oltre a quelli bellici. In poche parole, non esiste solo il keynesismo militare. L’aumento dei tassi d’interesse e il contestuale rafforzamento del dollaro come conseguenza della politica monetaria americana (che sta trainando tutti i tassi di interesse nel resto del mondo) dimostrano come il dollaro sia ancora centrale: se è vero che negli ultimi dieci anni ha perso un po’ del suo peso, visto e considerato che le riserve valutarie denominate in dollari sono passati dal 70% al 58%, nessun’altra valuta di riserva è riuscita a contrastarla. Il rafforzamento del dollaro si spiega se pensiamo al fatto che gli Usa non possono permettersi di non avere il resto del mondo vincolato al suo debito pubblico, all’enorme debito commerciale, a maggior ragione in un’economia in cui la spesa militare accrescerà il debito ancora di più. La forza del dollaro va anche interpretata alla luce di questa ibridazione tra keynesismo militare e infrastrutturale. Bisogna inoltre vedere gli effetti dell’aumento dei tassi di interesse e del rafforzamento del dollaro sulle economie dei paesi che hanno il debito denominato in dollari, come abbiamo già avuto modo di vedere in Sri Lanka. Quanti altri paesi rischiano lo stesso? In che misura il keynesismo militare è in grado di contrastare la crisi di quei 53 paesi che secondo l’«Economist» sono a rischio bancarotta? Un’ultima cosa che mi sembra importante ricordare: gli effetti dell’inflazione delle materie prime in Europa sono devastanti, mentre c’è un forte aumento delle entrate dei produttori di greggio. Le misure di austerità sui consumi di gas dovranno essere controbilanciati da forti investimenti. In questo caso il keynesismo militare in Europa potrebbe fungere da antidoto agli effetti dei cali del consumo energetico. Inoltre, per contrastare e ridurre l’inflazione, l’aumento dei tassi di interesse dovrebbe essere ben maggiore: secondo alcune stime, in Europa dovrebbe aumentare tra l’8% e il 12% per avere un effetto reale. L’economista gesuita francese Gaël Giraud sostiene che la Bce si stia confrontando con un vero problema: continuare a comprare debito italiano, col rischio di favorire l’inflazione, oppure comprare debito senza creare nuova liquidità reinvestendo il rimborso del vecchio debito? Il rischio di una spaccatura dell’Eurozona è forte, qualcosa che abbiamo già vissuto ai tempi della Grecia. Si ritorna a parlare, ad esempio, della creazione di una zona del marco (questa soluzione alternativa esiste già dal 2012). È uno scenario da non sottovalutare.
Rossana De Simone Innanzitutto bisogna dire che noi siamo in guerra e viviamo in una economia di guerra. Secondo il report Nato 2022, il rapporto tra spese militari e Pil in Italia è pari all’1,54 del Pil, mentre, secondo il Ministero della difesa, le spese autorizzate dalle varie leggi di bilancio dal 2016 in poi registrano un trend in crescita in termini assoluti, con un picco nel 2022, anno in cui le spese finali si avvicinano ai 28 miliardi. È tuttavia necessario ricordare che il settore della Difesa si avvale di finanziamenti provenienti dal Mef e Mise, a cui bisogna aggiungere quelli necessari per le missioni internazionali all’estero. Le missioni militari quest’anno hanno subito un incremento di costi complessivi, di uomini e mezzi sul fronte est-europeo in funzione anti-russa. Un’ulteriore conferma che siamo pienamente dentro la guerra russo-ucraina. Il ventunesimo secolo inizia con la dichiarazione del presidente Usa George Bush:«È la prima guerra del XXI secolo. Guideremo il mondo alla vittoria». Le Torri gemelle, crollate in un contesto di gravi crisi, costituiranno la premessa della dottrina sulla guerra perenne e preventiva contro il «terrore», teorizzata da Bush in aperta violazione del diritto internazionale. L’ex presidente creò il Dipartimento per la sicurezza interna che si tradusse in più repressione, più limitazioni delle libertà personali e più spesa militare, con l’obiettivo di aumentare gli investimenti nello sviluppo di sistemi tecnologici per la sorveglianza e controllo del territorio. Coerente con le ambizioni unilaterali, Bush si ritira da vari trattati e protocolli internazionali: da quello riguardante le restrizioni del traffico di armi leggere al progetto che mirava ad inserire meccanismi di controllo nel contesto della Convenzione sulle armi batteriologiche; dalla messa al bando dei test nucleari, sino al ritiro dal Trattato Abm per poter avviare il progetto di difesa nazionale missilistica (Nmd). Da allora, la maggior parte degli Stati hanno iniziato non solo ad utilizzare e «consumare» le nuove tecnologie della sicurezza ma anche a produrle, creando un fiorente mercato che occupa diversi settori legati alla information security. In Italia, sempre in quegli anni, grazie all’amicizia con Bush, Berlusconi sottoscrive il Memorandum d’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele per sugellare una relazione basata sulla reciproca cooperazione militare e politica. La concezione securitaria dello Stato di Israele è, per il neoliberismo, un modello da imitare: basandosi sulla gestione della paura e sul conflitto sempre aperto, permette di accelerare il processo di erosione dello stato di diritto e la fuoriuscita dalla democrazia. Per entrare nel merito dell’intervento che mi è stato richiesto, utilizzo tre concetti chiave: crisi, deterrenza e trattati o accordi nazionali/internazionali. Il concetto di crisi posto in relazione alla guerra può essere articolato in diversi modi: crisi monetaria, economica, finanziaria, ambientale ecc. Se prendiamo ad esempio l’agenda pre-elettorale del presidente Usa Joe Biden, si vede che pone l’enfasi sull’intenzione di «ripristinare l’America» al suo ruolo di arbitro del sistema internazionale partendo da alcuni elementi: necessità di reagire alla crisi della globalizzazione, a quella dei valori occidentali e di fermare il declino degli Usa. Non a caso i suoi primi interventi si sono basati sulla dicotomia tra democrazia e oligarchia che serviva a definire la Russia un paese dove vige un regime oligarchico. Con questo Biden annunciava la possibile apertura di un conflitto il cui preludio era possibile immaginare dalle esercitazioni congiunte tra Ucraina e Nato dopo il ritiro delle truppe statunitensi dall’Afghanistan. Per quanto riguarda il secondo concetto, ci si dovrebbe domandare cosa sia la cosiddetta deterrenza strategica. Secondo la concezione militare un mondo senza deterrenza non è un mondo sicuro. In generale la deterrenza nucleare viene messa in relazione alla teoria dei giochi, ovvero alla ricerca di un equilibrio tra varie nazioni che hanno a disposizione l’arma nucleare. Fino a qualche anno fa gli Usa erano riusciti a rompere l’equilibrio esistente con la creazione di un sistema missilistico capace di intercettare altri missili balistici con base a terra, lanciati da sottomarini e ordigni nucleari lanciati da aerei. Con lo scoppio della guerra, la Russia ha cancellato la superioritá americana con lo sviluppo della tecnologia nei missili ipersonici. Nel mese di maggio Putin ha testato il primo missile da crociera ipersonico Zircon non intercettabile dal sistema antimissilistico americano perché capace di viaggiare a velocità nove volte superiore quella del suono (oltre tre chilometri al secondo). La Russia, come la Cina e gli Usa, ha dimostrato grandi avanzamenti nella ricerca e sperimentazione nel campo delle nanotecnologie, materiali e intelligenza artificiale entrando di fatto in quello che viene definito il dominio dello spazio e del cyberspazio. È indubbio che la Russia sia stata la prima a dimostrare la piena operatività del suo sistema di missili ipersonici. La rincorsa alla superiorità tecnologica avvalla le richieste di Stati di aumentare le spese militari non solo nella ricerca e sviluppo, ma anche per aumentare le capacità produttive delle loro industrie (non solo quelle belliche vista la necessità di creare sostenibilità lungo la catena del valore) per essere competitive. Gli Stati Uniti si sono resi conto da tempo che il decentramento produttivo, fenomeno per cui i processi produttivi vengono affidati a fornitori esterni, ha procurato un effetto boomerang a vari livelli. In un documento sulla sicurezza nazionale, Biden ha sostenuto che «la Cina è l’unico attore che intende riformare l’ordine internazionale e che ha le risorse economiche, diplomatiche, militari e tecnologiche per farlo»; eppure, ironia della sorte, il caccia multiruolo F-35, costruito in una miriade di Stati, ha utilizzato componentistica cinese. È evidente che gli Stati non hanno bisogno solo di salvaguardare le aziende della difesa, ma hanno bisogno di tutta la capacità tecnologica espressa dai colossi hi-tech nel campo dell’intelligenza artificiale. In Cina il presidente Xi Jinping ha incontrato i colossi del web per discutere della sicurezza online e per impedire che vi sia una violazione delle regole antitrust. Ad alcune aziende che si occupano di mining di criptovalute ha chiesto di convertirsi alla produzione di componentistica e semiconduttori. Anche la Cina non può fare a meno di siglare un accordo finalizzato a bilanciare gli interessi del governo e, a livello governativo, di fare entrare nel governo scienziati con esperienze industriali nei settori ad alta tecnologia. Per finire sui trattati, accordi o leggi, entrano in gioco dinamiche decisionali. Si susseguono governi che entrano ed escono dai trattati cambiano norme secondo particolari convenienze geopolitiche incuranti delle conseguenze sugli equilibri fra Stati. Accordi o trattati non dovrebbero sottostare agli interessi particolari degli Stati come accaduto sotto il governo di Donald Trump. L’ex presidente ha ritirato gli Usa dal Trattato Onu sul commercio delle armi perché convinto di poter riequilibrare la bilancia commerciale aumentando le esportazione di armi (si parla di un aumento del 25%) e il fatturato delle imprese (si stima del 41%). In realtà questa soluzione non è riuscita nell’intento che si era prefissato Trump. Quindi riflettere sul legame fra tecnologia e sistemi di sorveglianza e controllo, tecnologia e apparati di potere, tecnologia e capitalismo, significa mettere al centro il problema della libertà.
Andrea Fumagalli
Siamo tutti d’accordo nel considerare la guerra come atto economico consustanziale al capitalismo, fa parte del suo Dna. Nei 250 anni di storia del capitalismo ci sono stati momenti più o meno bellicosi, ma i periodi a più alta tensione si sono verificati nel Novecento. Da un punto di vista formale ma non sostanziale, possiamo dire che l’unica eccezione è il periodo fordista post Seconda guerra mondiale, a cui è corrisposto un equilibrio geopolitico basato su due blocchi e che ha portato i paesi a capitalismo avanzato a non tenere al primo posto la guerra per rilanciare l’accumulazione. Questo non significa che in questo periodo la guerra non ci sia stata, nel resto del mondo era ben presente.
Non credo sia un caso che la crisi del fordismo ha riacutizzato e accelerato la tensione bellica, con fattori che si sviluppano in ambiti locali per poi assumere connotati globali. Tutto ciò avviene in parallelo con il processo di globalizzazione dell’accumulazione. Si potrebbe proporre questa tesi: nel ‘900, tra I e II guerra mondiale, la guerra è servita come strumento di ripresa dell’accumulazione originaria. La distruzione materiale e umana richiede un processo di ricostruzione. Oggi, dagli ultimi 50 anni in poi, la guerra non svolge più esclusivamente la funzione di ricreare le basi per un’accumulazione capace di generare nuove forme di crisi e di ricchezza, ma essa stessa è diventata un modo di produzione capitalista. Perché? Mi convince l’analisi di Maurizio Lazzarato ma ho qualche perplessità su due aspetti. Il primo è che è vero che il ‘900 è stato il secolo della dollarizzazione e dell’egemonia, che implicava quindi una definizione su scala globale di un mondo unipolare o univalutario, sancito dagli accordi di Bretton Woods e che ha origine con la crisi dell’impero inglese, le crisi bancarie etc; ma gli ultimi 20 anni sono caratterizzati dalla crisi del dollaro, processo che richiede una reazione di cui la guerra Russia-Ucraina ne è espressione.
Il secondo aspetto è il seguente: solo oggi probabilmente possiamo cogliere un parallelismo tra la guerra e l’attività speculativa, in quanto strumenti di produzione economica. Speculazione e guerra sono quindi due facce della stessa medaglia. L’attività speculativa è il motore dell’attività capitalistica, con il ruolo egemone dei mercati finanziari che intervengono nel definire le forme di finanziamento della produzione, soprattutto per quanto riguarda quella intangibile, le forme di assicurazione sociale su scala distorta, selettiva e iniqua (pensiamo ad esempio ai fondi pensioni e interviene pesantemente nella distribuzione ineguale della ricchezza: plusvalenze, ruolo dei moltiplicatori finanziari che creano domanda distribuita in maniera non equa, a differenza di quanto accadeva col moltiplicatore keynesiano basato sulla spesa pubblica in deficit. La speculazione finanziaria ha creato degli oligopoli, esattamente come nel caso della produzione bellica, che sono in grado di intervenire pesantemente sulle soggettvità, sulle condizioni di vita, sui meccanismi di specializzazione e selezione, di produzione e così via.
Tutto ciò è stato possibile perché è venuto meno il ruolo della politica monetaria e delle banche centrali. È paradossale che si parli di autonomia delle banche centrali nel momento in cui non sono mai state così dipendenti e supine agli sviluppi delle convenzioni speculative internazionali, create dalle grandi imprese finanziarie. Si tratta di una delle cause interne della crisi del dollaro: all’aumento di peso delle borse americane, diminuisce la capacità di sviluppare una politica valutaria in grado di mantenere l’egemonia del dollaro. Oltre a ciò, ocorre considerare il fatto che gli Stati Uniti hanno utilizzato strumentalmente il dollaro come fonte di finanziamento del proprio debito estero, fattore strutturale dell’economia americana, al fine di creare un afflusso di capitale che potesse compensare il saldo negativo della bilancia commerciale. Inoltre, soprattutto negli ultimi tempi, è utilizzato come fonte di finanziamento del debito interno, della Fed, del bilancio pubblico.
La crisi della dollarizzazione mette in pericolo la capacità degli Usa di riuscire a mantenere nel futuro questo meccanismo di riequilibrio perché stanno venendo meno alcuni strumenti di egemonia militare, sociale ed economica da sempre utilizzati. Ad esempio, l’egemonia militare è stata messa in discussione dal Vietnam in poi; quella economica dalla perdita del primato tecnologico, con l’avvento del paradigma tecnologica dell’Ict che negli anni ’80 ha favorito per un primo periodo il Giappone, ricaduto poi in una situazione di crisi e stagnazione per via delle scelte di politiche e strategie industriali che non hanno pagato. Il tentativo di superare la rigidità della fabbrica con l’iper-taylorismo (toyotismo e il just in time), non ha funzionato ed è stato superato dal modello della subfornitura internazionalizzata della produzione a flussi statunitense, basata su una catena di valore con alla testa la tecnologia, i brevetti e i flussi finanziari, che esternalizza i mezzi di produzione cambiando totalmente la logica del sistema taylorista-fordista.
Questi sono elementi che hanno favorito e, allo stesso tempo, sono stati favoriti dal processo di finanziarizzazione e privatizzazione. Dal momento stesso in cui gli Stati Uniti hanno recuperato parzialmente l’egemonia produttiva-tecnologica grazie al controllo dei flussi di globalizzazione (in seguito al Washington Consesus), sono venuti fuori i tentativi di affrancamento economico che hanno ridotto il livello di assoggettamento economico e sociale di paesi come Cina e India. Da qui in avanti, gli Stati Uniti hanno due strade possibili: accettare l’idea di mondo multipolare o passare dall’assoggettamento alla coercizione. Qui la guerra gioca un ruolo fondamentale: essa è la continuazione della speculazione finanziaria con altri mezzi. Il controllo dei flussi finanziari aveva una funzione di regolazione perché è vero che siamo in piena crisi del diritto internazionale, ma questo non vuol dire che viviamo in un mondo senza regole perché esiste una gerarchia economica, una concentrazione nei mercati finanziari come mai prima d’ora era successo nella storia del capitalismo. Questo significa che c’è una regola: la legge del più forte.
Questa situazione è oggi in pericolo: gli Stati Uniti cercano di superare la crisi della dollarizzazione utilizzando l’euro e l’Europa come nemici strumentali. La crisi attuale è contro l’Europa, per minare la sua capacità di diventare un soggetto forte, possibilità assai remota alla luce della governance europea attuale. Non si può creare egemonia soltanto con una politica monetaria di stampo neoliberista o monetarista, sarebbe necessaria anche una politica fiscale, sociale e industriale per diventare una forza geopolitica a tutto tondo. Cosa che è stata in grado di fare la Cina: come già scriveva Arrighi, è stata capace di controllare il processo di finanziarizzazione e di costruire un’egemonia tecnologica in grado di definire delle specializzazione produttive ad alto valore aggiunto.
L’Europa rischia di passare da capro espiatorio, la guerra è dentro i suoi confini. È interessante vedere come si evolverà la situazione, al vertice di Samarcanda di settembre c’è stata una certa compattezza per un ordine non occidentale, anche se permangono delle contraddizioni. La situazione è pericolosa perché c’è molta instabilità, molta incertezza che favorisce la speculazione finanziaria. Inoltre questa guerra viene utilizzata per prevenire qualsiasi tensione sociale in Europa e negli Usa. In questo ultimo anno, infatti, c’è stata una ripresa dei movimenti del lavoro che hanno strappato un aumento del salario minimo ed una ridefinizione della struttura del mercato del lavoro americano. Queste tensioni richiedono un controllo interno, è stata la lezione di fine anni ’70, con il presidente della Fed Volcker: aumentare i tassi di interesse per rafforzare il dollaro, se da un lato rischia di penalizzare i mercati finanziari, dall’altro penalizza le richieste di progresso sociale e lavorativo.
Immagine: Ulay-Jurgen Klauke, 1975.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.