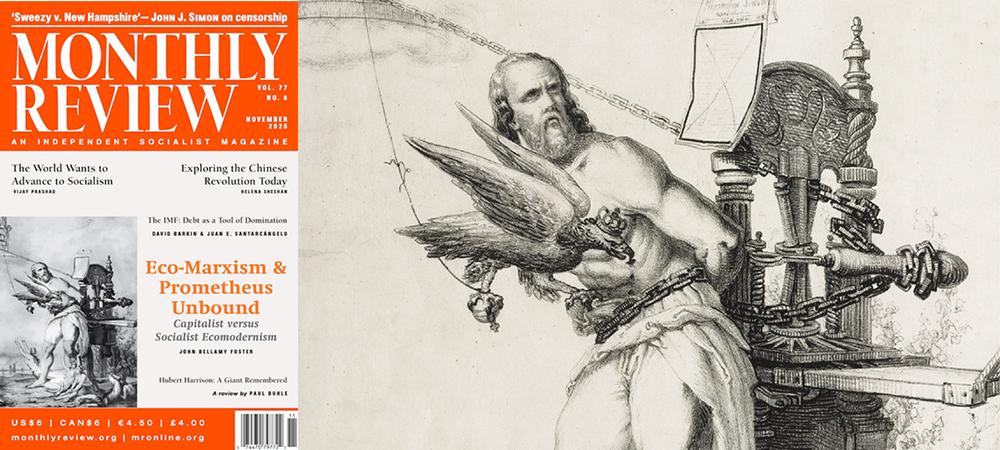L’urgenza di giustizia climatica e transizione energetica

Riportiamo da cuabologna.it la trascrizione dell’intervento di Emanuele Leonardi, docente e ricercatore dell’Università di Parma, portato lo scorso 29 aprile al ciclo di seminari “Pandemia: sintomi di una crisi ecologica globale”, interventi online per analizzare la crisi che stiamo attraversando secondo un’ottica ecologista. Qui la registrazione originale.
“Covid-19 e crisi economica globale: l’urgenza di giustizia climatica e transizione energetica”: questo seminario si inserisce nel ciclo di seminari online dal titolo “Pandemia, sintomi di una crisi ecologica globale” ciclo di interventi dentro e contro questa emergenza attraverso il quale cerchiamo di dotarci insieme di strumenti e conoscenze utili ad affrontare questa fase di pandemia e di post pandemia, e non solo. Infatti in questo momento ci stiamo tutti e tutte confrontando con questa profonda ed irreversibile crisi di portata globale le cui cause si possono individuare nel lunghissimo, se non incessante, processo di accumulazione operato dal sistema capitalista, un sistema che tramite una duplice azione di sfruttamento e appropriazione produce effetti devastanti sui corpi e sui territori.
Oggi con noi Emanuele Leonardi, ricercatore all’università di Parma che si occupa principalmente di ecologia politica, intesa come intersezione tra gli effetti di devastazione ambientale e l’agire dei movimenti e delle istituzioni in relazione a ciò, si occupa delle trasformazioni sul lavoro che avvengono nelle società contemporanee e oggi più che mai vediamo l’importanza dell’istituzione di un reddito di base incondizionato. Il seminario di oggi cercherà di leggere questa pandemia andando ad indagare i legami tra devastazione ambientale e diffusione di patogeni: questa crisi ci ha anche mostrato le contraddizioni intrinseche al sistema capitalista ed ha in questo modo anche aperto spazi ai movimenti in cui si può operare una rottura nei confronti di questo sistema, in particolar modo guarderemo alla giustizia climatica come ad una via da percorrere per convergere nelle lotte e quindi creare una società più inclusiva, più egualitaria, in relazione al vivente tutto, non solo a noi. Infine si guarderà anche al ruolo giocato da altri attori, spesso avversari o nemici con cui il movimento dovrà interfacciarsi in questo contesto nel quale sentiamo l’urgenza di una transizione energetica.
***
La prima questione che vorrei affrontare riguarda l’ecologia politica come chiave di lettura fondamentale per comprendere la pandemia dal punto di vista sia delle cause sia degli effetti. Il secondo punto riguarda la giustizia climatica intesa come strumento politico per l’organizzazione dei movimenti: se non ci sono dubbi che nel 2019 abbia vissuto una stagione esaltante (in tutto il mondo ma in particolar modo in Italia), è tuttavia lecito chiedersi cosa farne oggi – 29 aprile 2020 – in un momento in cui non è più immediato trovare in essa le risorse per definire un terreno utile alla convergenza delle lotte. Sosterrò che la congiuntura pandemica rende ancor più necessario e urgente rilanciare la scommessa della giustizia climatica come orizzonte comune delle critiche al capitalismo. Infine vorrei proporre alcuni spunti rispetto allo scenario globale all’interno del quale i temi della transizione ecologica ed energetica possono darsi efficacemente: cosa fanno i nostri interlocutori, come si muovono i nostri avversari? In questa terza e ultima parte mi interessa ragionare non solo – e non tanto – su quali siano le mosse possibili per noi, ma su come sia configurato il terreno politico su cui dovremo abituarci a camminare.
Comincio con un riferimento al famosissimo articolo di Mario Draghi uscito sul sito del Financial Times, nel quale vengono dette un sacco di cose interessanti, alcune condivisibili altre meno. In particolare ne viene implicata una che dal punto di vista dell’ecologia politica è fondamentale: la pandemia sarebbe uno shock esogeno, un cigno nero. Ciò di cui si occupa l’ecologia politica è dimostrare come questa affermazione non corrisponda al vero, a prescindere dal fatto che ci sia accordo o meno con i ragionamenti di Draghi (penso tra l’altro non ci sia la giusta attenzione per una figura che è sempre importante ascoltare perché non parla mai a vanvera). Le sue riflessioni sono come minimo incomplete se non si inseriscono in un quadro più ampio che vede la pandemia come al medesimo tempo uno shock esogeno e uno shock endogeno. Come dice Draghi, le pandemie esistono da ben prima che il capitalismo emergesse come una tipologia specifica di modo di produzione e poi come la tipologia di modo di produzione egemone – quale è incontestabilmente oggi. È altrettanto vero, però, che questa pandemia non si comprende se non all’interno della forma organizzativa che il capitalismo contemporaneo ha impresso al rapporto tra società e natura nel campo della produzione e poi in quello della riproduzione. In questo senso, la pandemia è uno shock completamente endogeno. Mi pare che il punto su cui insistere sia che è naturalmente sbagliato dire che il capitalismo crea la pandemia o addirittura il virus: è invece del tutto corretto sostenere che le forme produttive del capitalismo contemporaneo hanno accelerato la circolazione di patogeni che in circostanze non capitalistiche si sarebbero mossi molto lentamente: questa accelerazione ha comportato un innalzamento enorme della probabilità di una pandemia come quella attuale… del resto ne avevamo già avute tre nel ventunesimo secolo, come riportava Jim Robbins in un articolo del 2012. Questo significa che la radicalità del momento che viviamo dipende anche dal fatto che, se noi dovessimo uscire da questa crisi senza aver modificato in profondità le strutture che governano la produzione e la riproduzione, ci troveremmo in una situazione in cui la prossima pandemia potrebbe essere alle porte. Quattro pandemie, di cui una di questa portata, in vent’anni: non era mai accaduto… e naturalmente è legato alla forma particolare e determinata con cui il capitalismo organizza produzione e riproduzione. Svariati studi hanno mostrato come due delle dinamiche maggiormente dannose siano deforestazione e perdita di biodiversità, entrambe legate alla cosiddetta agroindustria (nonché al suo gigantismo). Luca De Crescenzo, in un bell’articolo uscito recentemente per Jacobin Italia, ha sostenuto (a mio avviso giustamente) che se gli effetti clima-alteranti dell’agroindustria sono stati studiati a fondo e sono sostanzialmente noti negli ambienti dell’attivismo legato alla giustizia ambientale e climatica (ma anche nei consessi internazionali sotto l’egida dell’ONU), molto meno studiati prima di questa pandemia, per quanto non ignoti, erano invece gli impatti microbiologici di questo stesso sistema agroindustriale.
L’autore di riferimento a questo proposito è Rob Wallace, epidemiologo che sta conoscendo una meritatissima fortuna in questi giorni, il cui libro fondamentale (pubblicato nel 2016) Big Farms Make Big Flu era fino a poche settimane fa confinato nei circuiti eco-socialisti, gruppi di studiosi o militanti che cercano di unire faticosamente la pratica e il pensiero ambientalista (in particolare quello legato alla decrescita) al pensiero rivoluzionario (nella sua ovvia pluralità). Ora, giustamente, il suo lavoro diventa più noto: in Italia è stata pubblicata sia un’intervista rilasciata originariamente a un blog tedesco, sia un articolo più lungo e impegnativo scritto con altri (“Covid-19 e circuiti del capitale”). Provo qui a semplificare le complesse tesi avanzate da Wallace e colleghi: la deforestazione riduce l’effetto diluizione che, rispetto alla circolazione dei patogeni, faceva sì che lo spillover (salto di specie, zoonosi in termine tecnico) incontrasse delle barriere naturali (le foreste) che lo rendevano meno probabile. Dunque: la deforestazione assottiglia l’effetto diluizione sia direttamente (accorciando la distanza tra comunità di esseri umani e comunità di animali) sia indirettamente (comportando una perdita di biodiversità che a sua volta si traduce in un ulteriore impoverimento dell’effetto diluizione). Ciò è dovuto a tre processi interconnessi: il primo è la coltivazione intensiva legata a monocolture agricole; il secondo è l’allevamento intensivo ancorato a monocolture genetiche dei capi di bestiame; il terzo è l’urbanizzazione, che in questo caso si può definire letteralmente “selvaggia”, nel senso che animali “esotici”, posti a stretto contatto con agglomerati urbani, diventano vettori di patogeni in sé non particolarmente dannosi per ma che invece, in presenza di un possibile salto di specie possono diventare gravissimi – che è poi ciò che stiamo vedendo con questa pandemia. Ho provato a semplificare un ragionamento molto complesso – citando però le fonti, di modo che ognuno possa approfondire, volendo – ma qui mi interessava porre l’attenzione su due punti per poi andare avanti nel dibattito. Il primo riguarda la razionalità basata sul profitto, che è antitetica (e si vede benissimo in questi esempi) rispetto alla ragionevolezza del benessere e della giustizia. Per quale motivo? In primo luogo perché, per massimizzare il profitto, si devono omogeneizzare le colture genetiche e questo produce le condizioni più adatte per la circolazione dei patogeni e per il salto di specie. Un secondo dato è che, dal punto di vista delle grandi multinazionali, che seguono la razionalità del profitto antitetica a quella del benessere, è perfettamente ragionevole correre il rischio di scatenare un’epidemia (persino una pandemia globale!) perché quando va bene i guadagni vengono internalizzati e nulla viene redistribuito, mentre quando va male i costi vengono esternalizzati, da un lato sulle società – e vediamo bene la pressione cui è sottoposto il servizio sanitario in Italia e ovunque nel mondo (dove c’è) – dall’altro lato sull’ambiente naturale. Questo naturalmente ci pone di fronte alla radicalità dello scenario nel quale siamo immersi: uscire da questa crisi con una modalità del tipo “si torna al business as usual, appena finita questa situazione si ricomincia come prima”, significa intensificare quei processi che hanno reso più probabile il salto di specie e quindi la plausibilità di una pandemia come quella cui stiamo assistendo. Si tratta di un circolo vizioso che a mio avviso giustifica la tesi che ha sostenuto Riccardo Bellofiore in un recente scritto: “Ci troviamo in una situazione di maturità del problema del comunismo”. Quello che intende è che o il cambio di rotta è radicale, la svolta è profondissima… oppure ci troviamo in una situazione che rende ancora più probabile l’avvento di un problema simile a o addirittura più grave di quello che stiamo affrontando adesso.

Passiamo ora al secondo punto che volevo toccare, di nuovo con un riferimento a uno scritto recente. Ida Dominijanni, sul sito di Internazionale, in un articolo di cui consiglio la lettura intitolato “Non siamo più gli stessi”, concludeva il suo ragionamento dicendo che il problema vero che ci troviamo ad affrontare oggi è che, in questa situazione di cambiamento in cui siamo, si danno comunque dei conflitti sociali: non è vero che la società è pacificata; piuttosto, abbiamo di fronte un problema enorme perché non sappiamo come ci si organizza dentro le restrizioni, il confinamento, il distanziamento sia fisico sia, quando non c’è azione politica, sociale. Io suggerirei di riconsiderare, come cornice politica capace di dare alcune indicazioni rispetto all’organizzazione in questa fase, la giustizia climatica. Sono consapevole che possa sembrare bizzarro che io avanzi questo suggerimento, perché una delle persone-simbolo del movimento per la giustizia climatica nel 2019, Greta Thunberg, nelle sue dichiarazioni ha sostenuto che la pandemia sarebbe un problema diverso rispetto alla crisi climatica – sarebbero due crisi diverse e adesso dobbiamo seguire quello che ci dicono gli scienziati e risolvere il problema della pandemia, poi – dopo – appena si potrà torneremo a occuparci del cambiamento climatico. La prospettiva di ecologia politica che ho delineato rapidissimamente prima dice esattamente l’opposto: il cambiamento climatico e il Covid-19 sono espressione di una medesima crisi ecologica e vanno quindi affrontati assieme, simultaneamente. Ci tengo a sottolineare che in generale i movimenti per la giustizia climatica non hanno assunto questa posizione: per esempio una lettera di FFF Italia sconfessava implicitamente questa chiave di lettura proposta da Greta Thunberg, e così altri movimenti (mi vengono in mente alcuni nodi italiani di Extinction Rebellion). Insomma: anche nel contenitore “giustizia climatica” non c’è né pacificazione né stasi.

Se noi però torniamo ad alcuni dei suoi tratti fondamentali per come è “esploso” nel 2019, allora vediamo che possono essere molto utili nella fase attuale. Ci sono due punti su cui vorrei soffermarmi. Come prima cosa, la grande svolta della sollevazione del 2019 sta nel fatto che gli scioperi climatici hanno completamente rovesciato il significato politico del riscaldamento globale e della crisi ecologica: laddove prima dire “cambiamento climatico” significava delineare scenari di sventura, apocalissi, catastrofi, a partire dal 15 di marzo – primo sciopero climatico globale – dire “riscaldamento globale” significa pensare a milioni di persone in piazza, a una generazione precedentemente poco politicizzata e ora molto partecipe, a pratiche di piazza e di gestione delle assemblee innovative o comunque molto diverse da quelle cui eravamo abituati. Questo ha aperto uno spazio di azione politica. Oggi dire “cambiamento climatico” significa avere in testa persone che scendono in piazza per reclamare un mondo desiderabile: non per evitare il peggio ma per mettere in piedi la possibilità di costruire un rapporto tra società e natura che sia molto più sano di quello attuale, non solo perché permetterebbe la vivibilità e quindi garantirebbe la salute delle popolazioni, ma perché è ciò che permetterebbe di democratizzarci, di rimettere il potere nelle mani dei molti, di decidere cosa è importante e cosa no in primo luogo rispetto alla produzione. Come si produce, e cosa? In quali posti, in quali modalità? Per chi? Chi paga? Chi lo fa? Queste domande sono a mio avviso quelle più importanti. Il secondo elemento che vorrei segnalare è che la giustizia climatica, in Italia e non solo, nel 2019 ha conosciuto un percorso di sviluppo, di maturazione: se nella prima fase prevaleva un approccio “individualista” e centrato sulle modifiche negli stili di vita e di consumo, ciò non è più il caso a partire dal terzo sciopero climatico globale del 27 settembre, quando da un lato si apre un proficuo terreno di confronto con le forze sindacali (in particolare quelle di base, ma non solo), e dall’altro il 5 ottobre in Italia esce il report della seconda assemblea nazionale che è molto avanzato dal punto di vista dell’ecologia politica. È evidente che, dentro la cornice della giustizia climatica, si debbano includere tutti quei movimenti che si danno sul terreno della riproduzione sociale: quel mese di marzo 2019 ha dato un’indicazione chiara: l’8 marzo con il movimento transfemminista transnazionale di NUDM; il 15 marzo i movimenti più recenti fondati sulla questione climatica come FridaysForFuture ed Extinction Rebellion; il 21 marzo con la marcia contro le grandi opere inutili e dannose che invece raccoglieva tutti i movimenti territoriali attivi nel nostro paese (e non solo) da molti più anni, che sono poi movimenti per la giustizia climatica ante litteram e che si sono apertamente richiamati a questo concetto a partire da quel momento. È utilizzabile oggi quella cornice politica che dice sostanzialmente che l’unico modo per risolvere il problema climatico è abbattere le disuguaglianze sociali e viceversa, con una cesura molto netta rispetto al ventennio precedente? Io penso di sì: si può applicare a tutti e tre i fronti di conflitto aperti dalla pandemia nel nostro paese e può anche, addirittura, rappresentare un terreno di convergenza per queste tre istanze.
Il primo di questi tre fronti è quello che riguarda l’insubordinazione operaia che, a partire dal DPCM dell’11 di marzo fino almeno al 25 di marzo (ma ancora adesso), rappresenta il momento più originale e inaspettato di questa fase: nel momento in cui Conte dice che verrà chiuso tutto tranne le fabbriche – questo ce lo raccontano benissimo Nadia Garbellini e Matteo Gaddi in due articoli scritti per la Fondazione Sabattini e poi nell’intervista per il sito “Le erbacce” – la risposta operaia è che chi lavora non è carne da macello: prima la salute. Si apre così un fronte di conflitto non solo serrato ma molto esplicito ed evidente tra il primato della salute e il primato del profitto. Ciò ha imposto a tutti i soggetti sociali di situarsi innanzitutto lungo quel discrimine politico – e ovviamente chi fa riferimento all’ecologia politica non ha avuto il minimo dubbio a schierarsi al fianco del punto di vista operaio.

Il secondo fronte riguarda il punto di vista precario, le campagne per il reddito di quarantena o l’estensione del reddito di cittadinanza lungo le linee di riflessione legate al reddito di base o ancora al reddito di cura. Voglio segnalare un bell’articolo di Luca Cigna e Lorenzo Velotti uscito di recente su Jacobin Italia, che esplora il motivo per cui esiste una dimensione ecologica del reddito di base, perché una tale misura andrebbe a disarticolare il nesso produttivista tra crescita economica e piena occupazione che era stato invece al centro del meccanismo di inclusione sociale tipico dei Trenta Gloriosi (periodo fordista). Qui si aprono degli scenari importanti nel momento in cui l’esigenza che la pandemia ci consegna non è quella di mobilitare più lavoro, ma piuttosto di smobilitare una parte di lavoro che oggi è dannosa e al contempo rimodulare un’altra parte, un tipo diverso di lavoro, che è sempre più necessario per produrre società – anzi: buona società. Un esempio possibile è il lavoro riproduttivo.
Il terzo fronte è quello legato al mutualismo dentro la pandemia, vale a dire le brigate di solidarietà. Di nuovo, qui il protagonismo è tutto della riproduzione sociale, il terreno di lotta è quello del welfare. Ci sono già, però, alcune esperienze che hanno legato il tentativo di praticare la solidarietà attiva – e quindi di andare ad aggredire situazioni di disagio sociale – al rapporto con fornitori locali che rispettino sia i terreni sia i lavoratori e le lavoratrici che li coltivano. L’idea è dunque quella di accorciare la filiera, utilizzare catene di fornitura che siano politicamente più dignitose – dal punto di vista sia ecologico sia sociale – e quindi di unire i tre aspetti: solidarietà sociale, lotta al disagio e accorciamento delle filiere (in una parola: sovranità alimentare – che è la via prioritaria per invertire quel trend di cui parlavamo nel primo blocco e per sottrarre forza sociale al mondo dell’agribusiness che è l’opposto della sovranità alimentare, e in realtà fragilizza sia la fornitura di cibo che le comunità di produttori e produttrici). Per queste ragioni credo che la giustizia climatica sia un’ottima cornice politica per leggere questi fronti di lotta all’interno della situazione tragica in cui ci stiamo muovendo.
Ultimo punto: gli interlocutori e gli avversari dei movimenti per la giustizia climatica. Richiamo un passaggio secondo me importante: se noi consideriamo il modo in cui la governance climatica – ma anche quella ambientale, più in generale – si è data, a partire dal Protocollo di Kyoto nel ’97 fino ad arrivare all’Accordo di Parigi del 2015, c’è stata una sorta di divisione del lavoro tra agenti del capitalismo fossile e green economy. Per quanto riguarda i primi, essi hanno continuato a tirare le fila del ragionamento nel campo della pratica, nel campo energetico: un esempio su tutti è il fatto che i sussidi pubblici a queste forme di estrattivismo non sono mai venuti meno e che la discussione non si sia neanche mai aperta all’interno delle Convenzioni ONU (né quella sui cambiamenti climatici né quella sulla biodiversità). A livello discorsivo, però, era lasciato ampio spazio a quello che potremmo definire capitalismo verdeo green economy, la cui scommessa principale era leggere la crisi ecologica e climatica come un fallimento del mercato (che non ha saputo internalizzare le esternalità negative) che tuttavia poteva risolversi solo attraverso altri mercati, nuovi mercati, che avessero la capacità di “dare un prezzo alla natura” – cioè di contabilizzare le esternalità e metterle a bilancio.
Questa scommessa teorica e pratica, che è stata indiscutibilmente egemone nel contesto delle Nazioni Unite fino al 2015, si è progressivamente sgretolata fino a esplodere nel dicembre 2018 a Katowice, quando diventa famosa Greta Thunberg, e a polverizzarsi nel corso dell’anno successivo, quando emergono con grande chiarezza in quello stesso consesso due posizioni molto chiare. Da un lato ci sono i negazionisti, che non concedono più che il cambiamento climatico sia una realtà di fatto e rivendicano esplicitamente che in realtà non ci sia nulla di specificamente umano tra le cause del cambiamento climatico (e quindi che esso non dipenda da noi come specie o dal nostro modo di produrre) e dall’altro lato ci sono le piazze che riconquistano la loro legittimità proprio sulla base del fatto che la scommessa del capitalismo verde non potesse essere riproposta. Abbiamo visto esimi rappresentanti della green economy – su tutti Macron – messi all’angolo durante il 2019: all’inizio c’è stato un tentativo di recuperare il “fenomeno” Greta Thunberg, ma a partire dal terzo sciopero climatico globale si è dovuto prendere atto che effettivamente c’era incompatibilità profonda tra quanto loro andavano dicendo (“più austerità, più mercato significa miglioramento ambientale”: scommessa persa dal punto di vista empirico in maniera molto evidente) e quanto dicevano Greta e le piazze.
Noi possiamo chiederci, per capire quale sia lo scenario in cui ci muoviamo, cosa succeda a questi due campi in questo momento, dentro la pandemia. Il primo campo, quello legato al capitalismo “fossile”, è alle prese con il problema non indifferente del mercato del petrolio in grande difficoltà: io non credo che il momento cruciale sia il barile di petrolio che va a -18 dollari il 21 di aprile – c’erano meccanismi assicurativi che hanno determinato quella situazione (infatti nei giorni successivi il prezzo del petrolio è tornato a un livello positivo e stabile, per quanto molto basso) – ma che il problema vada inquadrato in altro modo. Da un lato vediamo come il problema sia dentro la crisi dell’accordo tra Russia e Arabia Saudita: esso aveva garantito, tra il 2016 e il 2020, una stabilità dei prezzi del petrolio tra i 50 e gli 80 dollari al barile, cioè una quota superiore a quella richiesta all’industria americana delle fonti fossili non convenzionali – sabbie bituminose in Canada e gas di scisto negli USA: nuove fonti di approvvigionamento che erano state fondamentali per la dichiarata e sbandierata indipendenza energetica nord-americana. All’inizio di marzo l’accordo dentro Opec Plus tra Russia e Arabia Saudita (e altri paesi) si rompe e questo provoca un aumento della produzione sia dal lato russo che dal lato saudita, con effetto di un calo dei prezzi, che con la pandemia si accelera considerevolmente: questo causa il fatto che l’industria del fracking (gas di scisto) in particolare negli Stati Uniti venga messa, forse definitivamente, fuori gioco. Questo avrà un effetto globale importante: sembra che si possa dare uno sviluppo (molto negativo dal nostro punto di vista) per il quale questa crisi in realtà serva a far collassare le aziende più piccole, far concentrare gli asset migliori nelle mani delle grandi aziende petrolifere, e quindi in realtà si possa dare una situazione nella quale c’è un calo profondo del prezzo dell’estrazione poi seguito da un’accelerazione, da un effetto rimbalzo. Questa ovviamente è la posta in gioco di un conflitto: se il blocco dei negazionisti riuscirà a essere egemone e ad acquisire una forza sociale che gli permetta di fare ciò che vorrebbe, è certamente possibile che l’industria del petrolio esca addirittura rafforzata da questa crisi – che tuttavia è indiscutibilmente una crisi e dunque apre scenari anche di tipo diverso.
Più interessante, secondo me, è però quello che sta succedendo nell’altro campo, quello del capitalismo verde, che in qualche modo – messo all’angolo nel 2019 – oggi si trova nella situazione piuttosto scomoda di avere da un lato il gruppo dei paesi e delle aziende negazioniste che acquisisce una sua forza (e che potrebbe comportare un rientro nei ranghi della componente “progressista” che bollerebbe così l’interesse per la compatibilità ambientale come un errore di gioventù) e dall’altro lato la possibilità di saldarsi alla marea che è uscita dalle piazze e che oggi trova ulteriore spazio nella circolazione dei ragionamenti sull’ecologia politica e sulla giustizia climatica. Questo punto è interessante perché sembra segnare la fine di quella che era stata la scommessa dei vari Macron, cioè che la transizione energetica ecologica sarebbe avvenuta in un contesto di crescita sostenuta (meglio: con una crescita sostenuta del PIL sarebbe stato possibile attingere a risorse aggiuntive da investire in rinnovabili e in altri piani, e questo avrebbe comportato la possibilità di mettere in pratica una compatibilità tra innalzamento del livello dei profitti e riduzione dell’impatto ambientale). Questo scenario da modernizzazione ecologica è oggi del tutto impraticabile, perciò anche dal loro punto di vista diventa complicato scegliere tra l’opzione del ritorno all’ovile con i negazionisti oppure della saldatura alle piazze.

Questo è tutto un processo in divenire che potrebbe invertirsi o essere bloccato già nell’immediato; c’è però un certo tipo di politicizzazione di quella piccola parte del mondo scientifico che ha avuto una forte esposizione negli ultimi anni (quella legata alla governance climatica e ambientale) che comincia a prendere posizioni abbastanza forti. L’anno scorso è stato il caso dell’IPCC, ora un altro caso interessante è quello della Piattaforma Intergovernativa sulla Biodiversità e sui Servizi Ecosistemici, che è sostanzialmente un equivalente funzionale dell’IPCC per la convenzione sulla biodiversità (non per quella sui cambiamenti climatici) ma che ha avuto all’incirca lo stesso atteggiamento: raccomandazioni di politica pubblica fortemente avanzate, che di norma cadevano nel vuoto ma che avevano come retroterra l’idea di accelerare i processi di mercatizzazione basati sull’idea discussa in precedenza, cioè che solo il mercato può risolvere un problema creato dal mercato. L’ultimo documento ospitato dal sito di questo IPBES dice cose davvero molto diverse: non solo nella prima parte prende per buona la chiave interpretativa che abbiamo descritto nel primo blocco (anche se più che nominare come colpevole il capitalismo punta il dito contro l’umanità), ma nel momento in cui si fanno le raccomandazioni di politica pubblica va ben oltre ciò che era stato fatto in passato dall’IPCC, attraverso tre richieste. La prima, molto importante, è quella di un ritorno a una forte regolazione ambientale (l’esatto opposto di quello che hanno chiesto e ottenuto le grandi aziende del fossile – come stimolo alla ripresa economica). Il secondo punto è la raccomandazione di utilizzare come approccio sistemico la questione della salute, che ovviamente comprende anche il tema della salute degli ecosistemi e dei non umani più in generale, ed esprime una critica immediata all’incentivo all’esternalizzazione dei costi ambientali e sociali, che abbiamo visto essere alla base della incompatibilità tra profitto e salute umana e ambientale. Il terzo punto, egualmente rilevante, è quello di investire nelle infrastrutture sanitarie, di creare un sistema sanitario nazionale, in connessione e non in contrapposizione con quelle che sono le conoscenze tradizionali dei popoli nativi, che sono state tra le vittime primarie dell’azione dei negazionisti in Nord America e anche altrove. La politicizzazione di questi organi, che hanno in primo luogo una valenza scientifica, a me pare un elemento di speranza capace di controbilanciare la diffusione del negazionismo – anche se ovviamente non so quanto: quella è la posta in gioco del conflitto politico. Se da un lato è probabile che il fronte negazionista riesca a rilanciare il modello petrolifero oggi in crisi, dall’altro è possibile invece che i movimenti e le piazze trovino nuovi alleati coi quali è possibile costruire alleanze sociali. Penso si possa costruire una composizione favorevole alla giustizia climatica che sappia agire la convergenza tra i soggetti dei fronti che ho elencato sul piano nazionale, cioè: il fronte sindacale, il fronte precario e il fronte della riproduzione sociale.
In arrivo la trascrizione della seconda parte del seminario
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.