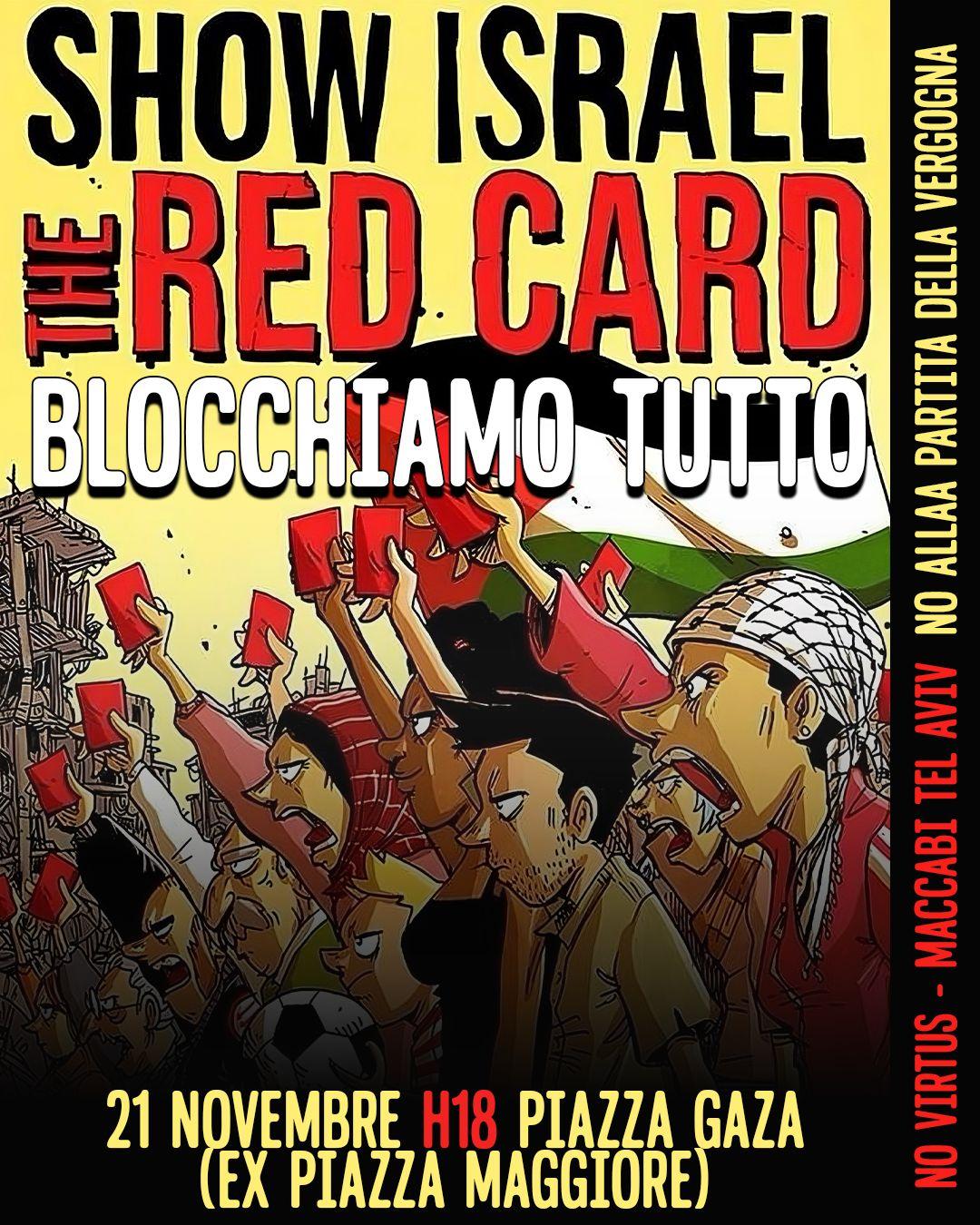Solo ammaestrati dalla realtà potremo cambiare la realtà

Sono molte le domande che ci poniamo collettivamente. Certamente all’oggi non è l’Università il centro gravitazionale delle lotte metropolitane. La zona universitaria come porzione di città, l’Università come istituzione e spazio-temporalità, come luogo, periodo e modo del dominio, ambivalentemente azienda e occasione potenzialmente formativa, può essere comunque il campo, uno dei campi dello scontro sociale? Come attraversiamo oggi gli spazi universitari? Con che comportamenti? Siamo omogenei? Quali volontà, aspettative, desideri spingono ad iscriversi ancora all’Università? Il nuovo calcolo Isee diminuirà il numero di coloro che potranno usufruire della borsa di studio, le alte tasse già impediscono o complicano a sempre più uomini e donne il percorso universitario, l’accesso alla cultura latamente intesa è messo in crisi dai prezzi inaccessibili per disoccupati, precari, studenti fuorisede o autoctoni. Servizi di prima necessità, come trasporti e vitto, anch’essi non raggiungibili per quanti riescono appena a pagare l’affitto in case in cui, pur di risparmiare, si vive ammassati. Eppure, nonostante ciò, anche quest’anno si sono registrate iscrizioni in crescita all’Alma Mater, il 5% in più rispetto all’anno 2013-2014 (23.000 nuove matricole, di cui più di 19.000 borsiste). Questo dato è in contraddizione solo apparente con l’inefficienza reale dell’università a rispondere ai bisogni degli studenti e delle studentesse. Spesso, è inutile negarlo, di fronte all’assenza di un’alternativa vera e praticabile, si preferisce sacrificarsi e stringere i denti, piuttosto che rinunciare ad un sogno di parziale autonomia dalla famiglia, o di crescita sociale, o di crescita culturale.
Alle ore di lezione e studio si affiancano spesso lavori precari, sottopagati e affatto stimolanti (ad ulteriore conferma che il lavoro non gratifica, né tanto meno rende liberi, come il PD bolognese ha tentato di convincere nel 2013), a tutto svantaggio del tempo per la socialità, del tempo di vita propriamente inteso. Questa condizione, che anche molti compagni e compagne vivono sulla pelle, non è la soluzione alla crisi, non di sopravvivere a stenti si deve trattare. Siamo edonisti. Credere nella lotta per la creazione e conquista di vera autonomia, di vera libertà dalla costante messa a valore delle nostre forze ed intelligenze. Credere alla possibilità reale di sottrazione di tempo al lavoro, di liberazione di tempo dal lavoro, in ogni sua forma.
Come è possibile, oggi, individuare e praticare la via della liberazione, non in un punto ma processualmente, da un rapporto, quello capitalistico, che continua la sua sovradeterminazione? La disoccupazione e la precarietà possono essere uno spazio di possibilità in cui immaginare nuovi tempi e forme di vita? L’occasione per sostituire all’aspettativa (quasi sempre tradita) del lavoro, il superamento pratico, nella riappropriazione, di questa attesa? Possono essere l’opportunità per immaginare l’avvenire altrimenti che nell’unica forma di “tempo salariato”? Cosa significa materialmente sottrarre tempo al lavoro, risignificare lo spazio vuoto della disoccupazione, credere alla decostruzione possibile del tabù salario, controsoggettivarsi oggi nella precarietà?Abbiamo provato a dare delle risposte, che non si contendessero la “verità” nel cielo delle idee ma, de-siderandole, fossero discussione sull’evidenza di lotte reali, sulla forza o debolezza di presenti opzioni di liberazione. Assente la certezza di reddito da lavoro per molti e molte, apparentemente di là da venire una redistribuzione della ricchezza dall’alto, crollato il sistema welfaristico, spesso residuale l’apporto economico della famiglia, servizi anche di prima necessità inaccessibili per tanti e tante, come avere la garanzia del reddito? Le occupazioni abitative rispondono. Riappropriazione diretta come salto, sostituzione della traiettoria dell’aspettativa con l’immediata soluzione collettiva ad un problema collettivo. Occupare per non dover pagare l’affitto, occupare per non dover lavorare, occupare per stare insieme, riscoprire la vita come sociale, risignificazione del tempo vuoto, negazione del principium individuationis nella solidarietà, superamento dell’angustia stretta tra non-lavoro e non-reddito, pratica insufficiente ma reale di rottura parziale del rapporto di dominio capitalistico, impegno per un presente degno, rifiuto del sacrificio, della miseria nell’attesa messianica di un futuro astratto, fuori dal tempo.
Quando sperimentiamo nel discorso e nella pratica quelle forme di lotta, spesso e di necessità consideriamo il portato, il lascito delle lotte passate. “Nella gioia e nella rabbia” ha voluto aprire, criticamente, una finestra sulla memoria dello scontro sociale e su sul metodo soprattutto. Non si tratta di riproporre oggi, uguale e tonda, una stagione di conflitti, di forzare il ritorno all’attuale di intuizioni teoriche e pratiche come fossero la nota “verità in tasca”, la pillolina da somministrare in cura ad ogni generazione. Alla nostalgia per una stagione che osserviamo da lontano, preferiamo il desiderio dello scontro con l’oggi, alla sentita mancanza, abulica, romanticheggiante e borghese, delle belle lotte di ieri (alla maniera di chi fa della propria pigrizia, o sfiducia, la teoria della grande tristezza, o peggio, alla maniera di chi con la propria nostalgia costruisce un’improbabile e goffa teoria, ed estetica, del ritorno), preferiamo la ferma e lucida analisi dell’oggi, con le sue contraddizioni, le sue discontinuità interne, le sue opportunità. Quel patrimonio è maestro, ma non si tratta di riprodurlo come si farebbe con un’immagine. Rifiuto del lavoro oggi, partigiani oggi, non tradisce l’aspirazione a consegnare al presente quel passato per come si è dato nell’aspetto, non ci comanda un giudizio di gusto, ma di metodo.Non sappiamo se torneranno i carri armati in Via Zamboni, sappiamo però che su Piazza Verdi si gioca una battaglia di vitale importanza per la libertà di tutti e tutte, che per difenderla spesso il potere mostra i muscoli, che si rende spesso necessaria la forza nostra, che quaranta celerini messi in fuga non sono né un esercito, né l’inizio di una stagione di ferma, stabile, costante liberazione della piazza.
Non sappiamo se e quando ci saranno altri caduti, ovviamente speriamo mai, ma è d’obbligo ricordare i morti della nostra parte. Perché caddero sulle strade di tutti i giorni, e perché sono l’esempio. Sono un esempio di etica, di sincerità e passione rivoluzionaria, il manifesto vivente che per loro, che morirono, lo scontro sociale non era un gioco (pensiamo a Pedro giustiziato a Trieste nel 1985 da Digos e Sisde, a Carlo Giuliani, e più ancora a Remì ucciso dalla polizia francese il 30 ottobre scorso, loro sono fratelli, loro un altro esempio). Per loro, per noi!, la lotta sociale è questione di vita o di morte. Senza senso della recita, sull’orlo di nessun baratro, ma sulla cresta dell’onda del presente: praticare la prima linea. Questo crediamo abbia significato scendere in corteo in memoria di Francesco. Non la mera liturgia di parte (che fosse solo rito verrebbe pure a noia) ma la prova asfalto, scarpe e programma che le lotte di oggi sono l’unica, l’unica sede in cui vale, ed ha significato, referente!, il gesto collettivo e militante della commemorazione. Che se in piazza scende lo scontro sociale oggi, allora quei fori di proiettili, quella sosta in Via Mascarella, quelle corone di fiori hanno significato politico, senso della storia come susseguirsi discontinuo di emersioni politiche, hanno nel movimento il referente. Non altrimenti. I pugni alzati possono essere un bel gesto di stretching o la promessa che noi come loro siamo disposti a morire, nel senso esatto del termine, a lasciar cadere una volta per tutte la luce dai nostri occhi, siamo disposti ad essere arrestati, cacciati, se della lotta per la dignità degli uomini e delle donne si parla. Di fronte alla lapide di Lorusso i compagni e le compagne occupanti hanno lasciato una corona di fiori, così i militanti storici, alcuni hanno posto, in monito, una targa sulla teca che protegge i segni dei proiettili, i cordoni si sono stretti e un compagno ha domandato: come si può unirsi in vera fratellanza e sorellanza se non si è disposti a dimenticare il proprio interesse privato?
Quando la memoria si fa colore e disegno sulle nostre mura, sulle mura della zona universitaria, assume un fondamentale impegno significante. Il murales per Francesco è lì, sul 25 di Via Zamboni, a ricordare a chi passa, giorno notte e giorno, che quelle strade non sono soltanto il diaframma, il canale spazio-temporale per trasferirsi da una lezione alla mensa, all’aula studio eccetera, non hanno il piccolo respiro di un piccolo intorno del presente, abitato da quella che vorrebbero fosse la nostra norma e quotidianità universitaria. Quelle strade sono lì da anni, e per anni sono state la base, il suolo donde partivano e si formavano idee e intuizioni a servizio della lotta contro lo stato di cose. Quei murales significano una porzione del tessuto urbano altrimenti che coi segni con cui si narra la metropoli vetrina, la metropoli gentrificata. Sono il tentativo di fare questo territorio secondo il nostro passato, secondo la nostra interpretazione del tempo e del mondo, secondo il nostro punto di vista altro ed ostile a quello che si indigna per un disegno murario (salvo poi riconoscerne il valore, allor quando, ahi noi, scema il portato politico ed anche il padroncino si concede il vizio del giudizio di gusto, della nostalgia delle belle lotte). Dare sede geografica a comportamenti e segni antagonisti. Territorializzazione diacronica e sincronica. Il murales in Piazza Verdi e quelli su Via Zamboni sono lì per costruire pezzo a pezzo, nel tempo, una zona universitaria che coi suoi segni si dica, sia!, anche come la vedono e sentono tanti studenti e studentesse, stufi della ritmica scolastica, asfissiante ed alienante, stufi del codice etico, stufi dell’università altoprodotta, determinati e risoluti a prendersi i propri spazi di autogestione, a creare e conquistare spazi di autonomia dentro l’università, contro la gestione accademica aziendalistica, oltre il contorno murario, verso i suoi bordi, la piazza, la mensa, i cinema, le case vuote, il teatro, le mostre, dove incrociare la strada di altri precari e precarie, migranti o autoctoni che siano.
“Nella gioia e nella rabbia” non è stato un contenitore che, in un oasi di tempo, ha garantito la messa in mostra, la performance alle lotte sociali, studentesche e non, che si sono sviluppate sul territorio bolognese. Non è stata una festa dei microconflitti, ma l’occasione per strutturare, tematizzare un rapporto con la memoria storica affatto nostalgico ed estremamente materialistico. Fare territorio anche e soprattutto con metodo del ricordo. Essere partigiani oggi, che significa? Quale punto di vista, quale posizione assume il partigiano oggi? Come si è di parte negli anni dieci del 21esimo secolo? Senza astrazioni, ma con la materialità delle lotte in atto. Abitare la linea dove si scontrano come a formare un uragano i venti della legalità e della legittimità, questo facciamo quotidianamente in Val di Susa, nelle occupazioni abitative, ai picchetti della logistica, quando stringiamo i cordoni per difendere il diritto assembleare in piazza.
Spazi di soggettivazione contro, spazi di autonomia (la memoria viva sono le lotte di oggi).
Di nuovo, il diritto e il referente alla commemorazione dei compagni e delle compagne cadut*lo consegnano non l’arbitrio, ma le lotte quotidiane che presentemente si sviluppano nei territori, nel nostro caso bolognese. Come studenti e studentesse il terreno primo, quello a noi più vicino, che attraversiamo e significhiamo tutti i giorni, è la zona universitaria, una porzione di città ad alta e quasi totale popolazione studentesca-precaria. Qui tutto punta a girare attorno al centro-studente come consumatore di cultura, cibo, servizi. Di questa centralità materiale non è però chiesto conto alcuno o quasi allo studente stesso, e piuttosto che argomentare o avere l’opportunità reale di esprimere e costruirsi il suo territorio su misura, si trova ad avere, prima che delle opportunità finite, già dei bisogni standard e precostituiti cui farebbero riferimento i servizi elargiti dall’alto. Insomma, se ne vorrebbero pre-costituire, pre-ordinare e le domande e le risposte. Nell’ottica di una circolazione regolata della merce-studente, senza sussulti e con l’illusione dell’offerta, della libertà e decisionale e creativa.Spesso in molti e molte sfuggono a questo meccanismo, spesso a fasulli spazi di libertà gli studenti sanno, collettivamente, sostituire veri spazi d’autonomia. Gli studentati occupati, le autoriduzioni in mensa, a teatro e in ultimo alla mostra di Escher sono il tentativo ancora embrionale, insufficiente e parziale di sostituire all’aspettativa del reddito da lavoro la riappropriazione immediata: saperi, vitto e alloggio. Sono l’esperienza pratica che fonda la politicizzazione possibile di quei bisogni. Non crediamo basti rubare un pezzo di formaggio, e farlo spesso, per sancire l’imminenza della rivoluzione. Ciò che passa tra l’azione individuale (anche reiterata e diffusa, ma pur sempre individuale) e la lotta collettiva, è lo spazio dell’organizzazione.Riconoscersi collettivo come parte offesa all’interno di un ciclo onnicomprensivo di messa a valore, fare politici quei bisogni, esaudirli nella riappropriazione diretta, deastrazione della creatura “studente precario”, soggettivazione contro, lotta metropolitana meticcia. Le occupazioni in università, con cui continuiamo ad abitare quelle mura e a farlo autonomamente, sono l’occasione per dibattere, sviluppare e tentare e praticare altra socialità, altri saperi, esterni e liberi dalle maglie ideologiche statuali. La zona universitaria, nelle sue contraddizioni, è vivificata da comportamenti eterogenei e spesso ostili ad ogni forma di controllo sociale. Siamo in costante tensione tra desiderio e ostacolo, nella quotidiana ricerca di vie di fuga non dalla piazza, non dalle vie, ma dalle pastoie predisposte da chi ha a cuore soltanto il profitto. Conflitto oggi in zona universitaria, liberazione di tempo di vita dal profitto, organizzazione dal basso per la riappropriazione diretta, spazio-temporalità autonoma in cui strada non sia soltanto tragitto, tempo pausa, in cui nuovi comportamenti sappiamo radicarsi e farsi il proprio coerente territorio attorno, fuori dalle temporalità routinanti e accademiche, fuori dalla messa a valore costante di forza e intelligenza, verso la città, verso le periferie in lotta, per una ridefinizione complessiva del tessuto urbano, della sua geografia e conformazione, per la risignificazione per-noi degli spazi, per la risignificazione del tempo vuoto della disoccupazione, in opposizione collettiva allo stato di cose. Non a caso “nella gioia e nella rabbia” ha dato spazio alla lotta per la casa ieri e oggi a Bologna. In corteo in memoria di Lorusso non c’erano soltanto gli studenti e i compagni storici che attraversarono queste strade anche con Francesco, c’erano gli occupanti di case, i facchini in lotta, gli inquilini resistenti agli sfratti. Se l’università è il nostro quotidiano campo di battaglia, immediatamente fuori di essa e già dentro la zona, dietro il bancone della mensa, alla guida del furgone che porta la posta al 36, si possono incontrare uomini e donne che si sono organizzati collettivamente per conquistarsi una vita degna. Francesco è vivo ben oltre Via Mascarellla, nelle occupazioni, ai picchetti antisfratto nei quartieri ribelli. Tutto questo insieme, tutte queste lotte unite sono contropotere oggi, e perciò l’unico contesto in cui di memoria politica si può, con diritto, parlare.
La cacciata della polizia da Piazza Verdi, Via Zamboni in socialità, musica, coi nostri stili, i nostri modi e comportamenti. Le code per un pasto autoridotto in mensa, lo spettacolo di Madama Butterfly accessibile, le litografie di Escher conquistate a tre euro. Tutto ciò è niente ma, camminando e domandando, il sentiero da battere. Le micro vittorie ottenute in queste settimane sono soltanto una piccola premessa ad un possibile comportamento diffuso in zona universitaria ed in città, l’embrione di una pratica possibile di riappropriazione di reddito estesa. Si chiedeva un compagno mentre ci dirigevamo verso la mostra di Escher, perchè un operaio non potrebbe andare a mangiare in autoriduzione alla mensa universitaria, perchè uno studente non dovrebbe occupare con i facchini sfrattati? Ecco, è questa una prospettiva di ricomposizione possibile, all’insegna del meticciato e della solidarietà precaria? Crediamo di sì.
Alla lotta!
tratto da UnivAut
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.