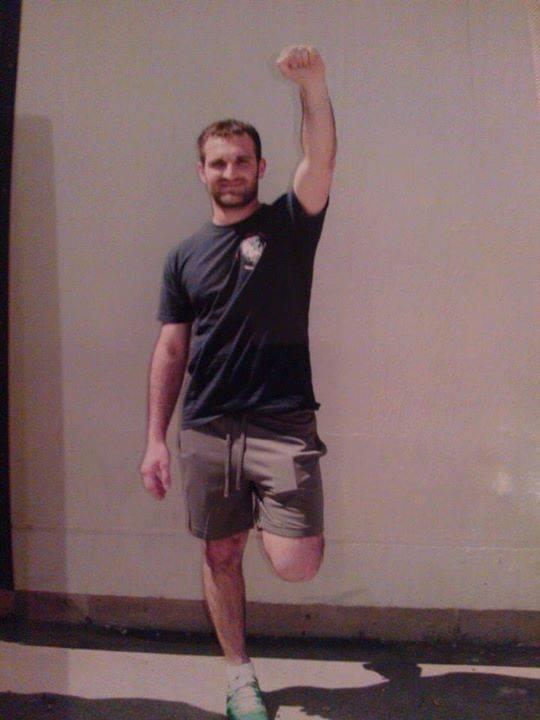L’irrappresentabilità dell’indignazione: nodi e note sul 15 ottobre e dintorni

Zuccotti Park, ora rinominato Liberty Plaza, New York, 14 ottobre: alle prime luci dell’alba migliaia di persone si radunano per difendere lo spazio che da alcune settimane è occupato da quelli che sono stati definiti indignati. Il sindaco Bloomberg è costretto a fare retromarcia. Occupy Wall Street ha vinto. Dopo poche ore, dall’altra parte del mondo, iniziano i primi cortei: Auckland, Sydney, Tokyo. Il 15 ottobre, giornata globale di mobilitazione per una trasformazione radicale, è cominciato. E poi grandi manifestazioni da Madrid e Barcellona ad Atene, da Londra a Tunisi, e in circa mille città in tutto il mondo. Questo è il primo, straordinario, dato: le lotte iniziano a riconoscersi su un piano immediatamente transnazionale. All’ordine del giorno non c’è questo o quel governo, ma il superamento del sistema capitalistico; non una particolare ricetta per alleviare i mali della crisi, ma la risoluta determinazione a eliminarne la causa. Ciò prefigura già un piano di organizzazione transnazionale? Certamente no, e gli elementi di blocco e frammentazione non vanno sottovalutati: al contrario, questo è il ricco problema che ci viene consegnato, a partire dagli sforzi di rete già avviati, importanti per quanto ancora insufficienti. E tuttavia, nonostante l’evidente eterogeneità di numeri, consistenza e sviluppo, la giornata del 15 ottobre profila – benché in modo estremamente differenziato e non privo di contraddizioni – le principali caratteristiche delle lotte nella crisi: l’esaurimento della sovranità statale; l’irrappresentabilità; la radicalità delle pratiche e dei contenuti; la dimensione immediatamente costituente; la vocazione maggioritaria. E inizia a tratteggiare embrionali elementi comuni di programma, come la centralità della questione del debito e la rivendicazione del diritto alla bancarotta per precari, studenti, lavoratori impoveriti dalla crisi. Oggi potremmo dirla così: la lotta sul salario sta al capitalismo industriale come la lotta sul debito sta al capitalismo cognitivo.
In questo quadro e solo in questo si collocano e assumono una propria fisionomia le centinaia di migliaia di persone che hanno riempito le strade di Roma. Dire questo non è tanto banale quanto può sembrare: perché di questo, prima e dopo il 15 ottobre, sembrano non rendersene conto i media, se non per rafforzare il giudizio di condanna per quanto è successo nella capitale italiana rispetto al presunto “buon senso” nel resto del mondo. E sembra non esserne pienamente consapevole neppure una buona parte delle realtà che hanno preparato e cercato di rappresentare la giornata del 15 ottobre. Sui contenuti, per cominciare. Quando tra il 2008 e il 2009 indicammo la lotta sul debito come terreno centrale e ricompositivo sul piano transnazionale, quando iniziammo a parlare di diritto all’insolvenza, in Italia c’era chi sosteneva che fosse un vezzo intellettuale e minoritario, che i milioni di proletari e precari che non pagavano il mutuo lo facevano a scopi meramente individuali e non erano organizzabili dal punto di vista collettivo. Era la difesa del pubblico il vero terreno del movimento, quello maggioritario. Ora il diritto all’insolvenza è, appunto, parola d’ordine globale delle lotte e slogan di massa della manifestazione romana.
Per certi versi, potremmo dire che la convocazione ufficiale del 15 ottobre è nata in Italia in una forma paradossalmente rovesciata rispetto alla proposta partita dalle acampadas spagnole. Da un lato, è stata molto confinata dentro le rappresentanze, esterne e interne al movimento; dall’altro, mettendo in primo piano la specificità italiana, se non addirittura il recupero della rivendicazione sovranista in opposizione alla dittatura della Bce, ha contraddetto la dimensione europea e transnazionale in cui è nata. Del resto, guardare all’ombelico della provincia, finendo per essere preda dei discorsi sulla supposta anomalia italiana, significa non cogliere l’eterogenea composizione di queste lotte che, come avremmo detto in altri tempi, stanno creando ciclo. Lo avevamo già visto il 14 dicembre, lo rivediamo – in forme e in una cornice parzialmente diversi – a meno di un anno di distanza. In molti sono stati vittime dell’erronea equazione tra vocazione maggioritaria e moderatismo nei contenuti e nelle pratiche. Da ciò è scaturita, nella piazza romana, l’assenza di obiettivi chiari, non velleitari o di nicchia, ma in grado di raccogliere le indicazioni politiche (peraltro girate molto in rete e nei social network da parte dei singoli partecipanti alla manifestazione e poi lungo il corteo) emerse da quelle lotte transnazionali da cui il 15 ottobre nasce, innanzitutto la contestazione dei cosiddetti “palazzi del potere” (da Wall Street al parlamento europeo) e la riappropriazione moltitudinaria dei luoghi centrali della metropoli, da piazza Tahrir e la casbah fino a Puerta del Sol e Zuccotti Park / Liberty Plaza. La mancanza di indicazioni politiche nella piazza italiana si è accompagnata – nelle settimane e nei giorni precedenti – a una sorta di feticizzazione della pratica dell’accampamento, privata di quella dimensione moltitudinaria che l’ha resa potente e riportata nei recinti della rappresentanza di movimento. Come se le forme di lotta non fossero produzione collettive storicamente determinate dalle composizioni sociali del conflitto, ma al contrario delle idee di attivisti creativi.
Allora, si possono valutare come meglio si crede le caotiche e talora strambe azioni contro banche, caserme e proprietà privata – azioni non troppo diverse da quelle che in contesti sufficientemente lontani, come nelle lotte inglesi contro l’aumento delle tasse e i tagli al welfare, hanno ricevuto plausi e celebrazioni; soprattutto se ne può mettere utilmente in discussione l’efficacia politica, o il rischio di una consumata ritualità simbolica – non differente, peraltro, dal pericoloso inflazionamento delle azioni simboliche, anche quelle molto pacifiche, o del loro ruolo di esonero e rappresentanza dei processi collettivi. Di certo, comunque, non si può sostenere la tesi dei gruppetti organizzati per quello che si è visto a piazza San Giovanni, dove lo scenario è notevolmente mutato rispetto alla prima parte del corteo (tralasciamo qui, per rispetto dell’intelligenza di chi legge, di prenderci cura dell’ormai noioso e grottesco spettro mediatico dei “black bloc” che tutto avvolge e confonde). Con buona pace del volgare e malriuscito gossip poliziesco di Carlo Bonini, neanche i trecento di Leonida avrebbero evidentemente saputo resistere e contrattaccare per almeno tre ore ai criminali caroselli della polizia con blindati e idranti. Del resto, facendosi pasdaran della legislazione emergenziale del tandem Maroni-Di Pietro e centri di propagazione dell’invito alla delazione diffuso in rete (inquietante rovesciamento della potenza comunicativa moltitudinaria in rancorosa circolazione delle passioni tristi), Partito di Repubblica e centro-sinistra si preparano a governare l’austerity e i sacrifici in modo finalmente credibile di fronte alla comunità internazionale. Ma la realtà è che il fronteggiamento è stato agito da migliaia di persone, oltre a quelle che pur non partecipando direttamente non hanno abbandonato la piazza. La composizione va al di là dei gruppi militanti e rispecchia quello che si era già visto il 14 dicembre, così come in altre piazze europee: molti giovani e giovanissimi (lo confermano l’età degli arrestati), perlopiù studenti e precari, molti provenienti dalle periferie, per cui l’assenza di futuro non è una frase ad effetto per i volantini ma una realtà da cui traggono delle conseguenze. Scambiare dei segnali di tendenza forti per dei gruppetti è, prima ancora che sintomo di malafede, un grande errore politico.
Questo strato specifico, non maggioritario ma che indubbiamente si allarga con una temporalità accelerata dalla crisi, è lo specchio di una dimensione massificata. Gad Lerner – e non poteva essere altrimenti – scrive che i riot in Inghilterra di agosto nulla hanno a che fare con il movimento degli “indignati”. Così facendo, dimostra di ragionare con quell’arsenale ideologico novecentesco che vorrebbe attribuire a quelli che lui definisce i “guastatori” del 15 ottobre. Le lotte nella crisi, a livello transnazionale, sono al contrario determinate dal convergere e differenziarsi di un ceto medio declassato e un proletariato senza prospettive di riscatto sociale, da centri che diventano periferici e periferie che vogliono appropriarsi del centro, fosse anche solo per un giorno. Sono accomunati dal blocco della mobilità sociale, dall’asciugarsi del welfare famigliare e dalla precarietà permanente (non solo più di prima, ma di seconda generazione); più complessivamente, dalla storica fine della promessa progressiva del capitalismo, ovvero dall’esaurimento di ogni opzione riformista. In questo quadro saltano le mediazioni e le sue strutture: questo è il nocciolo del processo di radicalizzazione, che assume forme estremamente differenti e spesso in aperto contrasto. Esistono, cioè, non solo sovrapposizioni e identificazione, ma anche evidenti punti di frizione o talora frattura nella produzione di soggettività e nell’espressione del conflitto tra ceto medio declassato e “indignato” e giovani “no future” (se ne sono avuti esempi anche nella piazza romana, per quanto minori di quelli strumentalmente enfatizzati dai media, e accompagnati da vari episodi di diretto o indiretto sostegno, di cui si possono trovare ampie tracce sugli stessi giornali e telegiornali). E qui non esistono scorciatoie politiciste, ossia la possibilità di rappresentare un pezzo nei parlamenti (veri o auto-eletti) oppure l’altro nelle piazze: perché a questo livello – che è generale e non solo italiano – gli elementi di potenziale scissione riguardano la composizione di classe e non solo i rapporti tra strutture.
Già, perché non si tratta di esaltare la spontaneità, né di estetizzare la rivolta. Il punto è che spontaneità e rivolta – quando avvengono su livelli tendenzialmente massificati – sono un dato di fatto indipendente dal giudizio di valore che se ne può avere. É solo a partire da qui che si possono affrontare le grosse questioni di organizzazione che questo quadro pone – se per organizzazione intendiamo un processo collettivo immanente alla composizione sociale, e non la trascendenza del potere sovrano o la salvaguardia degli interessi di bottega. Ciò che anche il 15 ottobre romano ha significato, al pari di quello che è avvenuto nelle acampadas e nel resto del mondo, è la spaccatura tra questa composizione sociale da un lato, presa nel suo complesso e nella sua eterogeneità, e non solo la rappresentanza politica, ma anche la rappresentanza interna al movimento dall’altro. Il che probabilmente deve portarci a riflettere su una critica dell’idea stessa di movimento laddove questa si presume coincidente con i gruppi che, appunto, dovrebbero rappresentarlo. L’irrappresentabilità della composizione sociale e della sua indignazione, ça va sans dire, non apre linearmente la strada alle magnifiche e progressive sorti delle nuove forme di organizzazione: indica piuttosto il nodo, cioè la coniugazione tra la vocazione maggioritaria delle lotte e le differenti forme della radicalità. Diciamo forme perché la vocazione maggioritaria è basata sul comune, sul suo desiderio moltitudinario che le lotte esprimono. É proprio la radicalizzazione – al di là delle sue differenti forme di espressione – a divenire maggioritaria. Come le lotte costruiscono nuove istituzioni, questo è il problema: senza questo, private cioè del comune, si scivola nel minoritarismo (politico, non numerico) che può assumere alternativamente e con medesimo risultato le forme dell’azione velleitaria o dell’opinione pubblica, della nicchia comunitaria o della rappresentanza parlamentare, dell’identità marginale o della rivendicazione meritocratica. Laddove, invece, la vocazione maggioritaria delle lotte è data proprio dalla composizione comune delle eterogenee forme di radicalità. Negli ultimi tre anni, nei movimenti, abbiamo visto all’opera le zone di frontiera e divisione tra i diversi strati di questa composizione sociale, ma anche i punti di reversibilità. Lo abbiamo visto, ad esempio, nell’Onda o in Val di Susa, quando i discorsi sulla meritocrazia o un sentimento genericamente definito “anti-politico” si sono rovesciati nella radicalità della lotta contro la precarietà e il debito, respirando l’aria di libertà del comune. Proprio il movimento NoTav è stato negli ultimi mesi un buon esempio di come le differenti espressioni della radicalità e figure del conflitto possano trovare un terreno di composizione comune, che non appartiene alla spontaneità del corso storico ma all’invenzione di nuove forme di organizzazione. Non solo dell’evento, ma innanzitutto dei processi.
Quindi, oltre che essere per ovvie ragioni deprecabile, la divisione tra un immaginario 99% di buoni e un 1% di cattivi, cioè la scelta di uno strato contro l’altro di questa composizione sociale che è al 100% precarizzata e impoverita, non fa altro che alimentare quella spirale di frammentazione che è ciò che le lotte hanno, almeno in parte o a tratti, invertito. Il problema di un processo organizzativo all’altezza della radicalità del presente è, allora, la costruzione di composizione comune. Da questo punto di vista i frammenti di indignazione e di rabbia, se analizzati al contempo insieme e nel loro contrasto, possono aprire la strada alla nostra ricerca collettiva.
Ps: mentre scriviamo molte ragazze e ragazzi sono ancora in galera. Chiederne l’immediata scarcerazione, senza se e senza ma, è il dovere comune di tutte e tutti. Pensiamo che nessuno possa avere dubbi su questo.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.