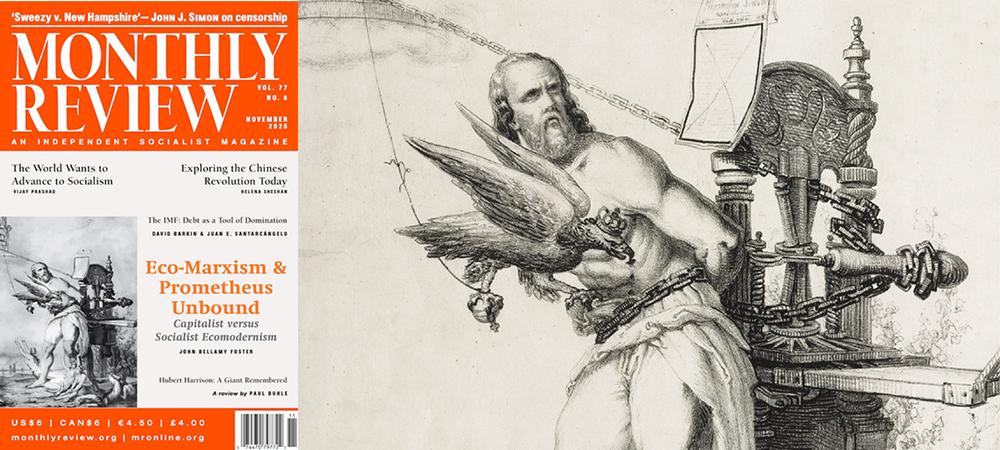Elogio della militanza

Non una figura qualunque, pacificata, della partecipazione politica liberale, ma una figura specifica e storicamente determinata della lotta politica. Il titolo è già di per sé una forma di rottura rivendicata, una rottura necessaria, che avviene non contro la normalizzazione liberal-democratica (troppo facile), ma dentro il campo della sinistra antagonista, che da tempo ha accettato supinamente la traslitterazione semantica (di provenienza anglosassone) dell’attivista. “Quando al giro di boa del millennio si è iniziato a chiamarlo attivista, non si è trattato di una semplice concessione linguistica, ma di un cedimento strutturale. Si è così persa la sua incommensurabilità rispetto ad altre figure, come quella del volontario. Figura dell’interesse generale, dunque della riproduzione dell’esistente”.
Attivismo e militanza non sono concetti sinonimi o ambivalenti: presuppongono opposte visioni della politica e sedimentano antitetiche coscienze dell’esistente e degli strumenti per combatterlo. In altre parole, il militante è figura politica, di parte, che attraverso il sacrificio e la disciplina dichiara guerra all’individuo liberale in favore del divenire rivoluzionario dell’individuo sociale; l’attivista è al contrario l’innocua figura volontaria che tenta di ricomporre ciò che invece andrebbe disarticolato socialmente per essere ricomposto politicamente contro e non al posto di. Sacrificio e disciplina: quale distanza tra questi due concetti e le forme attuali della partecipazione politica? Una distanza talmente profonda che anche laddove presenti – e sono continuamente presenti nella militanza quotidiana – vengono taciute, negate, quasi che imporsi un sacrificio o costringersi in una disciplina collettiva rimandi a forme e metodi di una lotta politica da cui finalmente si sono prese le distanze. Il militante, ci dice Roggero, è la figura fondamentale della politica rivoluzionaria. Traduce la linea politica verso il basso e la corregge verso l’alto. E’ la cerniera tra la teoria e la pratica, quel “medio raggio” che rappresenta il cuore dell’agire politico. E’ la figura che combina incessantemente la “massima rigidità strategica” con la “massima flessibilità tattica”, è in altre parole la personificazione della dialettica leniniana, colui che sta dentro le contraddizioni agendo da detonatore, sempre in bilico tra dogmatismo e opportunismo, senza mai scivolare nell’uno o nell’altro dei poli della rigidità politica della teoria senza traduzione pratica e della prassi senza strategia politica.
Se il militante è la figura a cui parla l’ultimo libro di Roggero, il tema affrontato nel saggio recentemente pubblicato è specificato nel sottotitolo: note su soggettività e composizione di classe. Temi in qualche modo ricorrenti in questo ultimo decennio, una lunga fase di “transizione declinante” che ha spinto le avanguardie più coscienti, o semplicemente più curiose, a cercare una risposta alla crisi politica della sinistra radicale partendo dall’individuazione dei soggetti da organizzare e dalle nuove forme organizzative che da questi scaturiscono[1]. Nel predisporre un discorso per definizione in fieri, quindi necessariamente non concluso e in corso di aggiustamento, l’autore indica una linea politica ben precisa: tornare all’operaismo per rompere con il post-operaismo, cioè con una “tradizione” politica che dagli anni Ottanta ha egemonizzato il piano culturale e dell’azione politica dei movimenti antagonisti in Italia.
Non ha posizioni precostituite da difendere Roggero, e questo permette un discorso sincero, efficace, sebbene storicamente e filosoficamente determinato. “Diciamolo così, in modo netto: il cosiddetto post-operaismo è finito[…]Ora il compito è ritornare all’operaismo, non certo contro ma sicuramente in modo critico rispetto a ciò che del post-operaismo non funziona più, oppure non ha mai funzionato”. Una rottura non semplice per chi in qualche modo ha condiviso molto di quel pensiero nella propria formazione politica, e che parte da premesse filosofiche precise che vanno lette e interpretate con attenzione. Riprendendo la lezione operaista, soprattutto trontiana, Roggero pone al centro dell’analisi del e sul capitale il conflitto tra questo e il lavoro di fabbrica. Non è il capitale che costituisce la classe operaia ma il contrario: è il proletariato che attraverso i suoi percorsi di resistenza costringe il capitale ad innovarsi prendendo la forma attuale e in continua evoluzione. La classe operaia in altri termini è il motore dello sviluppo, e le lotte operaie lo strumento attraverso cui il capitale innova se stesso: “il pensiero nasce sempre dalla contrapposizione[…]Sono le lotte a determinare lo sviluppo, prima viene la classe poi il capitale. Interpretare il capitale a partire da se stesso è una proiezione ideologica”. Seguendo tale impostazione, l’autore arriva a concludere che la classe “non è una questione di stratificazione, ma di contrapposizione[…]La classe, per Marx e per noi, è un concetto interamente politico. Classe significa antagonismo di classe. Con Tronti: non c’è classe senza lotta di classe”.
Potremmo continuare riprendendo altri frammenti del discorso, ma il senso dovrebbe essere a questo punto svelato: recuperando radicalmente l’impostazione operaista, l’autore ci dice che lo sviluppo umano, la natura stessa dell’uomo, è una natura contrappositiva, conflittuale, ontologicamente divisa e divisiva. Le diverse fasi dello sviluppo corrispondono alle diverse forme di resistenza che i soggetti subalterni hanno messo in pratica contro i soggetti economicamente e politicamente egemoni; infine, che l’innovazione organizzativa capitalistica deriva dalla rigidità operaia. Bisogna essere coscienti che tale impostazione è di natura filosofica e non contingente, e che ha poco a che fare con il pensiero di Marx. Secondo Marx infatti l’origine dello sviluppo umano, dell’uomo in quanto animale sociale, è la cooperazione, data in forma alienata per ragioni storiche verificabili (e che Marx per l’appunto verifica nelle sue opere e soprattutto nel Capitale), e che costituisce il presupposto e il fine delle lotte di classe: quello della riappropriazione del momento cooperativo in forma non mediata dal profitto privato. Il problema non è però solamente filosofico.
Economicamente, Roggero legge le continue evoluzioni del capitale come risposta alla rigidità operaia che di volta in volta organizza le sue forme di resistenza. E’ una visione quantomeno parziale dello sviluppo capitalistico. Il capitalismo infatti opera costantemente forme proprie di rigenerazione – è un processo sociale in continua evoluzione – soprattutto per sue caratteristiche interne. Il capitalismo è in realtà un campo di scontro tra capitali concorrenti, capitali che trovano una propria unità solamente nei momenti di conflitto con i soggetti subalterni, ma che fuori o parallelamente da questi sono naturalmente predisposti alla competizione interna, che è una competizione violenta per estromettere dai processi di valorizzazione capitali concorrenti. Sono le continue innovazioni tecnologiche dei capitali in competizione che impongono al capitalismo nel suo insieme una costante evoluzione, non certamente o esclusivamente progressiva, ma perennemente cangiante. Inoltre, le continue innovazioni tecnologiche che stanno alla base della costante ridefinizione produttiva del capitalismo, costituiscono la risposta non coordinata alla legge della caduta tendenziale del saggio di profitto. E’ tale caduta tendenziale, prodotto dal costante aumento della produttività del lavoro (attraverso l’aumento della composizione organica del capitale) sganciata dalla valorizzazione del capitale (valorizzazione declinante proprio dall’aumento progressivo del capitale costante in rapporto a quello variabile), che provoca le crisi cicliche che costringono i capitali concorrenti alla guerra e ai reciproci tentativi di eliminazione. In tale dinamica si situa poi la conflittualità operaia, che è sicuramente un elemento capace di modificare i piani del capitale, ma di certo non l’unico, e probabilmente neanche il più rilevante. E’ un elemento presente nel conflitto storicamente determinato tra soggetti produttivi e rapporti di produzione, ma che da solo non spiega la natura evolutiva del capitalismo.
L’operaismo rimane in un certo senso vittima di una sua prospettiva radicalmente sociologica: pone al centro di tutto la soggettività operaia perdendo di vista il quadro oggettivo dei rapporti di produzione. Dileguando ogni riferimento oggettivo, la rottura filosofica compiuta da Negri è tutto sommato conseguente. A quel punto il soggettivismo ha scalzato l’oggettivismo marxista producendo di converso una teoria politica nei fatti interclassista, che infatti è giustamente posta a critica nel proseguo del volume, che disvela le tare post-operaiste come solo un sapiente intellettuale militante di quel mondo potrebbe fare.
Tutto risolto dunque? Per niente. L’operaismo ha avuto un ruolo politico decisivo nelle lotte di classe del nostro paese: quello di dare sostanza teorica e prospettiva politica ad un pezzo di classe in rotta con la rappresentanza ufficiale del Pci. L’operaismo rompe il vicolo cieco in cui la rappresentanza operaia si era rinchiusa: da una parte la concertazione del conflitto economico attraverso i sindacati; dall’altra la rappresentanza politica nelle istituzioni preposte attraverso il partito in fase di transizione. Stretta tra queste due maglie politicamente annichilenti, scompariva in Italia ogni ipotesi di cambiamento radicale dell’esistente che non passasse attraverso l’onda lunga della prospettiva radicalmente socialdemocratica del Pci. Ecco perché non basta liquidare un patrimonio di idee e di inchiesta operaia che, seppur da impostazioni filosofiche discutibili, ha avuto un ruolo politico comunque importante. Rompere con il post-operaismo potrà produrre un fecondo passo in avanti nelle strategie della sinistra antagonista solo se non si ricadrà nel radicale soggettivismo in cui era finita l’esperienza operaista. Alla soggettività sociologica per cui la classe non è un mero dato oggettivo-economico ma soprattutto un dato politico e conflittuale, deve sommarsi lo studio dei modelli produttivi entro cui si situa la conflittualità operaia (dove per operaia, ovviamente, non si deve intendere quella dell’operaio della grande fabbrica fordista, ma dei nuovi soggetti sociali disponibili alla lotta e centrali nel processo di accumulazione capitalista nei paesi a capitalismo maturo).
Il cuore del saggio non si situa però nelle sue premesse filosofiche, sebbene dall’autore poste a premessa del discorso, ma da una possibile, o potenziale, traduzione militante all’altezza dei tempi. E’ qui che il ragionamento raggiunge il suo culmine e si fa a nostro giudizio più convincente. La critica a certe degenerazioni movimentiste è spietata. Vengono presi di mira tutti i cliché ideologici di un certo pensiero mainstream che ha trovato ricezione anche all’interno dei movimenti antagonisti: l’economia sociale e la cooperazione agitate contro l’economia pubblica che, lungi dal “rappresentare un terzo settore rispetto a Stato e mercato, è una delle forme che la privatizzazione del pubblico ha assunto”; “l’autoimprenditorialità diffusa” dei centri sociali, “che produsse modesti risultati dal punto di vista economico ma contribuì a produrre una soggettività politica cresciuta con una prospettiva da amministratore più che da militante”; l’(auto)identificazione tra militante e precario, risultato di una “frettolosa autoinchiesta vittima di una autoreferenzialità strategica”, che ha prodotto l’indebita identificazione tra “militante” (ormai attivista) e “classe”; una certa centralità acritica delle lotte sui bisogni primari, come quelle sulla casa, che in alcuni casi “feticizza il bisogno, non riuscendo ad andare oltre la sua soddisfazione, creando isole urbane di autogestione della marginalità e della miseria”; una presunta e pretesa autogestione dei “saperi” del cd “cognitariato”, al contrario costantemente “modularizzato, amministrativizzato, managerializzato, budgetarizzato, banalizzato, precarizzato, utentizzato”, in altre parole catturato a valle e messo a profitto per il capitale, completamente sottratto al controllo dei produttori; e via continuando. All’indebolimento del pensiero – potremmo aggiungere noi: all’infatuazione per il pensiero debole e particolare, ideologicamente avverso ad ogni piano generale – non è seguito un potenziamento della prassi. “La moltitudine è tutto, la composizione di classe nulla. La scuola è rimasta senza movimento, i codici accademici hanno inghiottito il conflitto di classe”.
La forza attuale del “populismo”, termine certamente incapace di descrivere e distinguere i diversi fenomeni politici sparsi per l’Europa, sta però nel “dare dei volti al nemico”, laddove un certo pensiero egemone dei movimenti ha completamente destrutturato e molecolarizzato i processi capitalistici senza più né volto né sede fisica, di fatto scomparsi dalla lotta politica contingente: “a un certo punto è stato spiegato che il potere non è concentrato esclusivamente in un punto, ossia nello Stato, ma è diffuso nelle relazioni sociali. Bene. Partendo dal presupposto che è dappertutto, si è arrivati alla conclusione che non ci sia più, o che non si concentri secondo una gerarchia. Male. Liquidare il problema è diventato all’interno dei movimenti un mantra: il Palazzo d’Inverno è scomparso, bisogna cambiare il mondo senza prendere il potere”. La moda anglosassone della cd “micropolitica” ha prodotto la metastasi della microcomunità autosufficiente, “che non mette in gioco i termini reali del potere, ma si accontenta di vivere praticando al proprio interno relazioni conviviali”.
La sfida, secondo l’autore, sta nella capacità della nuova generazione di militanti politici nel saper interpretare dialetticamente l’agire politico. Non è riscoprendo nuovi dogmatismi o rigidità strategiche slegate da prassi efficaci, che si ricostruiranno le basi di una nuova politica capace di incidere davvero nei rapporti di forza tra le classi. “Non si confronta con la contraddittorietà e la sporcizia del reale solo chi si sente debole”: il militante, forte della propria inflessibilità strategica e al contempo dalla sua estrema flessibilità tattica, è efficace solo se situato dentro le contraddizioni del reale, piegandole agli interessi della propria parte, immaginando alleanze spurie, sintesi sociali eterodosse, strade alternative a quelle libresche. Tutto al fine di tornare ad incidere davvero nella società e nei suoi rapporti di potere, in altre parole riappropriandosi di un orizzonte maggioritario, distante da settarismi, minoritarismi inconcludenti, dogmatismi o, al contrario, esaltazioni spontaneistiche e sottoculturali. Davvero rara, di questi tempi, tale generosità d’animo nel saper porre a critica il comodo esistente nel quale ci autoproduciamo, e nel voler coraggiosamente indicare una strada da perseguire che preveda la rottura con certe comodità intellettuali. Se non tutto è condivisibile, il metodo proposto è quello da seguire: aprire un dibattito e vedere cosa ne esce fuori, tornando a fare inchiesta.
[1] A titolo di esempio: Paolo Cassetta, Emilio Quadrelli, Noi saremo tutto – nuova composizione di classe, conflitto e organizzazione, Gwynplaine edizioni, Camerano (An) 2012; Clash City Workers, Dove sono i nostri – lavoro, classe e movimenti nell’Italia della crisi, La Casa Usher, Firenze 2014.
di Alessandro Barile
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.
capitalismoelogio della militanzagigi roggeromilitanzamodernitàpostmodernoproduzione