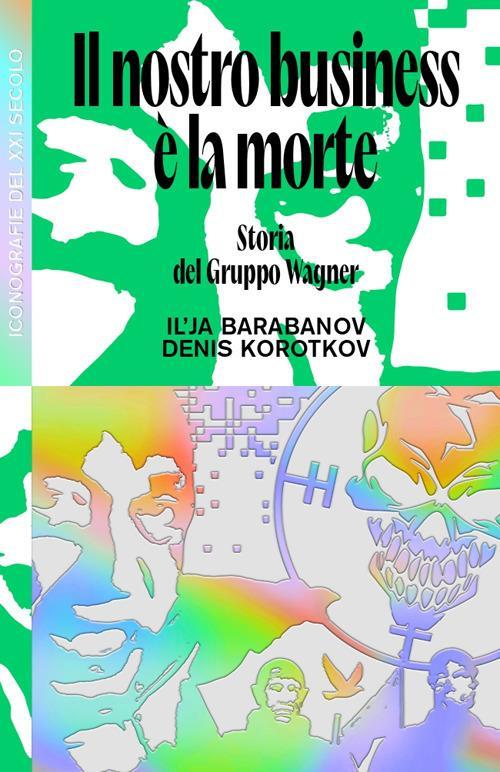«La libertà non si paga, si strappa». Lettera dal carcere di Andrea Olivieri

Nei primi giorni di questa situazione ero piuttosto incredulo per quello che mi stava accadendo. Sai bene che negli anni non è che non l’avessi e non l’avessimo messo in conto, ma puoi anche immaginare cosa posso aver pensato. “Sono vittima di una vendetta fuori tempo massimo”, mi dicevo, “possibile che non si rendano conto dell’idiozia di rinchiudermi qui ora?”. Beh, riguardo a questa domanda purtroppo la risposta è banale ed è sempre la stessa: all’idiozia di giudici e guardie non c’è limite, e se negli ultimi anni la mia rabbia può essersi spersonalizzata, tentando di andare alle radici delle cause che ci costringono a vivere in un mondo tale, oggi avrei di nuovo voglia di gridare slogan che i palati fini di certa sinistra considerano turpi e fuori moda. È vero che anch’io da qua dentro rischio di farla tetra, e di prendermi sul serio in maniera esagerata. Del resto di sentirmi vittima sono il primo a non volerlo, e che non ci fosse un tempo massimo ho sempre tentato di spiegarlo a chi mi diceva che era troppo impegnato con le cose della vita di ogni giorno – lo studio, la carriera, la famiglia – per impegnarsi nella “militanza”. Sai che sono concetti che ho sempre digerito male. “Militanza” appartiene a un vocabolario marziale che sento distante, le cose della vita non sono mai riuscito a percepirle distinte da “quello che devo fare”, la frase che Gert dal Pozzo continua a ripetere a sé stesso per spiegarsi il suo inestinguibile debito con la comunità umana.
Resta la vendetta.
E che la cella in cui mi trovo sia il simbolo di un ossessione vendicativa quotidiana contro milioni di dannati e dannate non l’ho mai avuto così chiaro come ora. Il canto di un muezzin risuona nel cortile che percorro di corsa ogni mattina, settanta giri sono quattro chilometri, ti scrivo all’alba mentre un pallido sole d’inverno illumina i muri scrostati e le sbarre con la vernice usurata da troppe mani impotenti. Una guardia entra, mi dice di aprire la finestra ed esegue il rito della battitura. Così sveglia i miei compagni di cella, un signore peruano diabetico e con l’asma, due ragazzi domenicani con un eterno ed eroico sorriso sulla bocca, un ragazzino ecuadoriano che da quando aveva sedici anni ha conosciuto solo galera. In questi sedici metri quadri, con me, c’è sempre anche Matteo: mi sorride e mi prende in giro con i suoi tic e le sue smorfie quando piglia male, quando sto precipitando. Arriva con la sua grammatica spagnola quando devo districarmi in qualche discussione con i miei coinquilini. Con il ragazzo serbo della cella di fronte ci divertiamo a scambiare insulti e bestemmie nella sua lingua. Ventidue ore al giorno di cella, per quindici di queste la televisione è permanentemente accesa. Vorrei gridare che così finiamo a vivere come bestie, spegniamo almeno quella merda! Ma poi cosa resterebbe? Certo, a me i libri di cui sono già pieno e che non riesco a leggere in questo casino di lingue, suoni e rumori. Ma poi mi accorgo che il rincoglionimento catodico è un’altra via di fuga, piccola e stupida, ma a volte efficace. Eccomi qua, per l’ossessione di un procuratore qualunque, di un digossino qualsiasi, per la vendetta di un ometto insignificante; eccomi tra i “dannati della terra” ad aspettare che passi, e a ripensare se c’era qualcos’altro da fare. No che non c’era. Per quanto possiamo illuderci che ci sia sempre un altrove, un’altra strada, quello che dobbiamo fare va fatto.
Il muro di fianco alla mia branda era ricoperto da cristi e madonne. Ora ho messo una foto scattata da mia nonno materno, che ritrae il padre di mio padre, grazie ad una prospettiva geniale: finge di tenere una casa in equilibrio su un dito, alla maniera dei giocatori di basket. Una casa in equilibrio sulla punta di un dito, il profilo longilineo di mio nonno che sorride divertito. Andò in galera quattro volte, sotto tre stati diversi. La prima nel ’43 nell’Italia fascista. La seconda nel ’45 e la terza nel ’46, quando Trieste era amministrata dagli anglo-americani e lui, comunista e ribelle italiano, si batteva perchè voleva Tito. La quarta volta infine per un mese nel carcere di Fiume e poi deportato in Bosnia, assieme a mia nonna e mio papà che aveva due anni. Era il 1948, erano emigrati in Jugoslavia per costruire un mondo nuovo, ma la rottura tra Stalin e Tito li lasciò in mezzo a un guado della Storia. Anche allora non c’era nient’altro da fare. Nient’altro che tentare, riprovare e sbagliare, e a volte vincere anche quando altri parlano di sconfitta. Alle volte non resta altro che stare in silenzio, ingoiare merda e aspettare un’altra occasione.
Ora io aspetto, ingoio, *ma non mi va di restare in silenzio.*
Non sono qui per sbaglio, non è stata la nostra atavica cialtroneria per le vicende giudiziarie a causare questa situazione. L’avvocatessa che mi assiste qui dice che nessun tribunale in Lombardia ha mai infierito in questo modo per reati simili. Ha visto la mia storia giudiziaria triestina che, a prima vista, mi dipinge come un aggressore seriale di poliziotti e dimostra quanto queste creature siano fragili e indifese di fronte alla furia assassina di contestatori e ribelli. Sappiamo come sono andate le cose: la prima condanna che ricevetti a Trieste sosteneva che avevo picchiato selvaggiamente due carabinieri, nello stesso istante ma a decine di metri di distanza.Ho sempre sospettato di essere Clark Kent!
Voglio ricominciare a scherzare, a piano a piano voglio raccontare un’altra verità, e altre storie. Raccontare di mio nonno e di quelli come lui, che la storia ufficiale dipinge nel peggiore dei casi come spietati infoibatori, nel migliore come illusi cretini orfani dell’ennesima rivoluzione mancata. La sera mi addormento in una vertigine pensando a tutto questo.
Sono finito nell’ossessione stupida e fottuta di omuncoli vendicativi e senza dignità, sono in questa cella per appagare il loro bisogno di sentirsi cazzuti e potenti, di credere che ora, solo grazie a questo, me la fanno pagare. Penso alla Casa delle Culture, a tutti quelli che abbiamo incrociato e con cui abbiamo lottato negli anni, alle mille cose intraprese, alle piccole vittorie e alle grandi sconfitte, alle migliaia di chilometri percorsi, a quanto e come siamo cresciuti, a chi ci ha lasciato per sempre ma lasciandoci sempre qualcosa. A Franz, a Bianca, a Ciuki, a Morgan, a Bobo, a Matteo. Quegli ometti non hanno mai capito un cazzo, non possono e non avrebbero mai potuto. Non sarebbe nemmeno servito tentare di spiegarglielo che la libertà non è merce di scambio, che ne è sempre valsa la pena, che la nostra libertà non si paga, si strappa.
Vi abbraccio tutti e tutte. Siamo, siete, troppi. E vi voglio bene.
A presto, Andrea
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.