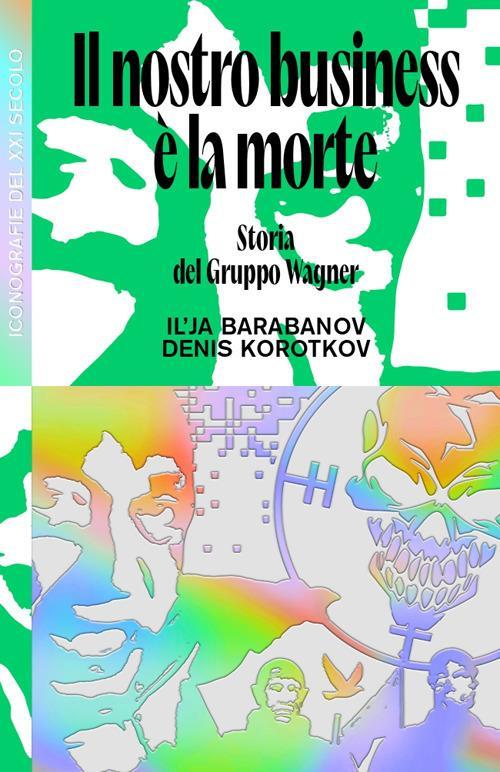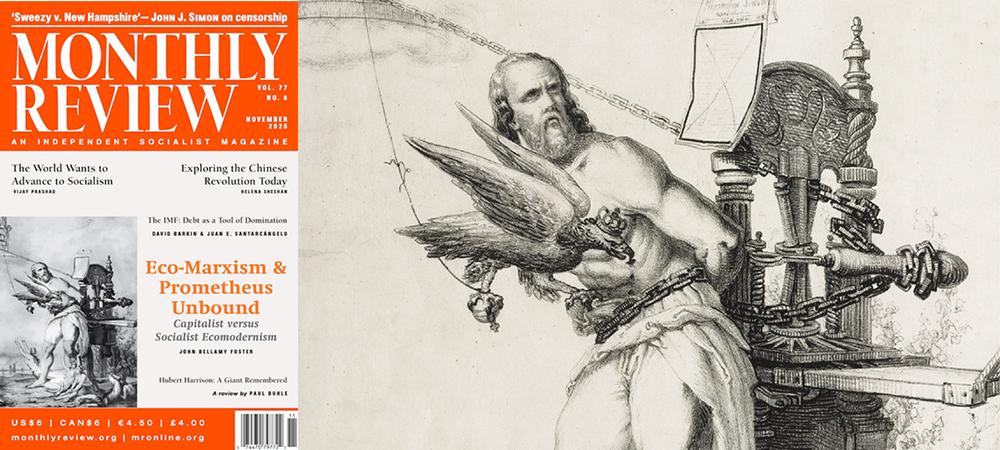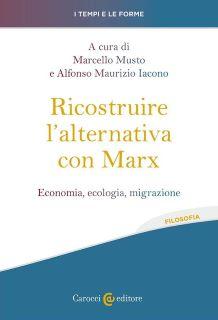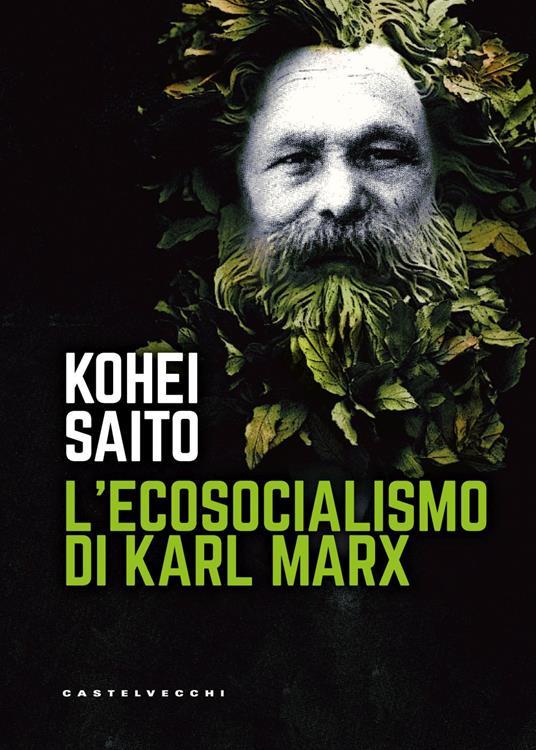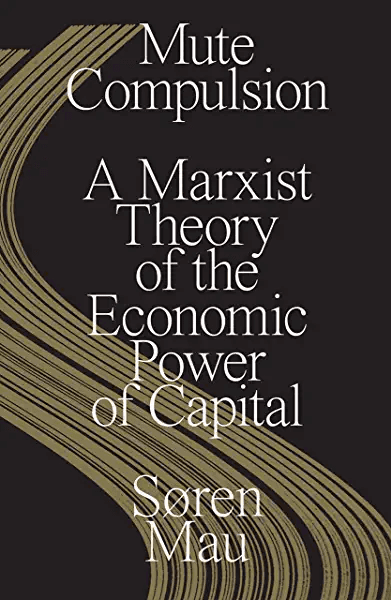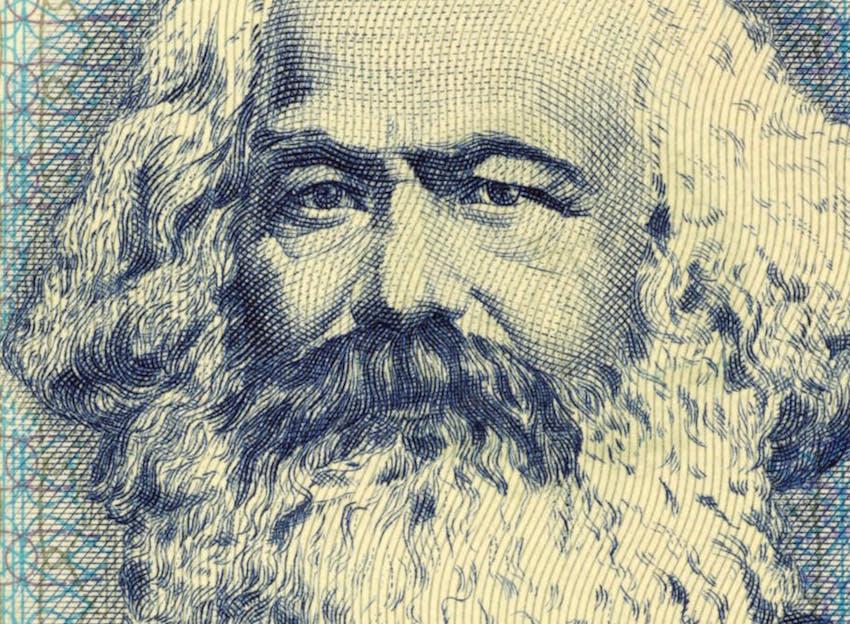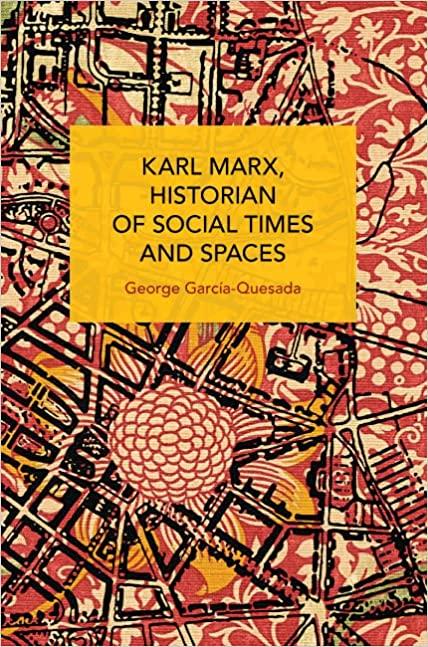
Marx e la narrazione storica tra necessità e contingenza
George Garcia-Quesada, Karl Marx, Historian of Social Times and Spaces, Haymarket Books, Chicago 2022
di Fabio Ciabatti da Carmilla
Brancaccio, Giammetti e Lucarelli nel loro recente testo La guerra capitalista “si sforzano di indicare nel movimento costante del Capitale verso la sua centralizzazione il motore di ogni guerra imperialista”. Così sintetizza Sandro Moiso su Carmilla nella sua recensione (qui) che si chiude con alcune domande suscitate dalla lettura del libro: “quanto l’imperialismo occidentale e statunitense riuscirà ancora a centralizzare a proprio vantaggio il capitale mondiale? E, soprattutto, avrà davvero ancora la forza militare per farlo, come ai tempi delle cannoniere e delle operazioni di polizia internazionale?” Per rispondere a questioni di tale portata l’analisi econometrica portata avanti dai tre autori è senza dubbio necessaria. Ma si può anche affermare che sia sufficiente? L’economista Roberto Romano, in un’altra recensione, dà una risposta negativa. Pur apprezzando l’analisi dei tre autori citati sulla centralizzazione, Romano sostiene la superiorità della concreta analisi storica quando si devono spiegare dinamiche complesse che non sono riconducibili ad una mera analisi economico-quantitativa, ma devono tenere conto di livelli differenti come la politica, la politica economica, la geopolitica e la geografia economica (qui). Menziono questa discussione senza voler entrare nel merito, ma solo per richiamare l’attenzione sul fatto che alcuni nodi teorici, da sempre al centro della riflessione storica di ispirazione marxiana (e non solo), non rappresentano meri arzigogoli intellettuali. Essi, infatti, riemergono con forza quando si cerca di comprendere questioni di estrema attualità e drammaticità come quelle legate alla guerra in corso. In estrema sintesi, che rapporto c’è tra la necessità strutturale e la contingenza storica, tra le strutture sociali e l’agency, tra la macrostoria e la microstoria?
Questi nodi teorici sono affrontati in modo originale da George Garcia-Quesada nel suo libro Karl Marx, Historian of Social Times and Spaces. Poiché abbiamo iniziato con la guerra dei nostri giorni, rimaniamo sul tema bellico riferendo quanto dice l’autore a proposito dell’analisi marxiana della guerra civile americana combattuta tra il 1861 e il 1865. In questo contesto il rivoluzionario tedesco non si limita a chiamare in causa le leggi di sviluppo del modo di produzione capitalistico che si esplicherebbero attraverso un processo di modernizzazione capitalistica, portata avanti dal Nord, a detrimento dell’arretrata produzione schiavistica degli stati sudisti. Anche perché quest’ultima, secondo Marx, ha natura pienamente capitalistica. Piuttosto vengono messe in evidenza due differenti configurazioni spazio-temporali dello sviluppo capitalistico, interdipendenti ma in competizione. Negli Stati Confederati, infatti, la coltivazione per l’esportazione di cotone, tabacco, zucchero ecc. per essere remunerativa necessitava dell’utilizzo e della riproduzione su larga scala del lavoro schiavile, e di una continua espansione delle terre fertili coltivate. Data la contiguità spaziale delle due aree, il conflitto tra il Nord e il Sud era solo questione di tempo.
Dunque la spiegazione storica chiama in causa come elementi determinanti la topografia e la decrescente fertilità del suolo oltre che condizioni di natura strettamente politica e militare per definire lo scontro tra due differenti formazioni sociali. La dimensione spazio-temporale chiamata in causa si configura con riferimento alla forma-stato, ma la spiegazione ha come ultimo referente il mercato mondiale, data l’impossibilità per l’industria britannica, potenza egemone a livello globale, di sostituire nel breve periodo la produzione del cotone, bloccata dalle vicende belliche, proveniente dagli stati confederati. In sintesi la spiegazione della guerra civile si basa su una combinazione di formazioni sociali che, sebbene generalmente orientate all’accumulazione del modo di produzione capitalistico, non possono essere ridotte ad un unico meccanismo esplicativo.
Nelle righe precedenti abbiamo fatto riferimento a due differenti concetti, modo di produzione e formazione sociale, che ora andranno chiariti facendo riferimento ai differenti livelli di astrazione in cui si articola l’analisi marxiana. La fondazione del materialismo storico, secondo Garcia-Quesada, si basa su affermazioni di carattere metastorico che costituiscono la teoria dei modi di produzione (al plurale) avendo a che fare con le condizioni generali di produzione e riproduzione di tutte le società a partire dal ricambio organico tre essere umano e natura. A un livello inferiore di astrazione abbiamo la teoria di un singolo modo di produzione che, basandosi su astrazioni storicamente determinate, si articola in tendenze o meccanismi operanti in virtù di relazioni necessarie/interne. Scendendo ancora nella scala dell’astrazione abbiamo la spiegazione di una formazione sociale in cui si sintetizzano le tendenze del livello precedente con le specifiche le condizioni in cui operano. A livello massimo di concretezza storica abbiamo, infine, le congiunture.
Sul piano ontologico il modo di produzione è astratto ma reale, mentre la formazione sociale è più concreta e con più determinazioni da spiegare. A livello epistemologico il modo di produzione è un sistema chiuso e i suoi risultati sono necessari, mentre la formazione sociale è un sistema aperto e presenta un certo livello di contingenza. In altri termini lo studio del modo di produzione capitalistico è necessario ma insufficiente per l’analisi di una formazione sociale in cui prevale perché si deve tener conto delle diverse modalità attraverso cui il capitalismo si espande entrando in relazione con altri meccanismi di tipo economico, politico, ideologico ecc.
Il concetto di modo di produzione, dunque, non esaurisce la teoria della storia di Marx ma ne costituisce il necessario punto di partenza. Questo concetto, però, rimane centrale nella teoria marxiana in quanto uno specifico processo di produzione rappresenta la condizione di possibilità per tutta l’attività degli esseri umani dal momento che questi devono organizzarsi socialmente per soddisfare i propri bisogni e sopravvivere. Esso, dunque, è il grimaldello teorico per la totalizzazione, vale a dire per articolare e integrare le differenti prassi umane in un processo storico unitario sebbene mai concluso. In questo senso il concetto di modo di produzione rappresenta la discontinuità di base nella storia, organizzando ciascuna delle diverse forme di sociali sulla base dei loro principi peculiari a partire dalle interazioni tra le prassi umane e le loro condizioni materiali. Ma a questo punto sorge una domanda. Come intendere questa discontinuità dal momento che per Marx esiste una storia unica per quanto costituita da tempi non omogenei? L’unitarietà del processo storico si può riscontrare al livello più astratto dell’analisi, perché esistono condizioni comuni, metastoriche per la riproduzione di ogni società. Ma la ritroviamo anche analizzando il capitalismo perché si tratta del primo modo di produzione che, per il suo intrinseco dinamismo, è portato a espandersi a livello globale.
Insomma, con il capitalismo abbiamo per la prima volta una storia mondiale tendenzialmente unificata. Secondo Garcia-Quesada, Marx, solo in un primo momento, concettualizza questa tendenza nei termini di una teoria stadiale dello sviluppo storico: l’espansione capitalistica, in qualità di stadio più avanzato, impone una singola totalizzazione spazio-temporale sulla molteplicità spazio-temporali delle coeve società caratterizzate da modi di produzione meno produttivi. In breve, lo stadio più avanzato è destinato a sostituire in toto quelli più arretrati in un processo che può essere concepito come un predeterminato schema di evoluzione. A partire dai Grundrisse, però, Marx articola una concezione diversa: il modo di produzione più produttivo non elimina necessariamente gli altri, ma crea diverse formazioni sociali sotto un meccanismo dominante, l’accumulazione capitalistica, che subordina e, nel caso, rifunzionalizza le forme sociali pregresse. Da ciò deriva, da una parte, la possibilità di delineare una concezione multilineare della storia, dall’altra, la capacità di rendere visibili diversi tipi di oppressione e sfruttamento. Questa concezione si è articolata e consolidata attraverso l’approccio teorico e politico di Marx ai paesi non europei. Un approccio che ha tra i suoi esiti più rilevanti l’ipotesi di una via russa al socialismo senza un passaggio preliminare attraverso un compiuto sviluppo capitalistico.
Ripetiamolo in altro modo: la dinamica capitalistica tende verso una totalizzazione dello spazio mondiale, ma quest’ultimo assume caratteristiche contraddittorie perché contraddistinto da uno sviluppo diseguale e combinato. Lo spazio-tempo capitalistico sussume ma non annulla la molteplicità delle configurazioni spazio-temporali presenti sul globo. Qui il tempo e lo spazio, come si può intuire dal titolo del libro di Garcia-Quesada, devono essere intesi come forme sociali storicamente mutevoli, vale a dire prodotti della prassi umana che organizzano i differenti processi sociali e che, nella loro inscindibile ma variabile relazione, definiscono le coordinate di ciascuna configurazione storica. Nonostante l’inseparabilità di queste due dimensioni, Marx utilizza modelli prevalentemente spaziali per descrivere le società precapitalistiche, con particolare riferimento al rapporto tra città e campagna. La dimensione temporale non scompare ma è messa in secondo piano perché questi tipi di società sono caratterizzati dalla longue-durée. La forte stabilità è una loro caratteristica essenziale. Il capitalismo è invece concettualizzato da Marx prevalentemente in termini temporali, caratterizzato come è dall’annichilimento dello spazio da parte del tempo. La separazione dello spazio dal tempo è però il portato dello stesso sviluppo capitalistico. È possibile pensare un processo sociale in termini esclusivamente temporali a patto di presupporre implicitamente uno spazio con caratteristiche costanti. Uno spazio, cioè, astratto, globale e mercificato in cui prevale la dimensione urbana.
Abbiamo fin qui visto l’importanza delle configurazioni spazio-tempo a livello teorico ed epistemologico. Ma c’è un altro aspetto che emerge leggendo Karl Marx, Historian of Social Times and Spaces. La rilevanza di queste configurazioni da un punto di vista narrativo. Nel raccontare la storia della Comune, per esempio, Marx, ricorre a uno slittamento nella scala della periodizzazione che permette una sorta di happy ending. Se ci si fermasse al breve periodo, alla congiuntura, la narrazione diventerebbe semplicemente tragica in considerazione del massacro dei comunardi. Ma su una scala temporale (e spaziale) più ampia possiamo prevedere la vittoria del proletariato. Questo slittamento ha una spiegazione politica, perché serve a motivare la prosecuzione della lotta. Al tempo stesso non si tratta di una scelta arbitraria dal momento che è possibile giustificarla sulla base della teoria marxiana la quale consente di affermare che i meccanismi generativi della lotta di classe non finiscono di operare nonostante la sanguinosa sconfitta della Comune.
La storiografia ha dunque degli aspetti narrativi che la accomunano alla fiction. Tuttavia, sottolinea Garcia-Quesada, questo terreno comune non dissolve la differenza tra i due generi e la loro specifica relazione con la realtà. Detto altrimenti, formulare un cronotopo – termine ispirato all’opera di Michail Bachtin che sta per configurazione spazio-temporale – significa per Marx articolare attraverso una narrazione il livello cognitivo, quello politico e quello estetico, anche se è il primo a prevalere perché la funzione principale in una storiografia realista è quella di dar conto dei meccanismi all’opera nel processo storico. Rimane il fatto che i cronotopi marxiani comportano sempre uno schieramento politico perché sono strutturati sulla base del conflitto descrivendo relazioni sociali diseguali con l’accumulazione del capitale come ultimo background di tutti i processi. Il resoconto marxiano della “cosiddetta accumulazione originaria”, per utilizzare un altro esempio tratto dal libro recensito, è una spiegazione narrativa che può essere formulata solo rendendo visibile il punto di vista degli espropriati, una spiegazione critica che approccia la totalità sociale dal suo lato nascosto e che implica una presa di posizione nella battaglia per la memoria.
Marx, a proposito del Capitale, parla della necessità di tenere distinti il metodo della ricerca da quello della esposizione (Darstellung) dei suoi risultati, consapevole del rischio di fare apparire l’esposizione stessa, anche in considerazione della sua articolazione dialettica, come una costruzione a priori. Ma con ciò, sostiene Garcia-Quesada, il filosofo tedesco si riferisce alla teoria del modo di produzione e dunque al livello dei sistemi chiusi. La narrazione rende invece conto della contingenza che inerisce ai sistemi aperti, cioè alle formazioni sociali e alle congiunture. La narrazione necessariamente completa l’esposizione, marxianamente intesa, al fine di spiegare la storia effettiva, collegando la microstoria con la macrostoria e, in questo modo, l’agency con le strutture e i meccanismi oggettivi che, a vari livelli, operano nelle diverse configurazioni spazio-temporali. Questi meccanismi, a loro volta, contribuiscono a definire la modalità narrativa più adatta alle società contemporanee. Se il capitalismo è il modo di produzione totalizzante per eccellenza, per descriverlo sarà necessario utilizzare un racconto a sua volta totalizzante ma, al tempo stesso, data la varietà delle forme sociali in cui esso domina, capace di fare affidamento su diverse sottotrame intrecciate in una narrazione multilineare.
Concludiamo con un’ultima considerazione. Secondo Garcia-Quesada, la dimensione episodica, che può essere catturata solo attraverso la narrazione, è quella che introduce la discontinuità nello spazio-tempo definito dalla narrazione stessa, indicando le possibili trasformazioni della dimensione strutturale e, in questo modo, un momento riconfigurativo che appare nella storia. Una considerazione di cui varrà la pena tener conto anche quando affrontiamo le questioni inerenti alla guerra in corso. Attraverso le attuali vicende belliche, infatti, si manifesta una tendenza verso il baratro che apparirebbe assolutamente ineluttabile qualora ci limitassimo a svelare il dispiegarsi delle leggi generali dell’accumulazione capitalistica.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.