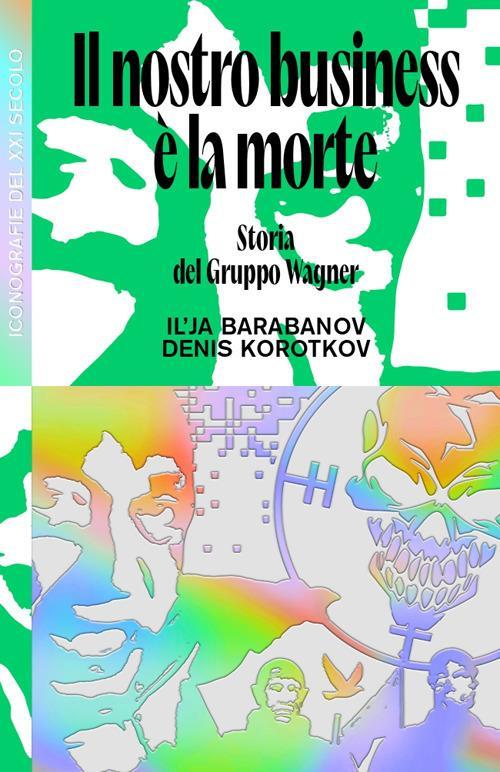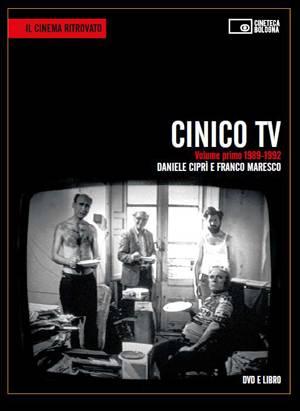Perché amiamo alcune serie Tv – Into “The Wire” (pt1)

Into The Wire (1)
Baltimore all I know. Man gotta live what he know.
Omar Little
David Simon, l’ideatore di The Wire, è stato definito dalla Entertainment Weekly’s TV come “il più brillante marxista ad aver prodotto uno show televisivo”. Lui ha rifiutato questa etichetta, eppure la critica della società capitalistica americana (da lui definita come “questa oligarchia ossessionata dal denaro che chiamiamo Stati Uniti d’America”) elaborata in questo prodotto televisivo è forte. L’immagine che si sedimenta in controluce durante la visione è quella di una battaglia nella quale alla fine il capitalismo ha trionfato, ma in cui al di là delle retoriche la working class continua ad esistere, funzionando anzi proprio come lente epistemica attraverso cui leggere le trasformazioni della città americana. Una classe che certamente non ha alcun orizzonte quale soggetto rivoluzionario, ma che porta in scena una narrazione difficilmente reperibile in altri sceneggiati. Quella di un sistema, di un modello sociale, che costitutivamente si fonda sulla costruzione di diseguaglianza. Troppo spesso infatti le retoriche filmiche che si propongono come critiche tendono al fondo ad elaborare teoresi cospirazioniste, o comunque finalizzate a mostrare come siano pochi cattivi corrotti ad inquinare la società. In The Wire invece appare chiaro come l’idea del business sopra a tutto valga come rappresentazione del capitalismo nella sua essenza. Utile a giustificare qualsiasi atto. Un’idea che conduce alle molte critiche elaborate recentemente anche in Italia che svelano il nesso indelebile tra ordine economico ed ordine criminale. Un legame indistricabile che riesce anche a mostrare come non si tratti di bene contro male o dell’individuazione di colpevoli, quanto appunto di una intima logica sistemica.
Tutto ciò è raccontato attraverso il tessuto urbano. The Wire è prima di tutto uno spaccato dell’urbanità americana. Il vero protagonista della serie è Baltimore, la città in cui tutta la storia si svolge, “dark corner of the American experiment” (Simon). La città è il prisma critico attraverso cui vengono esplorate le vicissitudini di ciò che Simon ha definito come “raw, unencumbered capitalism”.
Dipinta con uno stile che molti hanno paragonato al neorealismo italiano, questa di fatto non è una serie tv. Ma un lungo film di oltre 60 ore, spezzettato solo per esigenze televisive ma in cui le puntate non hanno propria autonomia senza (o quantomeno con un’alternanza di) personaggi principali e secondari.
La droga in realtà appare più come espediente narrativo che come focus della trama. Agli spacciatori ed ai poliziotti si affiancano politici, giornalisti, portuali, giudici, vagabondi… In un caleidoscopio di figure sociali che di volta in volta si trovano invischiate in rispettivi mondi istituzionali. Dei quali, stagione dopo stagione, vengono messi in luce gli intrecci, le connessioni che alla fine compongono un quadro integrato. E’ d’altra parte ancora Simon a dirci che in fondo la sua opera è “un trattato politico mascherato da un cop show”.
Per chi si è scolato la serie, andare a Baltimore è effettivamente in qualche modo entrare dentro The Wire. E diciamo subito che si ha conferma che il suo realismo stilistico ha un’effettiva aderenza alla realtà. Ma andiamo con ordine e proviamo ad inquadrare meglio Baltimore, una città della East Coast sita tra New York e Washington, che non era particolarmente conosciuta sino a quando è stata impressa nell’immaginario collettivo dalla serie televisiva The Wire. Eppure Baltimore è un punto di vista molto interessante per osservare gli Stati Uniti. Guardare questo paese attraverso tale città, come tutti gli sguardi, rende un’immagine ovviamente parziale, ma offre una storia che racconta tanto della vita di questo paese-emblema del capitalismo, fatto di ricchezze sfrenate e miseria assoluta.
Fondata a metà ‘700, Baltimore raggiunge l’apice demografico nel 1950, per poi vivere in maniera emblematica il processo di suburbanizzazione che caratterizza l’America di quel periodo. Se nel 1950 aveva quasi un milione di abitanti (di cui meno di un quarto neri), oggi ne ha poco più di seicentomila (di cui il 65% sono neri). Chiunque poteva permetterselo nei decenni post-bellici inseguiva il sogno americano della casa rurale col giardino davanti ed il macchinone per spostarsi, tanto che oggi oltre a quella che si considera come “città” va guardata l’area metropolitana: quasi il quintuplo degli abitanti, e viene spesso considerata come regione urbanizzata la cosiddetta BaWa (Baltimore-Washington) che arriva agli otto milioni e mezzo di abitanti. A questo processo di suburbanizzazione va legato anche quello di deindustrializzazione, che in termini di effetti sociali ha probabilmente solo in alcune zone di Chicago e in Detroit una durezza maggiore (e non a caso le due città si contendono il primato nei tassi di criminalità, con Baltimore sempre seconda con la sua media di molto superiore ai duecento omicidi l’anno). Non a caso David Harvey, che proprio a Baltimore ha fatto i suoi giovanili studi, ha ricostruito come dopo il 1960 la città abbia perso i due terzi del suo impiego manifatturiero, e nel libro Space of Hope ha scritto: “Baltimore is, for the most part, a mess. Not the kind of enchanting mess that makes cities such interesting places to explore, but an awful mess”.
Il porto della città, tutt’ora il più grande degli Usa, nacque prima della città stessa, e fu uno dei centri irradiatori dell’industrializzazione. In costante competizione con New York quale centro per lo smistamento degli scambi (sono le prime due città americane ad aver superato i centomila abitanti) grazie alla posizione geografica ed alla possibilità di accesso ad un fiume di collegamento con l’entroterra, verrà battuta dagli investimenti della borghesia newyorkese nella ferrovia, ma rimarrà comunque snodo di prim’ordine. Città indipendente, che vota democratico ininterrottamente da 150 anni, Baltimora è stata distrutta dall’intreccio di suburbanizzazione, deindustrializzazione e da quella che Loiq Waquant ha definito come “brutale implosione” dei ghetti neri: “The post-1960 ‘brutal implosion’ of the Black American ghetto is propelled from outside ‘by the confluence of the decentring of the national political system, the crumbling of the caste regime, the restructuring of urban capitalism, and the policy of social regression of the federal government set against the backdrop of the continued ostracization of African Americans”. Oggi ad un’economia basata al 90% sul terziario ed in cui il secondo datore di lavoro della città è la John’s Hopkins University, fanno da contraltare più di quattromila homeless (di cui molti giovani) ed uno spaventoso tasso del 37% di bambini che vive in povertà. Ricordata dalla storiografia ufficiale solo per la decisiva e vittoriosa battaglia nella guerra contro la Gran Bretagna del 1812 (quasi espunta dai libri di testo italici…), ha una storia puntellata di numerosissime rivolte ed enormi scioperi. Considerata tutt’ora, solo come lascito della tradizione però, come “città dei quartieri”, proprio -involontariamente- a segnalare questa grande capacità delle comunità di appropriarsi del tessuto urbano, Baltimore è un esempio significativo del declino della città Americana.
Il progressivo abbandono degli abitanti e la fuga dei capitali aveva reso il “centro” della città un’enorme distesa di povertà ed abbandono, sulla quale come da manuale negli ultimi decenni si è imposta una gigantesca operazione di gentrification che ha costruito un corridoio urbano che dal porto reso attrattivo per i turisti corre a nord fino al campus della Johns Hopkins. Un fascia di terra che non a caso la parte di benestanti della città chiama Safetimore o Smalltimore. E’ ancora Harvey che può essere preso come spunto per mostrare questo processo, in questo video (annesso ad una conferenza di alcuni anni fa chiamata “City from below”) dove dall’alto di una collina dalla quale si può mirare tutta Baltimore descrive le trasformazioni urbane:
<
leggi pure:
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.