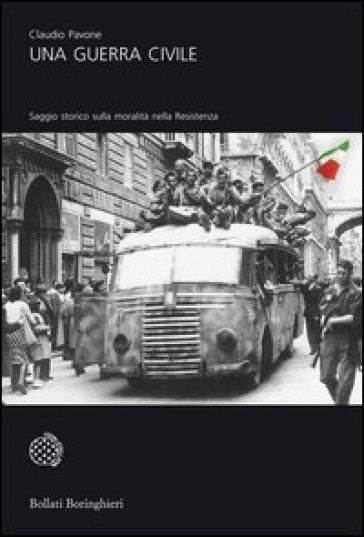
Sulla moralità nella Resistenza (perché si può e si deve parlare di “guerra civile”)
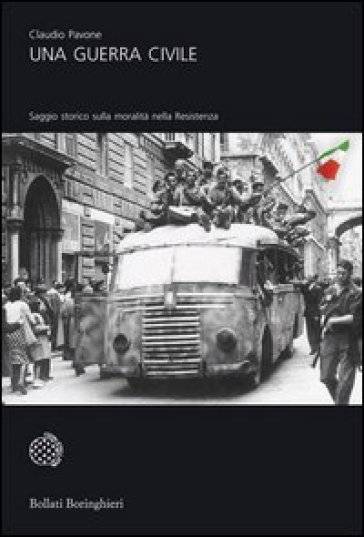 Estratto di una Conversazione con Claudio Pavone.
Estratto di una Conversazione con Claudio Pavone.
In occasione della ricorrrenza della 25 aprile, recuperiamo e proponiamo ai nostri lettori un pezzo di un’interessante intervista realizzata da Daniele Borioli e Roberto Botta nel 1991 per il “Quaderno di Storia Contemporanea” (qui l’intervista integrale) a Claudio Pavone, storico e partigiano italiano nonché presidente della Società italiana per lo studio della storia contemporanea e direttore della rivista di studi storico-politici “Parolechiave“. L’intervista fu realizzata a ridosso dell’uscita del suo libro “Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza” che da allora si è imposto come uno dei lavori di rilettura storica e profondità politica più interessanti e stimolanti sul fenomeno resistenziale. In questo estratto Pavone spiega perché, reletivamente alla Resistenza si può e si deve parlare di “guerra civile” senza per questo concedere nulla ai revisionismi di comodo.
Il riferimento forse più significativo è quello alla presenza di tre diverse figure di nemico; ma prima di dire alcune cose a questo proposito vorrei precisare perché io preferisco, anche per la prima delle tre guerre, la definizione di guerra patriottica a quella di guerra di liberazione nazionale. Il motivo è che nel dopoguerra in questo modo venivano definite proprio le guerre che univano la lotta di classe e la lotta patriottica, diventando quindi un’espressione forse ancora più intrisa di significato ideologico e politico rispetto a quella di guerra civile. Per di più nella formula “guerra di liberazione nazionale” resta qualcosa di imprecisato: da che cosa bisogna liberare la nazione?
Dunque, il nemico nella guerra patriottica è lo straniero invasore, e cioè il tedesco. Certo, c’è a monte il problema, cui nel libro accenno, che invasori erano anche gli inglesi e gli americani; ma allora bisognerebbe capire perché gli uni venivano percepiti come invasori e gli altri come liberatori, nonostante tutti gli sforzi in contrario della propaganda della Rsi; ma questo è un tema che qui non possiamo sviluppare. Il tedesco invasore però era anche nazista, non era un invasore privo di qualifiche politiche e ideologiche: e questo ci porta già sul terreno della guerra civile, come grande guerra civile europea.
Nella guerra civile il nemico era il fascista, proprio come figura politico-esistenziale, che era tale non solo per i garibaldini, ma anche per i GI, e per una parte almeno dei liberali, dei moderati, dei cattolici. Il fascismo era un fenomeno globale che andava combattuto anche se non se ne riconoscevano le radici o per lo meno le componenti di classe. Questo è un concetto importante da tenere presente, perché altrimenti si finirebbe con il riproporre l’ortodossia terzintenazionalista secondo la quale il fascismo è solo un fenomeno di classe, per cui essere “antifascisti conseguenti” ed essere proletari e, soprattutto, comunisti coincide. E invece non ha sempre coinciso, e sarebbe curioso che arrivassero a questa conclusione proprio gli antifascisti non comunisti, nella recente loro ansia di sbarazzarsi dell’antifascismo.
La guerra di classe si può considerare, da un punto di vista di rigorosa distinzione logica, come un fenomeno che rientra sotto la categoria di guerra civile: la guerra civile dopo l’Ottobre è anche guerra di classe. Esistono cioè guerre civili che coincidono pienamente con la guerra di classe, ma non sempre è così. Comunque la guerra di classe, quando ha per nemici persone della stessa nazionalità, è sicuramente riconducibile sotto la categoria generale di guerra civile. Conserva tuttavia, nel nostro caso, alcune specificità, che traggono origine dal fatto che, come ho detto, non tutti gli antifascisti erano socialmente proletari, né tutti erano ideologicamente disposti a far coincidere fascismo ed oppressione di classe. Qui si potrebbe riconoscere quanto c’era di giusto nella storiografia operaista, e cioè che per un operaio politicizzato il padrone era una figura che trascendeva lo stesso fascista: c’era cioè un’oppressione di classe nel corso della quale i padroni s’erano serviti del fascismo, e proprio per questo nel combattere i fascisti bisognava cogliere l’occasione storica per combattere anche i padroni, i quali, fascisti o non fascisti, andavano Comunque combattuti: cosa che un liberale sinceramente antifascista non avrebbe mai ammesso. La distinzione della terza guerra rispetto alla seconda dunque si ripropone. Nella guerra di classe la principale figura del nemico è allora quella del padrone, e io, forse con una battuta troppo facile, ho scritto che l’ideale di un operaio politicizzato sarebbe stato quello di trovarsi contro un padrone in camicia nera e sfacciatamente servo dei tedeschi, ma che il padrone non sempre lo accontentava. Anzi, i padroni erano abbastanza accorti per accontentarli in misura sempre decrescente. E qui verrebbero alla luce tutti i problemi relativi ai doppi giochi: finanziare i Chi e fare contemporaneamente buoni affari con i tedeschi eccetera, ma si tratta di problemi che non rientrano strettamente nell’ambito della guerra civile, la lambiscono ma sono questioni diverse.
Questa chiave di lettura della Resistenza in cui i tre livelli, della guerra patriottica, della guerra civile e della guerra di classe, si intrecciano e si sovrappongono, determinando all’interno della stessa vicenda aspettative, atteggiamenti e comportamenti differenti, la vai elaborando già da alcuni anni, a cominciare dalle occasioni che tu stesso hai ricordato. Nonostante questa precisa e rigorosa definizione dei tre livelli, a noi pare che nell’attenzione accordata al tuo libro dai mezzi di informazione sia possibile cogliere una tendenza alla semplificazione che porta a far coincidere il livello della guerra civile con quello della guerra di classe. Ed in sostanza a riproporre, certo con non poche forzature, una interpretazione esclusiva e fuorviante della guerra partigiana come confronto armato tra due ideologie totalitarie, quella fascista e quella comunista.
Soprattutto quest’ultimo punto è emerso non solo in certe “interpretazioni” del mio libro, ma ha attraversato tutte le polemiche degli ultimi due anni: totalitari gli uni e totalitari gli altri. I venti mesi come una commedy of errors, insomma. Ma questo mi sembra veramente del tutto insufficiente come tentativo di spiegazione, e poi è contraddittorio con l’interpretazione della Resistenza quale grande fatto unitario nazionale: se veramente la Resistenza, accettando e rovesciando il segno dello slogan “la Resistenza è rossa, non è democristiana”, è stato questo scontro tra due totalitarismi, chi è caduto in un equivoco ancora maggiore, e direi grottesco, sono stati i cattolici, i moderati, e persino i GI, i quali, non essendo totalitari, si sono fatti risucchiare più o meno per dabbenaggine in uno scontro tra opposti che erano nella sostanza uguali. La cosa mi pare quindi priva di qualsiasi possibilità euristica. Il che non significante da altri punti di vista questo problema non possa e debba essere preso in considerazione: ad esempio, se e come il comunismo staliniano e il fascismo e il nazismo possano rientrare tutti, pur con le ovvie differenze, sotto la categoria generale di totalitarismo, ma questo è un altro discorso. Interpretare la Resistenza nel modo sopraddetto significherebbe però considerare la storia come una deduzione dei fatti dalle ideologie. Sarebbe davvero una operazione ideologica, mentre invece, nei limiti delle mie capacità e delle mie forze, ho cercato di dimostrare per quali ragioni un partigiano poteva gridare “Viva Stalin e viva la Libertà” senza contraddizioni. Oggi qualcuno potrebbe dire: ma come! Stalin era contro la libertà e quindi bisogna cassare uno dei due termini. No. Teniamo anche presente che molti partigiani lo gridavano morendo, e quindi in quell’espressione unificavano delle cose che in quel momento alle loro coscienze si presentavano congiunte. Storicamente bisogna porre grande attenzione nel cercare di comprendere la concretezza dei singoli atti. Perciò ricondurre la Resistenza, o anche solo la sua componente classista, sotto il criterio di una lotta fra ideologie totalitarie non può portare molto lontano, anche se, lo ripeto, resta aperto il problema del totalitarismo come trista caratteristica del nostro secolo.
A proposito del concetto di guerra civile, tu prima parlavi di una certa refrattarietà della storiografia e del mondo politico di sinistra a usare questo termine. E’ un atteggiamento che in qualche modo contraddice un uso ampio del concetto che è possibile riscontrare non solo nella documentazione garibaldina e giellista, ma anche in diversi prodotti della storiografia resistenziale – dove il termine è però spesso utilizzato senza una precisa forza analitica – e nei discorsi politici post Liberazione di molti uomini della resistenza (1).
Le fonti coeve hanno senz’altro molto minori scrupoli ad usare questa espressione. E’ dopo che nasce la rimozione.
Certo, ed hai anticipato in qualche modo la domanda: ci sembra infatti che questa impreparazione e refrattarietà postuma a confrontarsi con il concetto di guerra civile sia anche la spia di quanto la storiografia e la cultura resistenziale siano state sostanzialmente condizionate, sino a non molti anni fa, da esigenze e cautele politiche.
Non c’è dubbio. In un primo momento c’è stata una specie di continuazione dell’unità di vertice ciellenistica, grosso modo sino alla cacciata dei comunisti e dei socialisti dal governo; sino ad allora, bene o male, l’unità era il concetto accettato un po’ da tutti o quasi, almeno a parole. Dopo quella cacciata c’è stato un fenomeno che ha portato a rivendicare per molti anni il concetto di unità da parte della sinistra, in specie dai comunisti, proprio per qualificarsi come forza nazionale: poiché i sovversivi e, di nuovo, soprattutto i comunisti, erano sempre stati qualificati come antinazionali, c’era ora l’esigenza politica di presentarsi come parte legittima del sistema repubblicano, anche se fuori dal governo, e di far ricadere la colpa della rottura solo sui democristiani, riaffermando di contro la vera propensione unitaria del proprio schieramento. In quel contesto parlare di guerra civile quadrava poco: la Storia della Resistenza di Battaglia (2) rispecchia in qualche modo questa fase.
Però facendo queste riflessioni a volte si dimentica la controparte, nel senso che nell’esorcizzare gli aspetti di guerra civile c’è una responsabilità anche del centro-destra antifascista. Per questa parte politica glissare sul concetto di guerra civile rappresentava un’implicita polemica contro quel troppo di rosso che c’era stato nella Resistenza. Era quindi un modo per respingere tutto quel filone interpretativo (storiograficamente da considerare certamente con occhio critico) che si è basato sul tema della Resistenza tradita o di La Resistenza accusa, il libro di Pietro Secchia (3). Se invece, quando proprio non si poteva tacere, si diceva che la Resistenza era stata un embrasson nous generale questo edulcorava ed esorcizzava gli aspetti inquietanti, utopici, drammatici della lotta di Liberazione. Alla Resistenza tradita veniva contrapposta così una Resistenza beata e soddisfatta, al santino di sinistra si affiancava un santino di destra.
Poi c’è stata una fase in cui l’establishment di governo ha capito – e questa è naturalmente solo una mia schematizzazione – che lasciare il monopolio della Resistenza, sia pure con quella bandiera unitaria, dietro la quale si ostinava peraltro a far capolino la bandiera rossa, alla sinistra poteva non convenire: forse conveniva di più assorbirla per fame una tavola di fondazione un po’ generica della democrazia repubblicana. t stata la fase in qualche modo connessa al cosiddetto disgelo costituzionale, in cui si comincia a non considerare più la Costituzione una trappola, come diceva Scelba, ma un ambito entro cui confrontarsi. Ciò comportò l’assorbimento della Resistenza in un canone nazionale che tranquillizzava tutti, e lo si può vedere, ad esempio, nella sostanziale identificazione che venne fatta delle forze partigiane con l’esercito del sud. Ovviamente è necessario il massimo rispetto per quelli che a fianco dell’esercito alleato hanno combattuto e sono morti. Però si tratta storicamente di due fenomeni diversi. Invece abbiamo potuto vedere, da un certo periodo in poi, che erano i ministri della difesa e i generali ad essere incaricati di celebrare il 25 aprile, un modo per far rientrare la Resistenza nella storia italiana in maniera molto asettica.
Sotto questo aspetto il Sessantotto fu salutare, per distinguere e spezzare, dopo una primissima fase quasi di rigetto, la unità oleografica della Resistenza, anche se con prese di posizione magari schematiche, come ad esempio il già ricordato slogan “la Resistenza è rossa, non è democristiana”. L’operaismo e il movimentismo furono atteggiamenti che richiamavano l’attenzione su problemi reali ma li semplificavano oltre il lecito. Ma allora, nella storiografia successiva al Sessantotto, si sono poste le basi di quella nuova stagione che forse può apparire ovvia: se la Resistenza va vista nella sua complessità, nelle sue contraddizioni e anche nelle sue lotte intestine, si prepara il terreno per riconoscere che il concetto di guerra civile non può più essere esorcizzato. E tengo a precisare che senza questo movimento post-sessantottesco nemmeno a me sarebbe probabilmente venuto in mente il mio schema interpretativo. Non lo dico certo come fatto personale, ma per sottolineare come molte volte le cose mutano per fattori complessi e per fortuna anche extrastoriografici. Del resto la storiografia è una disciplina che cerca di dare del passato una spiegazione rispetto alle domande che pone il presente, e siccome il presente muta per mille motivi bisogna risalire anche a questi motivi.
Note
(1) Un utile ed attento esame della fortuna e della sfortuna del concetto di guerra civile nel secondo dopoguerra è nel saggio di Cesare BERMANI, Guerra di liberazione e guerra civile, in “L’Impegno. Rivista di storia contemporanea”, Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea in provincia di Vercelli, anno X, n. 1, pp. 10- 16.
(2) Cfr. Roberto BATTAGLIA, Storia della resistenza italiana, Torino, Einaudi, 1 ed. 1953.
(3) Cfr. Pietro SECCHIA, La Resistenza accusa, Milano, Mazzotta, 1973.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.




















