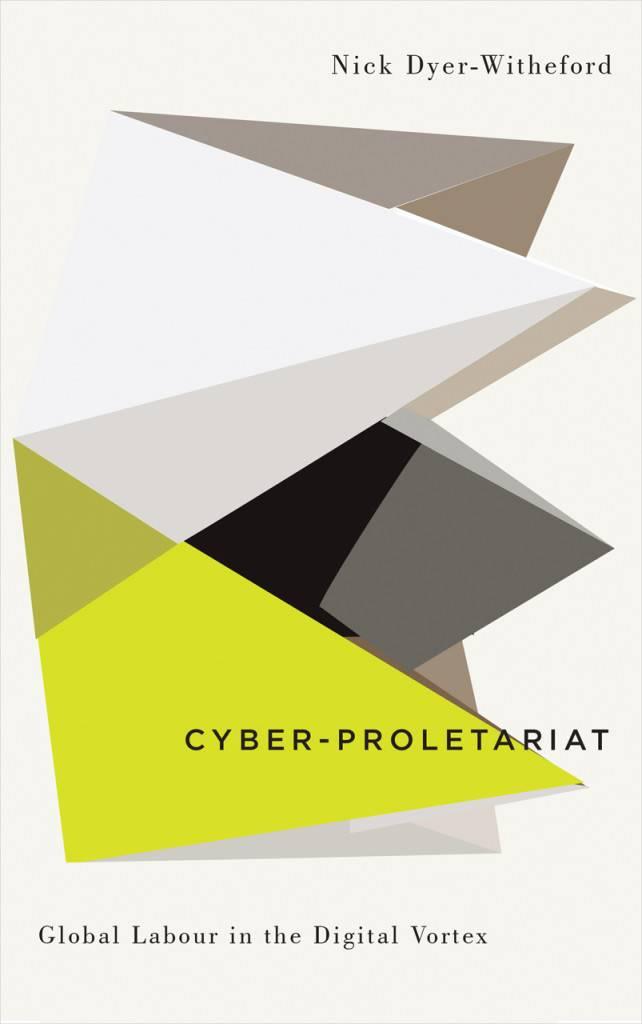Discorso o pratica dell’utopia? Colloquio virtuale con Carlo Formenti

“La questione del potere, allusa dal movimento nel ’69, è ancora in attesa di pensieri ben pensati, e di risposte non conformiste”, scriveva Paolo Virno nel 1989, l’anno in cui – a vent’anni esatti dall’autunno caldo – gli stati socialisti orientali iniziavano il loro domino, sotto la spinta dei movimenti più forti ed estesi visti da molti anni ad allora, e non se ne sarebbero visti così fino ai moti sudamericani degli anni 2000 e a quelli arabi degli anni 2010. In questi anni 2010, i nostri anni, un altro protagonista della stagione dell’operaismo italiano, Carlo Formenti (primo traduttore italiano de La condizione postmoderna di Lyotard ed analista delle tecnologie digitali), scrive un libro (Utopie letali, Jaca Book, che consigliamo vivamente) per prendere congedo da quella “tradizione” (quella dell’operaismo, appunto), proprio perché, a distanza di tanti anni da quel ’69 (e da quell’89) appare chiaro che, all’interno di essa, pensieri ben pensati e risposte non conformiste sulla questione del potere non sarà facile trovare; e Formenti, nel suo libro, cerca di spiegarci che non è un caso.
Fu sempre Paolo Virno, d’altronde, a inizio anni Duemila, in un’intervista rilasciata ai ricercatori di Futuro anteriore, a dire che l’operaismo è una tradizione e, come tale, andrebbe buttata a mare. Punto di vista condivisibile, ma il problema non riguarda noi militanti: contrariamente agli analisti o ai tifosi dei movimenti – lo ricorda bene nel suo libro Formenti – i militanti vengono selezionati dai movimenti e vivono in essi e per essi; non hanno bisogno di alcuna collocazione teorica, di nessuna etichetta di scuola, poco importa se identitaria, anti-identitaria o alternativa. L’immersione nell’azione politica quotidiana impedisce, infatti, non la riflessione e il concetto, ma l’indulgenza verso le astrazioni e, ancora, la credulità verso tutta una serie di fandonie di stampo accademico o para-accademico che nel libro di Formenti vengono criticate e messe allo scoperto. Molte compagne e compagni in giro per l’Italia si sentiranno quindi spontaneamente vicini alle argomentazioni dell’autore, che riecheggiano ciò che da anni molti sottolineano nelle situazioni di lotta; e tuttavia non mancheranno, noi crediamo, di scorgervi alcuni limiti a cui, come umile contributo al dibattito, volgeremo qualche accenno.
Ripensare la transizione
Il principale merito di Utopie letali è proprio quello di denunciare il vuoto di dibattito che, dal 1968, si è creato attorno a una questione esiziale per chi desidera un cambiamento radicale della società: quella della transizione, termine che l’autore utilizza per indicare il passaggio concreto da una società capitalista a un’altra, non capitalista; ed è, senz’altro, ciò che Virno intendeva quando parlava venticinque anni fa di un’inevasa questione del potere. Dopo aver fatto notare come questo problema fosse stato ampiamente affrontato, tra gli altri, da autori come Marx, Lenin e Gramsci, e come in generale dalla comune di Parigi alla seconda guerra mondiale esso fosse nei fatti tutt’uno con l’agenda politica dei movimenti operai e rivoluzionari, Formenti registra l’eclissi del problema nel “trentennio dorato” (ma freddo) seguito al 1945, per poi attaccare duramente l’esorcismo teorico che, verso di esso, è stato prodotto dopo quel trentennio di lotte senza sbocchi rivoluzionari; vale a dire negli anni (1980-2010) della crisi profonda delle nozioni di antagonismo di classe, sinistra, comunismo.
La questione del potere è bensì stata variamente affrontata, egli dice, ma, paradossalmente, proprio per eludere il problema della sua conquista: ciò che Formenti chiama (forse un po’ genericamente, in questo caso) “postmodernismo” ha concentrato la sua attenzione sulle forme microscopiche del potere, sulla perdita di rilevanza dei centri, sull’ingarbugliarsi dei livelli gerarchici delle istituzioni e sul valore politico delle minoranze; ciò che non costituirebbe un errore in sé, se l’obiettivo primario non fosse stato proprio nascondere l’evidenza di un fatto imbarazzante: mentre nelle aule dei “ghetti dorati delle facoltà umanistiche” (eccellente definizione formentiana) si tenevano seminari sexy-noiosi, e non di rado banalizzanti, su una resistenza che si voleva frammentata alle forme del dominio molecolare, o sulla liberazione imminente/immanente dell’umano grazie all’uso delle nuove tecnologie, vecchissimi macropoteri si innovavano (anche molecolarmente, ed anche grazie alle tecnologie) per approntare la gestione totalitaria delle nostre vite; e il rispetto linguistico delle minoranze, con annessa la critica “antiautoritaria” di ogni forma di organizzazione politica, diventavano grimaldello ideologico contro chiunque osasse contestare l’ordine costituito – tanto nella pratica quanto nell’ordine del discorso.
Diritti e beni comuni
Tale critica cosiddetta “antiautoritaria”, che Formenti identifica (forse, di nuovo, un po’ genericamente) con il lascito del “vietato vietare” di sessantottina memoria, ha concentrato una parte grandissima dei suoi sforzi sull’analisi e la decostruzione delle forme e delle teorie proprie dei movimenti stessi – in primo luogo il movimento operaio, ma in verità ogni genere e ogni sorta di struttura, organizzazione o relazione politica che si volesse in rottura con la società capitalista. Il risultato, secondo Formenti, non è stata la creazione di una nuova teoria critica o rivoluzionaria, migliore della precedente, ma lo sposalizio ipocrita (perché avvenuto sotto mentite spoglie) con il vecchio e decrepito pensiero liberale. Qualche esempio? Anzitutto quelle che l’autore chiama “rivendicazioni postmaterialistiche”, cioè slegate (almeno secondo i discorsi postmodernistici) dal conflitto di classe tra capitale e forza lavoro (minoranze “etniche”, linguistiche, “culturali” e di orientamento sessuale in primo luogo; il caso delle donne, lo sottolinea l’autore stesso, è più complesso); rivendicazioni che hanno nel tempo rifiutato ogni prospettiva di rovesciamento delle istituzioni esistenti per rivendicare una sorta di ingresso nel sistema delle garanzie giuridiche, avanzando la pretesa di ottenere “diritti”.
Formenti analizza le opere di svariati autori, “di movimento” e non, per mostrare come questa scelta sia letta anche dagli ideologi liberali come consona a conservare l’equilibrio sistemico nell’età della “postdemocrazia” (il tempo in cui le democrazie liberali restano orfane delle proprie parziali capacità di rappresentanza sociale, e sperimentano forme nuove di autoritarismo). L’esito recente di questa tendenza è esemplificato, in Italia, dalle teorie del ben noto Stefano Rodotà, secondo cui il corpus giuridico è rimasto, dopo la fine delle lotte novecentesche, ultimo baluardo concreto contro il dilagare dei rapporti di forza brutali imposti dal liberismo dispiegato. Una concezione che non spiega in che modo un apparato testuale fatto di timbri e ceralacca potrebbe fare da argine all’interesse di chi possiede armi e capitali; un’impostazione che non menziona le striature interne al dettato giuridico, in ogni tempo e luogo, e ad ogni livello (altrettante tracce e sedimentazioni di lotte, lutti e prove o rapporti di forza) e soprattutto, fa notare Formenti, non indica quali soggetti sociali in carne ed ossa sarebbero pronti a sobbarcarsi il dubbio onore e l’enorme onere di partecipare a questa battaglia.
“Abbiamo già vinto”
Ciononostante Formenti concede ai teorici del “diritto di avere diritti” il beneficio di una certa coerenza: se la teoria appare astratta e inconcludente, ciò accade per la ben nota discrasia logica che esiste tra liberismo (fatto) e liberalismo (trasfigurazione; sogno, delirio). Coloro ai quali l’autore non è disposto, invece, a concedere altrettanto sono i “benecomunisti” più radicali, che tentano di piegare l’idea di una difesa dei “Beni Comuni” (non tutti lo sanno, forse, ma essa è già in origine una categoria giuridica, presente in ogni manuale di diritto costituzionale) a una sorta di battaglia comunistica con finale colpo di scena: i movimenti benecomunisti sarebbero l’anticamera, nientemeno, della fine dell’antica distinzione tra diritto pubblico e diritto privato (e dell’apparire eirenico e tutto sommato indolore del regno della libertà e della cornucopia comunista). Come, fa notare Formenti, non si sa (non possiamo che rinviare al libro per il dettaglio del suo ragionamento). Proprio su questo punto le teorie “postoperaistiche” (avversario principale qui è Negri) denunciano il loro carattere “vetero” (per usare contro di loro il loro stesso, sempiterno ritornello polemico) nel momento in cui rispolverano l’antico adagio a/traversista de ‘la rivoluzione è finita, abbiamo vinto’, sempre buono per mascherare il buon vecchio determinismo metafisico nei tempi che corrono, con la sola variante del ridicolo (che, stavolta, non fa ridere).
Analogamente a ciò che Formenti chiama “neosituazionismo”, ossia agli adepti del “comitato invisibile” francese, infatti, i “postoperaisti” sostengono che di transizione (e a ben vedere – in entrambi i casi – anche di concreta “insurrezione”) non c’è alcun bisogno, perché il capitalismo cadrà da solo, in base a leggi oggettive della storia mascherate con finezza post-strutturalistica in un: “toh, sta per crollare”; ovviamente per una “magia” interna che, non potendo essere più chiamata “scienza” – le (malintese) apparenze antimetafisiche vanno rispettate – è ormai semplice “evidenza”, là dove anche la conricerca e l’inchiesta, non a caso, hanno ceduto il passo all’erudizione accademica. Ma “evidenza” di cosa? Delle intuizioni frutto dell’elucubrazione filosofica, naturalmente, altra base epistemica altamente innovativa che accomuna, senza alcuno scandalo, opere degli anni 2000 come l’Appello post-tiqquniano e Moltitudine. Anzi: il comunismo c’è già, anche se noi non lo sappiamo, e basterà, parafrasando Jim Morrison nel film di Oliver Stone, “sbarazzarsi della sfida con una scrollata”. Tutto ciò che ci serve è costruire una miriade di ghetti e chiamarle “Comuni” oppure, nella variante negriana, presentare liste in circoscrizione e dirottare un po’ di fondi sul doposcuola del centro sociale: il gioco è fatto. No, dice Formenti: il gioco non è fatto, perché la rivoluzione non è un gioco.
Rivoluzione e organizzazione
Nel contestare il carattere intellettualmente imbelle di simili forme di determinismo mascherato, Formenti arriva a contestare alcuni punti fermi dell’analisi del capitalismo cognitivo, che noi invece condividiamo (ci torneremo più avanti); ma ciò che più conta, a nostro avviso, è la critica che egli dispiega alla rimozione dell’elemento rivoluzionario, di rottura politica concreta, che tale determinismo tenta di nascondere senza neanche troppa convinzione. Riprendendo il Marx de Le guerre civili in Francia, Formenti pone l’accento sul carattere organizzato che i movimenti devono assumere per poter trasformare concretamente i rapporti sociali, a partire – non potrebbe essere altrimenti – dalle procedure esistenti della decisione politica, che non devono essere passate di mano, bensì distrutte; ciò che avrebbero voluto fare i comunardi (che commisero l’errore di temperare la propria ferocia rivoluzionaria) e come fecero effettivamente i bolscevichi (che incamerarono una ferocia doppia dopo l’esperienza del 1905 e, quale formidabile riferimento ansiogeno, della stessa Comune).
Il rifiuto di organizzarsi, tuttavia, oggi è piuttosto diffuso, soprattutto in quell’area umana che si distingue tanto dai neofiti (i soggetti sociali che si affacciano alla lotta) quanto dai militanti (quelli che si sono già votati ad essa): si tratta del magma degli “attivisti” felici e confusi e delle “libere individualità” impegnate nella propria indefinita autovalorizzazione moralistica. Questi attivisti e questi liberi individui pongono sovente il veto della cosiddetta “orizzontalità assoluta”, che si risolve in un metodo per cui la discussione è tutto, mentre il ricorso all’azione è un optional, producendo un immobilismo e una frustrazione in seguito alle quali non è raro che le questure arrivino a dispensare qualche giorno di ferie ai propri funzionari. Formenti è lapidario: “Dietro questo lessico radical-chic, occhieggiano le (…) decrepite categorie liberali”.
Si badi: l’accusa di liberalismo – ne siamo consapevoli – è un’accusa che anarchici e anarcoidi non accetteranno mai, perché, nell’immacolatismo politico che li contraddistingue, vi vedranno immediatamente una messa in dubbio della propria “onestà” ideologica o, nel caso dei più scafati, della propria proverbiale intelligenza. Invece, come spesso accade, l’errore peggiore non si commette con dolo, ma proprio con ingenuità; né le fatali corrispondenze prendono corpo nella lettera del flusso linguistico (lo stile letterario e le terminologie anarchiche e liberali sono incomparabili), bensì sul terreno più insidioso del concetto e, soprattutto, dell’(in-)azione, qui intesa come castrazione di ogni possibilità di costruzione condivisa dell’azione sovversiva.
Parte e partito
Al rifiuto teorico e pratico dell’organizzazione corrisponde, inoltre, l’inconsapevole rinuncia a costruire la figura essenziale del nemico, l’unica che può riportare il discorso sull’odio alla pratica dell’odio. La rimozione è quella del carattere duale della politica, intesa come guerra sociale dispiegata o latente, come conflitto esiziale tra due parti inconciliabili, che prevede il riconoscimento psicologico dell’esistenza di un avversario, di un campo avverso, dunque anche di un campo amico, giacché una vita fondata sulla discordia (quella del rivoluzionario) è proprio per questo anche e soprattutto una vita basata sull’amicizia, e se vogliamo persino su una certa qual fraternità, che è al contrario negata al suddito disciplinato dell’ordine capitalista. (Una fraternità e un’amicizia che essendo grandi, scettiche e curiose, e talmente adirate da voler diventare immense, sono l’esatto contrario dell’affinità). Abbiamo ritrovato una simile concezione dell’antagonismo nella condivisibile scelta di Formenti di riportare la vecchia questione comunista del “partito” (come già aveva fatto un sostenitore di tesi opposte, Marcello Tarì, ne Il ghiaccio era sottile) alla sua corretta radice etimologica nonché storica: quella del “prendere parte”, del “prendere partito”, dell’essere “partigiani”, e di avere, se si vuole, un “partito preso” per o contro qualcuno o qualcosa.
Ciononostante, dopo aver posto la questione in questi termini, egli avanza una proposta che ricalca tutt’altra cosa, ossia la forma-partito: termine apparentemente analogo, con cui però si indica la modalità storica che il “prendere parte” anticapitalista ha assunto lungo la prima parte del ventesimo secolo. Una forma che ha avuto molti pregi, non ultimo l’aver permesso importanti, ancorché brevi, rivoluzioni sociali, ma che non può essere considerata la forma definitiva di organizzazione della parte avversa al capitale, se non altro perché ciò nasconderebbe una considerazione delle lotte che rischia di rivelarsi astratta; le cose, lo sappiamo, non si ripetono mai nello stesso modo. È vero che Formenti argomenta per una versione rinnovata, “federativa” e “corporativa”, della forma-partito (immaginata sulla falsa riga del MAS, il Movimento per il Socialismo boliviano, guidato dall’attuale presidente Evo Morales), dove diversi soggetti, che si sono organizzati su diversi fronti sociali, si coalizzano: ma non si vede come tutto questo potrebbe offrire gli spazi di profonda dinamicità che le lotte necessitano nei tempi moderni, né impedire l’endemica degenerazione burocratica che identifica ormai ogni forma-partito con l’incrostarsi di gerarchie.
Organizzazione partigiana
Non a caso, chi da anni crea e disfa attorno ai movimenti “grandi alleanze”, “coalizioni”, “unità” di stampo politicistico e para-burocratico sono proprio i seguaci acritici di quelle forme di “benecomunismo” e “postoperaismo moltitudinario”, magari mescolati con un po’ di elettoralismo e un po’ di diritti, che Formenti non considera aver realmente “preso un partito” per la trasformazione in senso postcapitalistico della società. Senza contare che, uno dopo l’altro, tutti questi esperimenti falliscono, rivelandosi precari piedistalli per la riproduzione di forme di relazione politica che appaiono lo specchio della continua ridefinizione strumentale delle alleanze parlamentari (portate avanti da partiti che, peraltro – si pensi a Forza Italia, al MoVimento 5stelle e, in forma maggiormente metamorfica, anche al Pd – hanno da tempo, e non a caso, abbandonato la struttura novecentesca della forma-partito). È soltanto la prassi concreta dello scontro, crediamo, ogni volta diversa e imprevedibile, che dovrebbe orientare i criteri e i modi dell’organizzazione pratica, su piccola o su vasta scala, giacché (come abbiamo altrove sostenuto, e Formenti vi fa riferimento) non esiste organizzazione che possa essere slegata dall’immediatezza degli scopi pragmatici del conflitto: tutto il resto rischia di essere recupero, cristallizzazione, pessimo auspicio e, probabilmente, finale già visto (al di là di tutte, e comunque rare, migliori intenzioni).
In un certo senso, la “rigidità politica” che tanto noi quanto Formenti riconosciamo ai movimenti che riescono a crescere e rafforzarsi, è una rigidità che ha a che fare anzitutto con la determinazione nella contrapposizione, la quale porta sì, in sé, anche la capacità di organizzazione, ma è un’organizzazione dinamica e informale, là dove al termine “informale” si vogliano sottrarre tutte le attribuzioni ideologiche che ha dovuto patire da parte di chi ha contribuito nel tempo a forgiare le argomentazioni “antiautoritarie” di sui sopra. “Informale” è un aggettivo cui dovrebbe essere nuovamente attribuito il senso di relazioni militanti che sappiano darsi continuità, estensione, forza e progettualità senza ricadere nel burocratismo; il quale, si badi, è proprio di qualsiasi separazione tra ruoli e azione, anche quand’anche (come avviene regolarmente) tale separazione si produca nei centri sociali o nei gruppi “libertari” o “informali” (nei quali, lo ricorda Formenti, emerge nei modi più patetici la delega silente e ipocrita ai bohèmien più carismatici della… situazione). Il genere di organizzazione partigiana che alcuni compagni in Italia stanno cercando di produrre ci sembra incompatibile con la forma-partito tradizionale, quand’anche adattata ai tempi: essa sarà piuttosto il frutto storico, a tutt’oggi purtroppo acerbo, della decostruzione antagonistica di quella forma.
Movimenti e rete
Una mole molto vasta di riferimenti bibliografici, che vanno dal saggio politologico al pamphlet di movimento, e dall’articolo giornalistico all’inchiesta militante, permette a Formenti di esporre anche una lunga serie di circostanze empiriche che costituiscono un buon giacimento di informazioni per chi vuole comprendere gli anni in cui viviamo. Dalle radici della svolta finanziaria alla sua crisi, dai crimini sociali delle politiche liberiste alla formazione di un nuovo, immenso corpo mondiale di salariati (200 milioni in Cina), con concentrazioni produttive abnormi (1 milione di addetti alla Foxconn, sempre in Cina; mezzo milione nelle miniere sudafricane; diversi milioni di addetti alla catena Walmart, negli USA) cui corrispondono lotte operaie durissime e drammatiche, che solo un vizio eurocentrico potrebbe indurre a ignorare. A tutto questo fa da contraltare una sempre più forte concentrazione del capitale globale in pochi trust: Formenti descrive il versante che conosce più da vicino per le sue ricerche, quello della New Economy (con la banda dei quattro – Apple, Google, Amazon e Facebook – che, controllando il mercato digitale, controlla anche un flusso incredibile di informazioni e detiene quindi un enorme potere politico).
Ciononostante, il ruolo della rete nell’evoluzione e nelle pratiche dei movimenti (ad es. in nordafrica) non è sottovalutato dall’autore, anche se rischia di restare in parte offuscato dal suo principale obiettivo polemico, che è l’irrealismo proprio tanto dei media mainstream quanto di alcuni “teorici” dei movimenti a questo riguardo. Per Formenti appare necessario bilanciare i peana dei profeti della liberazione digitale, o per mezzo del digitale (schiera a cui anche lui un tempo appartenne), evidenziando in primo luogo la “sottovalutazione del potere di sovradeterminazione del codice informatico sulla creatività e sull’autonomia dei linguaggi, delle pratiche e dei comportamenti”. Un elemento che, si badi, travalica la questione della proprietà intellettuale ed ha a che fare con l’essere macchina (lavoro morto e oggettivato, quindi capitale) non soltanto dell’hardware, ma degli stessi software, ivi compresi quelli che rendono possibili le piattaforme 2.0. Proprio tali piattaforme, d’altra parte, permettono la cattura gratuita di un immenso quantitativo di forza lavoro intellettuale da parte del capitale, grazie alla sottrazione coatta di dati forniti in ogni istante da miliardi di utenti della rete, che creano uno scenario dove l’identificazione di lavoro (non formalizzato, né retribuito, né ideologicamente riconosciuto) e consumo è realizzata ai massimi livelli, ciò che costituisce forse il più grande furto di intelligenza e creatività della storia umana.
Sebbene gli argomenti di Formenti costituiscano sul punto un necessario, e ormai reiterato, bilanciamento delle strida inascoltabili di chi si ostina a coltivare una concezione progressista della storia (sempre, rigorosamente, sotto mentite spoglie), siamo convinti che la carica di ambivalenza politica del web (così come è configurato dal capitale oggi, domani non possiamo sapere) sia maggiore di quella prospettata dall’autore, e su questo torneremo in seguito. Vogliamo però già far notare, come mero spunto per il dibattito, che il “taylorismo digitale” di cui egli parla a questo proposito senz’altro esiste (capacità di tracciatura e controllo e parziale misurazione organizzativa, da parte del capitale, dei comportamenti sul web di addetti e prosumer), ma tale capacità è incomparabile, sul piano epistemico, con quella del taylorismo classico. Non si tratta di una minore potenza epistemica del capitale, che è invece aumentata enormemente, ma di un ancor maggiore aumento della complessità del quid che il capitale si trova dover conoscere, misurare, organizzare.
In altre parole, per quanto ci si applichi nel tentativo di dare un’organizzazione “formale” e tayloristica alla sussunzione reale dei desideri, dei sogni, degli incubi, delle perversioni e delle insicurezze della popolazione mondiale, questo oceano psichico “oggettivato” on line resterà sempre irriducibile a una misura; resterà sempre clamorosamente eccedente quella capacità di controllo. Per questo il mare magnum che fa da sfondo al taylorismo 2.0 ci sembra un argomento in favore, e non contro, l’ipotesi del crollo della legge del valore (contrariamente a quanto sostiene Formenti).
Composizione di classe
Nell’affermare il proprio “congedo” dalla “tradizione operaista”, l’autore afferma di voler conservare il riferimento, che in quell’esperienza è maturato, al concetto di composizione di classe, e soprattutto alla distinzione tra composizione tecnica e composizione politica (della classe, di un movimento, di un agglomerato sociale). Eppure, in quasi tutti i luoghi in cui Formenti descrive il lavoro autonomo di seconda generazione (freelance, knowledge workers, promotori di startup, ecc.) contesta il ruolo preminente ad essi assegnato da alcuni autori sulla base della scarsa “coscienza di classe” che questi soggetti mostrano in molti dei loro comportamenti concreti: ma non si corre così il rischio, paradossale, di un’indebita sovrapposizione proprio tra composizione tecnica (ruolo del soggetto nell’ingranaggio produttivo) e composizione politica (posizione di accettazione o rifiuto, con tutti i gradi intermedi, nei confronti di tale ingranaggio)? I comportamenti più o meno conflittuali, passivi o reazionari dei soggetti non sono l’unico elemento decisivo quando si tratta della loro collocazione di classe, e ciò dovrebbe essere tanto più dirimente là dove si rivendica (è il caso di Formenti) una concezione “oggettivistica” delle classi sociali.
In ogni caso, proprio dopo aver affermato di essere acerrimo nemico delle concezioni “costruttiviste” della classe intesa come fenomeno linguistico-narrativo, Formenti afferma che essa è “una comunità di destino” che determina la qualità concreta della vita in termini di “reddito” e “chance di mobilità sociale”. Più avanti, citando E.P. Thompson, afferma che la classe si identifica con ciò che più individui “sentono ed esprimono” circa l’appartenenza a un destino sociale comune e sostiene che l’appartenenza ad essa è determinata “in gran parte dai rapporti di produzione”. Se l’appartenenza a una classe viene collocata sul terreno del reddito, però, e quindi della disponibilità economica, il discorso rischia di divenire pauperistico (ciò che è del tutto legittimo, ma si disegna allora uno scenario dove il conflitto sembra contrapporre ricchi e poveri, anziché due classi); mentre ci preme ricordare, ancora, che dove fanno capolino elementi quali il “sentimento” o “l’espressione” di un senso di appartenenza è ancora la rappresentazione soggettiva a rivendicare il suo ruolo nella connotazione duale del confine di classe, che può darsi oggettivamente nella pura economia, ma acquisisce politicità sul piano della scelta e dello scontro.
Conflitto di classe
Tanto la nostra insistenza politica, nel modesto contributo alle discussioni di movimento, sulla centralità dell’elemento soggettivo, quanto le modalità della nostra azione concreta (tacciata addirittura, da qualcuno, di spontaneismo se non di “populismo”) ci conducono sovente a interrogarci sull’intersecazione continua dei due differenti livelli – tecnico e politico – nella concretezza delle lotte in cui riusciamo a immergerci, sempre preservando la volontà di leggere i due tipi di composizione sociale mantenendoli distinti, evitando quel tipo di sovrapposizione (in un verso o nell’altro) che produce proprio il determinismo che tanto a noi quanto a Formenti non piace; anche e soprattutto perché esso inibisce proprio l’urgenza (oltre che il piacere) di produrre soggettività e conflitto. In altre parole, occupare una posizione determinata nel ciclo produttivo può certo favorire il rifiuto, ed anche forme di rifiuto particolarmente nocive al capitale, ma – su questo concordiamo con l’autore – da qui a credere che quella semplice posizione crei avanguardie storiche ce ne corre.
Se il rapporto di produzione, e quindi la posizione nel ciclo produttivo, non determinano automaticamente comportamenti antagonistici, tuttavia, che cosa li determinerà? Qui, molto spesso – e ad ogni latitudine ideologica – prospera il continuo riciclaggio (ancora, spesso, sotto mentite spoglie) della nozione di coscienza, i cui retaggi moralistici (oltre che estremamente vaghi dal punto di vista epistemico) sono stati giustamente denunciati dai compagni che fecero inchiesta di fabbrica diversi decenni or sono, rompendo non soltanto con un partito che aveva da tempo smesso di prendere il giusto partito, ma con tutto un universo culturale che, attraverso il riferimento alla coscienza e alla “classe per sé” non ha mai smesso di barare centellinando, e più spesso negando, legittimazione alle forme concrete dell’insubordinazione di classe.
Noi, piuttosto che rivalutare una simile categoria, preferiamo scommettere sulla materialità imprevedibile e avventurosa del conflitto: l’avanzamento politico di questo o quel settore di classe (studenti-precari, precari non studenti, migranti, settori metropolitani e pezzi di territorio, operai di fabbrica, ecc.) è qualcosa che trascende i desideri o gli auspici di una soggettività organizzata, la quale non potrà che fomentare e indirizzare i conflitti che si producono, senza mitizzarne la spontaneità (né l’immanente radicalità) ma evitando al tempo stesso di snobbarli intellettualisticamente in nome del “vero” interesse di “classe” o della vera “coscienza”; come accadde a chi, all’esplosione del biennio rosso, sembrò ritenere che gli operai avrebbero dovuto leggere Il capitale prima di insorgere (Treves). La ricomposizione soggettiva, politica, non può che avvenire attraverso la lotta come portato di esperienza e, se indubbiamente la soggettività organizzata deve contribuire a rafforzare le lotte, non può certo crearle soggettivamente – né oggettivamente prevederle.
Paganesimo e ambivalenza
Di qui anche la nostra attitudine (da alcuni ritenuta “scandalosa”) ad approcci squisitamente pagani al conflitto sociale, dove non vediamo soggetti buoni o cattivi, ma soggettività più o meno in grado di destabilizzare la pace e l’ordine sociale di un dato periodo e in un dato contesto, provocando, possibilmente, una tendenza alla riproduzione di comportamenti conflittuali. Questo piace molto quando si ha a che fare con la “bella soggettività” di studenti e migranti, molto meno quando emergono soggetti giovanili meno scolarizzati, periferici e maleducati, o adulti legati al lavoro formalmente autonomo di prima, anziché di seconda, generazione: e ci si dimentica che questa “brutta soggettività” è precisamente lo sterminato spazio che ci contendiamo con il recupero capitalistico (anche fascista) delle istanze di rabbia sociale, e di striature di classe che sempre con la vendita dei propri tempi e spazi al capitale devono confrontarsi. Il movimento No Tav è “bello” quasi per tutti, d’altra parte, ma è anche (sebbene non solo) il prodotto di un lavoro sotterraneo, come non manca di ricordare Formenti, che nessuna anima bella, ve lo assicuriamo, ha mai voluto compiere (e infatti, anche in valle, per lunghi periodi di “anime belle” non c’è stata traccia).
Ciò su cui insistiamo costantemente, non a caso, è il carattere ambivalente dei comportamenti sociali nell’era capitalista. Il capitale non è un’entità divina; non è un ente matematico; non è la classe proprietaria che lo detiene: il capitale è un rapporto sociale. Questa relazione produttiva è attraversata da tensioni cui soltanto l’intervento soggettivo può suggerire una direzione e un segno e, se c’è una cosa che la storia delle lotte insegna, è che si tratta di una sfida a doppio taglio, perché al desiderio di trasformazione di chi si ribella corrisponde sempre lo sforzo di innovazione di chi è pronto a utilizzare il suo rifiuto a mo’ di utile suggerimento per un ulteriore potenziamento della relazione stessa – prima e anche dopo un’eventuale rovesciamento del potere costituito. In questo senso non possiamo condividere la narrazione di Formenti delle ristrutturazioni capitalistiche degli anni Ottanta e Novanta, da lui viste come puro disegno politico della parte capitalistica: esse furono una risposta al rifiuto del lavoro taylorista in occidente e dello stesso modello lavorativo, aggravato dall’assenza di un accesso fordista al consumo, in oriente; e quel rifiuto, se non ottenne il cielo, provocò lo spostamento del conflitto su un terreno nuovo, quello attuale, che è perciò prodotto tanto del conflitto quanto dell’innovazione; un terreno che, naturalmente, non possiamo né rifiutare né scegliere; è il terreno materiale in cui ci troviamo ad operare.
Ambivalenza e decisione
Il gesto dei coloni americani che si gettarono alla conquista del West (producendo devastazioni e massacri) per fuggire dal lavoro di fabbrica dell’East Coast (esempio tratto proprio da Utopie letali) mostra il carattere da sempre e per sempre ambivalente dei comportamenti di liberazione, carattere che nessuna argomentazione etica potrà mai esorcizzare. Che cosa significa questo? Che dobbiamo lasciare per sempre inevasa la questione cui infine, forse, alludeva Virno nel 1989 quando parlava di “questione del potere” – quella riguardante la vittoria? Tutto il contrario: il potere (che in origine, e in effetti anche negli esiti, resta comunque un verbo) è a sua volta qualcosa di radicalmente ambivalente perché, come le armi, cambia segno sociale a seconda di chi lo impugna; e pazienza se sarà impossibile convincerne chi crede che, in ultima analisi, la libertà di fare o non fare qualcosa e il potere di fare o non fare qualcosa siano distinguibili avvolgendosi in una bandiera della pace o vergando una “a” cerchiata su un muro: vedere le ambivalenza sociali significa vedere sempre la possibilità di un esercizio diverso della libertà/potere, ossia proprio non rinunciare ai presupposti possibili che una transizione rivoluzionaria dovrà comunque avere.
È questa nostra, ossessiva, ricerca delle ambivalenze, come probabilmente ritiene Formenti, paralizzante? Noi non crediamo. Paralizzante è una certa concezione della dialettica e della storia: quella della dialettica come processo (che conduce al determinismo) e quella della storia come progresso (che conduce al liberalismo di ritorno). Eppure, ci si dirà, per Hegel la dialettica era un processo, ed anche per Marx, così come per Engels era un progresso la storia. Bene: a noi non interessa. Noi procediamo per fallimenti e prove, come tutti i compagni in tutte le epoche; non abbiamo che la nostra convinzione come arma: le rivoluzioni e i movimenti hanno pagato abbastanza a lungo il loro pegno alle insistenze palesi o mascherate del pensiero dialettico, determinista, progressista, moralista. L’ossessione per l’ambivalenza e per l’ambiguità del reale ci mette al riparo da tutto questo, ed è quindi per noi preziosa.
Ogni sorgente di rabbia sociale nelle nostre metropoli, che emerga come fattore anche primitivo o ideologico, ma ricompositivo, avrà per noi un’ambivalenza; ogni resistenza globale all’imposizione di progetti o rapporti di forza favorevoli al capitale, avrà un’ambivalenza; ogni espressione del desiderio frustrato o sublimato, anche quando orientata al brand commerciale, spettacolare, musicale, sportivo o digitale, avrà un’ambivalenza, perché porterà sempre con sé un’eccedenza. La cooperazione produttiva caratteristica del processo di sussunzione formale, dove il lavoro estratto è valorizzato come scienza, possiede davvero, per noi – infine – la carica di ambivalenza più estrema; perché nel prostituire e sottomettere ciò che di più intimo esiste nell’essere umano (le passioni e l’intelligenza) introduce il nostro cavallo di troia ai livelli più alti della gestione del ciclo produttivo. Cosa e come accadrà, in seguito a ciò, non possiamo sapere; ma il fatto che qualcuno venda libri dove scrive di saperlo, per noi non cancella ciò che vediamo progredire di fronte a noi come una grande, palese potenzialità, sia pur “soltanto” oggettiva.
L’ambivalenza, crediamo, è d’altra parte tutt’uno con la contraddizione: proprio la compresenza di possibilità antitetiche nello stesso campo, nello stesso tempo, nello stesso fenomeno, esprime la contraddizione; soltanto non vogliamo leggere la contraddizione a partire dalla preveggenza del suo esito, o dalla preveggenza di un esito complessivo, di sistema; né ci sembra possibile – per una serie molto ampia di ragioni storiche, politiche, di memoria – poter rinvenire una razionalità immanente allo svilupparsi delle innumerevoli contraddizioni del nostro o di qualsiasi tempo. Del resto, a scongiurare la melassa contemplativa che potrebbe risultare, quale esito a dir poco ironico, da tutto questo – e per non pochi accade – resta, proprio per chi sceglie di farsi soggettività rivoluzionaria, il privilegio del ricorso all’elemento al tempo stesso più prosaico, più politico e maggiormente qualificante per tutto ciò che siamo andati dicendo, anche attorno al problema del potere e della transizione: quello della decisione.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.