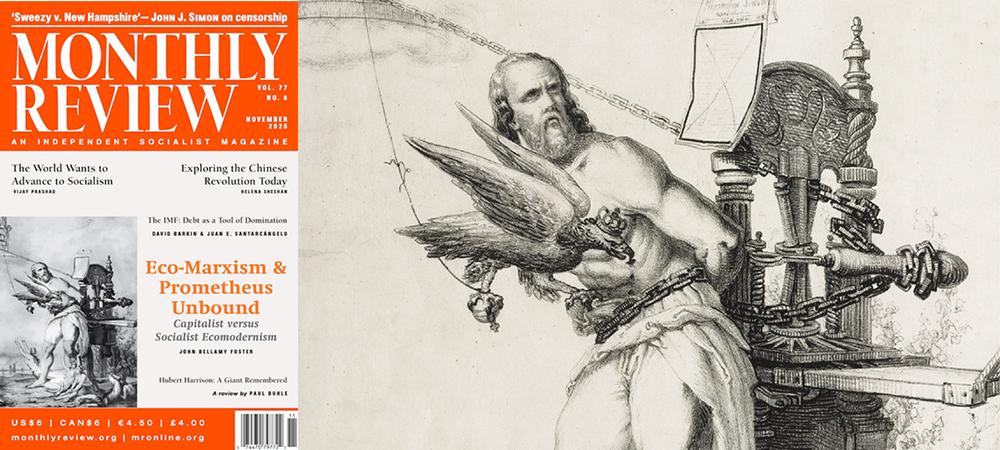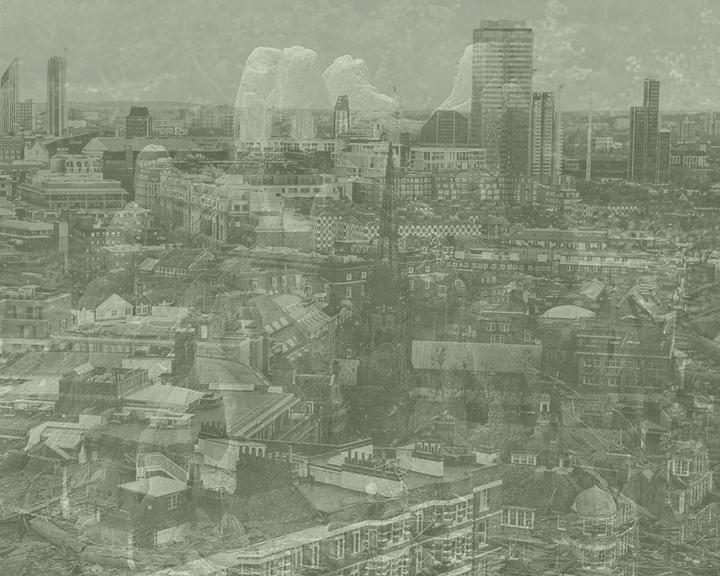
Dove siamo? Tra disordine e responsabilità – Parte 1
Continua irresistibile il degradarsi dell’ordine globale antecedente e si manifestano attori, burattini e teatranti della tempesta che viene. Non abbiamo ancora visto niente, ma è la storia che si è rimessa in moto e questa è gravida di possibilità, nei brevi termini non per forza di buone notizie. Alcune riflessioni per puntate in vista dell’anno che viene.
Le faglie aperte
I movimenti tellurici si fanno sempre più rabbiosi. Sono diverse le faglie aperte nell’ordine capitalista. Sono contraddizioni tutte interne a quest’ordine che si moltiplicano esponenzialmente, si influenzano a vicenda e generano complessità. E’ il capitalismo a generare le sue crisi.
Non si tratta di fare una classifica tra i livelli di realtà di questa complessità, si tratta piuttosto di individuarne i movimenti. Tra alto e basso, tra orizzontale e verticale, una spirale di intrecci dove una nave cargo in avaria può provocare danni al commercio internazionale e l’incontro quasi casuale tra un umano ed un pipistrello può provocare milioni di morti. Questi esempi testimoniano allo stesso tempo la fragilità e la tenuta del modello di sviluppo capitalistico, la sua debolezza e la sua persistenza. Viviamo nel paradosso per cui più sembra avvicinarsi il crepuscolo più si fanno forti alle nostre latitudini le forme di assoggettamento esplicite ed implicite, rozze e raffinate. E’ un paradosso solo apparente, un cane ferito morde più forte. Questa specifica fase storica del capitalismo ad egemonia statunitense traballa, ma ci sono le condizioni, le ridotte strategiche, le risorse, la capacità di fare la guerra perché duri ancora per lungo tempo: servono a poco i confronti e le date, ma il tardo impero romano ci impiegò duecento anni a disfarsi del tutto e noi stiamo ancora misurando i gradi di febbre del sistema.
Molto dipenderà dagli sviluppi del quadro oggettivo, ma anche dalla possibilità che in questo quadro emergano forze in grado di muoversi all’interno di questa complessità ed indirizzarne le traiettorie. D’altronde proprio come il magma che fuoriesce dalle faglie aperte disegna un nuovo volto al pianeta, così la fucina della trasformazione ribolle in basso, quali assetti sociali traccerà?
Proviamo ad esplorare alcune di queste faglie.
L’umano fuori dalla natura
Uno dei grandi processi storici di alienazione che il capitalismo ed il suo complesso ideologico sono riusciti a portare a termine è quello di una illusoria separazione tra umano e natura. Qualcosa che in nuce era già presente nella Bibbia, il paradiso non era altro che uno scenario naturale di cui l’umano poteva disporre liberamente, salvo per alcuni limiti e prescrizioni ovviamente ignorati. In seguito al peccato originale la natura diventa terribile e la divinità costringe l’umano alla fatica per sopravvivere. Il giardino dell’Eden è una delle tante versioni dell’Età dell’Oro presenti in molte tradizioni antiche a cui gli autori danno di volta in volta un significato morale leggermente diverso.
Il topos dello scontro tra uomo e natura si intensifica con l’emergere delle grandi narrazioni imperialiste e capitaliste, dove l’eroe domina con le sue capacità la sfera naturale che comprende anche quel pezzo di umanità considerata non civilizzata e dunque appunto “naturale”. La separazione si fa sempre più netta e il regno dell’umano ed il regno della natura vengono immaginate come due sfere antitetiche. L’umano è il prodigio, l’eccezione ed il suo obbiettivo diviene percorrere al contrario la strada verso l’Eden, cioè addomesticare ai propri scopi la natura. L’intera scienza ottocentesca, teorica ed applicata, porta con sé questa idea.
L’alienazione dalla natura non è però solo ideologica, ma fisica. Centinaia di milioni di contadini che hanno vissuto per millenni a contatto e dipendendo dai cicli naturali in un tempo relativamente breve hanno riempito le periferie delle città industriali e continuano a farlo. In un tempo ancora più breve, almeno in Occidente, l’epoca delle industrie di grande scala si è estinta, lasciando dietro di sé veleni e macerie, ma anche una profonda alienazione nei confronti dell’ecosistema in cui si vive.
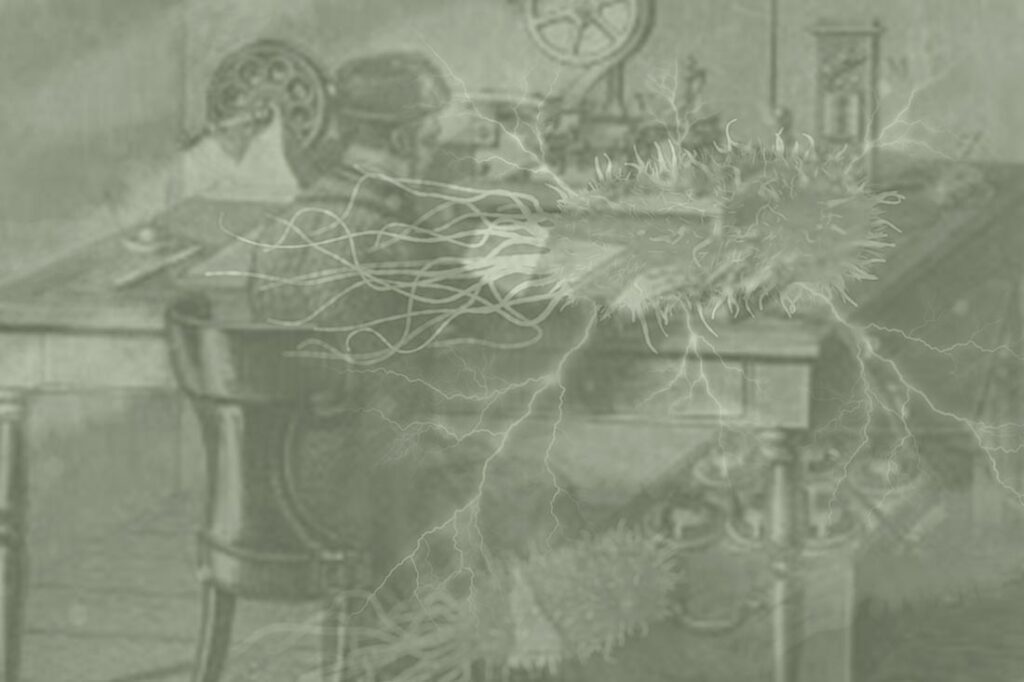
Oggi ci troviamo di fronte ad una crisi climatica senza precedenti nella storia dell’umanità generata dalla particolare organizzazione sociale in cui viviamo. Inverni straordinariamente caldi e siccitosi, bombe d’acqua, incendi devastanti, frane ed alluvioni: un intero corredo di fenomeni climatici anomali che destano preoccupazione in molti, ma per motivi diversi. L’impatto della crisi climatica è sensibile sull’economia globale ed anche su quella del nostro paese. Se ci si concentra sul settore agricolo secondo i dati di Coldiretti, i danni all’agricoltura italiana nel 2023 supereranno i 6 miliardi del 2022, dal momento che quelli provocati dall’alluvione in Emilia-Romagna, da soli, ammontano a oltre 1 miliardo. Inoltre, si registra un calo di produzione di grano, pari al -10%, ma soprattutto di miele, -70% rispetto al 2022. Si tenga conto che nel 2022 il valore aggiunto dell’agroalimentare italiano è stato pari a 64 miliardi di euro: 37,4 miliardi il settore agricolo e 26,7 miliardi l’industria alimentare. Dunque in un solo anno si sono registrati danni per circa il 10% del valore aggiunto complessivo del settore. Chi ha conoscenza di come funziona il lavoro agricolo nel nostro paese sa bene che con i prezzi bassi all’ingrosso dei prodotti ed il costo delle manutenzioni straordinarie in caso di eventi estremi o della riconversione della coltura e degli strumenti per via del clima, prima che le aziende tornino a produrre a pieno regime ci vorrà molto tempo, sempre che non scelgano di chiudere. Dunque gli effetti di un singolo anno si trascineranno cumulandosi a quelli degli anni successivi.
Secondo uno studio dell’università del Delaware solamente nel 2022 la perdita in termini di prodotto interno lordo (ponderata in funzione della popolazione) a causa dei cambiamenti climatici è stata stimata al 6,3% a livello globale. I ricercatori americani hanno anche evidenziato come in molti casi i danni provocati dagli impatti dei cambiamenti climatici siano strutturali. In termini di perdite di infrastrutture, di relazioni commerciali, di catene di approvvigionamento. E praticamente tutti i settori sono coinvolti: dall’agricoltura, all’energia, alla produzione industriale. Anche calcolando la percentuale non ponderata di mancato guadagno del Pil siamo già ad un -1,8%. Il che significa perdere ogni anno 1.500 miliardi di dollari.
Oltre a queste perdite andrebbero conteggiate sul lungo quelle determinate dalla ridefinizione degli ecosistemi, con le migrazioni di umani, flora e fauna e le potenziali pandemie.
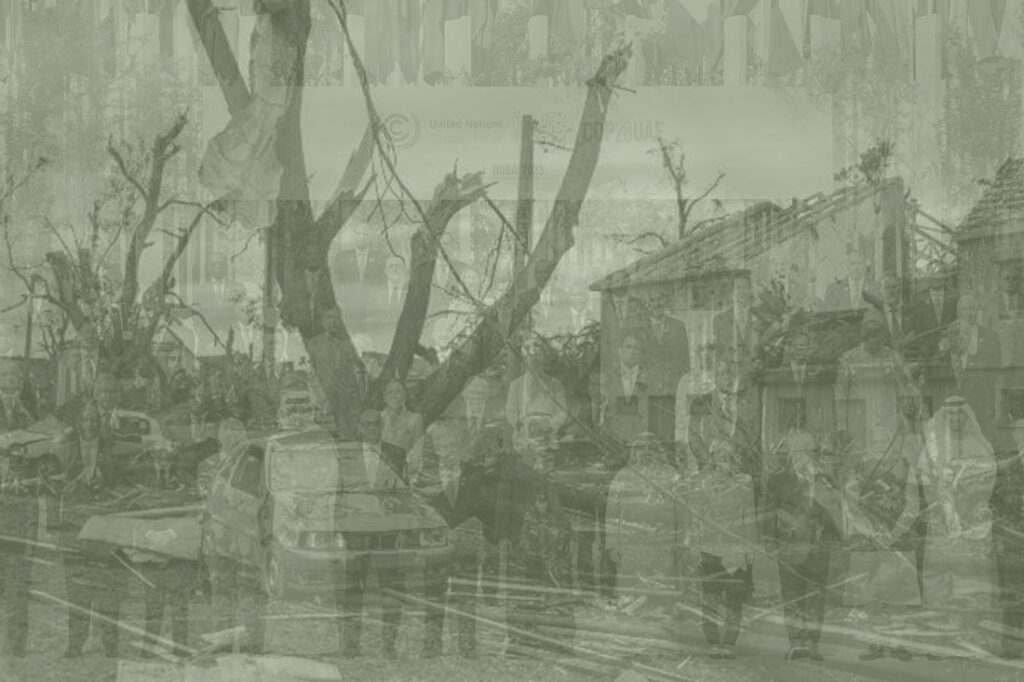
Il dilemma del capitale si è materializzato chiaramente nella ridicola Cop 28 di Dubai: accettare i costi economici ancor prima che sociali di questa crisi e del suo approfondirsi per mantenere il paradigma produttivo esistente basato sulle fonti fossili o ridefinire almeno parzialmente il modello di sviluppo inserendo loro malgrado la variabile ecosistemica? La risposta che si sono dati a Dubai e piuttosto chiara: se ne riparla più in là.
Se il capitalismo come sistema di sviluppo non sa dare risposte a questa crisi i movimenti dal basso, almeno in Occidente, non sembrano essere in grado di visualizzare la vera sfida: cioè quella del potere e di cosa farci. Una parte del movimento climatico ha interiorizzato la separatezza tra umano e natura in una forma paradossale. Se per il capitale la natura è vista solo come qualcosa da addomesticare e trasformare in merce, per certi ecologisti è un Eden da lasciare incontaminato e gli umani sono alla stregua di parassiti. La natura non a caso viene immaginata in entrambi i casi come uno spazio ancestrale, arcaico,“naturale” in questa accezione. Questa visione dell’ecologia è altrettanto falsificata: l’umano è parte dell’ecosistema e qualsiasi azione che compie è co-agita con esso in forma cooperativa o conflittuale che sia.
O si fa rientrare l’umano all’interno dell’equazione naturale o i movimenti climatici saranno destinati all’inefficacia. La scienza ottocentesca, a partire dalla teoria dell’evoluzione è un’immagine della separatezza, ogni specie si evolve al suo interno nello scambio di geni. Molti biologi però stanno superando questa concezione parlando di evoluzione collaborativa, cioè di più specie, più fattori ecosistemici che concorrono all’evoluzione ed alla trasformazione complessiva dell’ecosistema. Un esempio lampante è quello del nostro corpo dove 30mila miliardi di cellule convivono con 39mila miliardi di batteri. Siamo più batteri che carne e senza un’evoluzione condivisa chissà cosa accadrebbe.

Un altro esempio utile per quanto stiamo dicendo è quello di alcune specie di formiche che allevano afidi sulle piante del nostro giardino. Questo stretto rapporto, noto con il nome di simbiosi mutualistica e trofica, consiste in una specie di scambio di prestazioni. Mutualistica perché entrambi i gruppi ne traggono vantaggio e trofica perché riguarda la nutrizione. Gli afidi si nutrono di linfa che succhiano dalle parti giovani e in accrescimento delle piante e, avendo un apparato digerente particolare (in grado di espellere l’eccesso di acqua e altre sostanze assunte con l’alimentazione), i loro escrementi sono piuttosto ricchi di zuccheri e non solo: contengono infatti anche altre sostanze nutritive come aminoacidi, proteine, vitamine e sali minerali e vengono emessi sotto forma di liquido leggermente vischioso, denominato “melata”. Le formiche si nutrono di questa melata ed in cambio difendono gli afidi dai predatori. Alcune specie di formiche, inoltre, sono in grado di costruire dei manicotti di terriccio attorno allo stelo delle piante in cui gli afidi possono vivere ben protetti anche dagli agenti atmosferici, come succede nel caso della formica Lasius niger, oppure tengono al sicuro durante i periodi invernali particolarmente rigidi le uova degli afidi all’interno del formicaio. Nella notte dei tempi, le formiche erano predatrici e gli afidi, apparsi sulla Terra molto prima delle formiche, non avevano nessun rapporto con esse. Il loro incontro non deve essere stato idilliaco fin da subito, ma con il passare del tempo l’evoluzione ha fatto sì che negli afidi (per lo meno nelle specie che vivono in simbiosi con le formiche) si involvessero delle strutture adatte a secernere delle sostanze di difesa, e le formiche dal canto loro non predassero più gli afidi ma scoprissero la possibilità di nutrirsi della loro melata. In entrambi i gruppi quindi, la convivenza ha portato a modificazioni fisiologiche, morfologiche e comportamentali.
Ora possiamo pensare che umani, pecore, maiali e pomodori, zucchine e fagioli si siano evoluti insieme attraverso un rapporto mutualistico? Molti di questi animali e piante lasciati a se stessi non sopravviverebbero perché la cooperazione interspecie ne ha mutato le caratteristiche e probabilmente si potrebbe dire che ha mutato anche le nostre. L’equilibrio mutualistico interspecie però è stato interrotto dal sorgere del modo di produzione agroindustriale, dall’idea della natura merce. Ben lungi da noi rimpiangere la civiltà contadina, ma queste considerazioni ci servono per sottolineare che è necessaria una visione totale dell’ecologia. Non sono le attività umane di per sé, come l’allevamento e l’agricoltura, ad essere nocive, ma le particolari forme che hanno assunto in termini storici.
A questo punto una “piccola” provocazione: possono i cacciatori avere una funzione ecosistemica? Se si rivolge lo sguardo ai popoli indigeni questa funzione (ed il rispetto per la vita dell’altro animale) è abbastanza chiara. Se si fanno i conti con gli squilibri ecosistemici provocati in alcune aree del paese a causa dell’invasione dei cinghiali (anche qui vi è il cambiamento climatico tra i possibili motivi del fenomeno, insieme all’abbandono delle aree montane e boschive) è una domanda da porsi e valutare. Dunque il problema non è l’attività in sé, ma le caratteristiche storiche che ha assunto: come predazione della natura, come accumulazione di profitto legale od illegale (bracconaggio), come attività ricreativa separata. Eppure in molti cacciatori convivono queste tensioni ed allo stesso tempo un rispetto ed una cura degli ambienti naturali (o anche solo una conoscenza a volte maggiore di chi tratta questi temi nelle sfere cittadine) che è una contraddizione, un paradosso, possibilità di discussione.
Avere presente la necessità di colmare questo vuoto teorico e pratico, la necessità di ricollocarci entro un quadro più ampio è necessario per due semplici motivi: individuare chi sono i nostri alleati umani e non umani e quali contraddizioni vivono, quali complessità ed insofferenze. Si tratta di avere una idea materialistica dei rapporti ecosistemici. Spesso la mancanza di una prospettiva di alterità credibile e concreta, di una proposta politica e di un programma di trasformazione fa in modo che la reazione abbia campo libero in luoghi, tempi e soggetti che paradossalmente sono quelli che pagheranno e stanno già pagando il costo più alto a causa del cambiamento climatico. In secondo luogo la credibilità di una proposta dipende dalla sua concretezza: siamo in grado di immaginarci progetti di cooperazione mutualistica interspecie che siano preferibili alle macerie ed alla polvere che coprono le lande dell’espropriazione capitalistica? Probabilmente adesso no, ma dobbiamo comprendere come costruirli ed insieme a chi e attraverso la cooperazione ed il conflitto spingere verso una transizione reale e giusta.
In fin dei conti le combinazioni di una cooperazione mutualistica sono infinitamente maggiori di quelle che permette un sistema di sviluppo che ha come regola aurea la massimizzazione del profitto. E questa è un’interessante possibilità.
Continua nelle prossime puntate…
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.
CRISI CLIMATICAdisordine globaleDove siamo?ECOLOGIAglobalizzazione