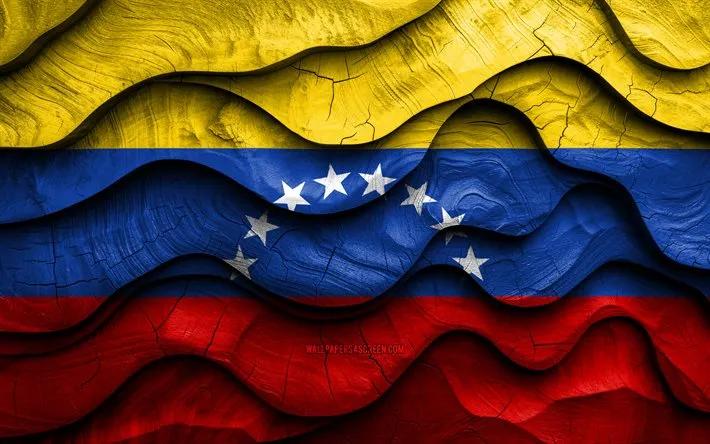Trump all’attacco dell’America Latina con la scusa della “guerra alla droga”
La tensione nei Caraibi ed in America Latina si fa sempre più alta. Alcune note per comprendere quanto sta succedendo.
I media europei stanno trattando solo marginalmente quanto sta accadendo in America Latina. Dall’Argentina, al Venezuela, alla Colombia gli Stati Uniti stanno mettendo in campo una Grand Strategy per riprendere il controllo su quello che considerano, secondo la dottrina Monroe, il loro “cortile di casa”. Gli scopi sono molteplici: mettere le mani sui giacimenti di petrolio e minerali critici di cui sono ricche alcune aree del continente, contrastare la crescente influenza economica cinese e chiudere i conti con il ciclo del “Socialismo del XXI secolo”.
Partiamo dall’inizio. Fin dal suo primo mandato Trump ha chiarito che la strategia della sua amministrazione nei confronti dei Caraibi e dell’America Latina si sarebbe inserita nel solco della cosiddetta dottrina Monroe, cioè fondamentalmente il ritorno ad un approccio imperialista nei confronti del continente. Tra la fine degli anni ’90 e l’inizio dei 2000 questa dottrina era stata rivisitata: sebbene le mire sull’America del Sud rimanessero intatte, l’approccio messo in campo dalle amministrazioni USA in questo periodo era fondato sull’utilizzo del Soft Power e sull’integrazione del paesi latinoamericani all’interno dei circuiti della globalizzazione. Con la salita al potere di Trump nel 2016 questo cambiamento di approccio si interrompe: i flebili tentativi di Obama di riprendere le relazioni diplomatiche con Cuba attraverso l’alleggerimento dell’embargo vengono immediatamente interrotti. Nel 2018 Bolsonaro vince le elezioni in Brasile e diventa il riferimento politico del trumpismo in Sud America. Ma nel suo primo mandato, la strategia del presidente USA è stata confusionaria ed incerta come in molti altri campi. L’amministrazione Biden da questo punto di vista non ha mostrato alcuna discontinuità. Oggi la situazione è ben diversa: Trump è tornato al potere con un programma preciso ed articolato sia in politica estera che interna.
Nel frattempo l’importanza dell’America Latina dal punto di vista economico-politico è cresciuta.
Nuovi e “vecchi” estrattivismi
Come è risaputo in Venezuela vi è la più grande riserva di petrolio a livello globale. L’industria petrolifera venezuelana, la PDVSA, è nazionalizzata nella seconda metà degli anni ’70 con l’obiettivo di evitare lo sfruttamento dei giacimenti da parte delle multinazionali straniere, ed in particolare quelle statunitensi, leaders del mercato.
Dal 2017 le sanzioni statunitensi hanno tagliato fuori PDVSA dal sistema finanziario internazionale rendendo impossibile vendere liberamente il petrolio, sbloccare fondi, acquistare ricambi o tecnologia. Un assedio economico che ha fatto crollare la produzione: da oltre 3 milioni di barili al giorno negli anni ’90 a meno di 700.000 nei periodi più duri. L’obiettivo degli Stati Uniti era ben chiaro: costringere il governo venezuelano a far entrare i privati nell’estrazione del petrolio. Le conseguenze di tali misure, in un paese sostanzialmente dipendente dalle esportazioni di petrolio e già in crisi, sono facilmente immaginabili. I falchi venezuelani del libero mercato da tempo spingono nella direzione di un regime change “dall’alto” dopo che diversi tentativi di destituzione di Maduro non sono andati a buon fine.
Ma il Venezuela non è un territorio strategico solo per il petrolio, qui vi sono importanti giacimenti di coltan (uno dei materiali strategici per la costruzione delle batterie degli smartphone), di oro e di ferro.
María Corina Machado, leader dell’opposizione turbocapitalista e di estrema destra recentemente insignita del premio Nobel con un tempismo sospetto, sostiene che in caso di regime change il Venezuela potrebbe aprire agli “investimenti esteri” con il potenziale di generare “un trilione di dollari” di ricchezza in soli 15 anni. Le mire del capitale internazionale sul Venezuela riguardano anche le riserve di acqua dolce del Paese, i 30 milioni di ettari di “terra fertile non sviluppata” (circa la metà di questi terreni in realtà sono gestiti da organizzazioni contadine, in un paese in cui la produzione interna copre il 97% del fabbisogno alimentare) e i 2.800 chilometri di costa caraibica. Dunque Machado ha in mente un progetto di privatizzazioni che comprende l’acqua, già avvenuta in alcune regioni dell’America Latina, come il Cile dove alcune aree rurali sono andate incontro alla totale desertificazione a fronte dell’impianto di coltivazioni agroindustriali di avocado, un violento land grabbing nei confronti delle comunità contadine e la turistificazione delle coste venezuelane. Non sorprende l’identità di vedute tra Machado, Trump ed il regime sionista con il progetto, momentaneamente accantonato, della “riviera di Gaza”.
Ma la strategia trumpiana non riguarda solo il Venezuela, le mire degli USA si estendono a tutto il continente. Dopo il clamoroso salvataggio di Milei in Argentina, il cui progetto ultraliberista si stava andando a schiantare contro una crisi economica estrema e le accuse di corruzione, Trump può festeggiare la vittoria alle elezioni presidenziali di Rodrigo Paz in Bolivia. Qui la devastante parabola politica del MAS di Evo Morales, nonostante la resistenza popolare al golpe del 2020, ha condotto ad un ballottaggio tra il partito centrista di Rodrigo Paz e la destra di Jorge Tuto Quiroga. La Bolivia insieme a Cile ed Argentina fa parte del cosiddetto triangolo del litio, un metallo fondamentale per la tecnologia delle batterie dei veicoli elettrici e dei sistemi per l’accumulo di energia rinnovabile. Anche il Perù, in preda ad una crisi politica che non accenna a terminare dopo la destituzione di Dina Boluarte, vede una significativa presenza di litio.
Vi è poi il Brasile che è considerato il il secondo Paese al mondo con più riserve di terre rare, dietro solo alla Cina, con 21 milioni di tonnellate, la metà di Pechino (44 milioni) ma quattro volte l’Australia e oltre dieci volte gli Stati Uniti, che possiedono sul proprio territorio il 2% dei minerali critici del pianeta. I giacimenti brasiliani sono in larga parte inutilizzati: solo negli ultimi anni si è messa in moto la macchina dell’estrazione. Inoltre l’unica azienda che si occupa di questa industria, Serra Verde, per adesso ha venduto quasi esclusivamente alla Cina, anche per la mancanza di competenze tecniche e macchinari per processare il materiale. Non a caso il 7 agosto Trump ha imposto al Brasile di Lula dazi al 50%. La retorica del tycoon americano vuole che questi dazi così pesanti siano stati imposti in nome del suo sostegno a Jair Bolsonaro, ma è probabile dalle notizie che circolano in questi giorni che si sia trattato di una tattica per costringere il Brasile a negoziare con gli USA un accordo bilaterale sul modello di quelli stretti con altri paesi.
Infine nel mirino di Trump vi è il Presidente della Colombia Petro a cui l’amministrazione statunitense ha imposto recentemente dure sanzioni economiche. Anche la Colombia possiede giacimenti non indifferenti di terre rare, ma soprattutto Petro è il presidente dell’area che più di tutti si è schierato contro l’imperialismo statunitense, il genocidio sionista a Gaza e, oggi come oggi, a fronte di una crisi significativa delle sinistre nel continente rappresenta un punto di riferimento per molti.
A questa lunga lista andrebbero aggiunti la Groenlandia ed il Canada per cui sostanzialmente vale lo stesso principio secondo l’amministrazione trumpiana, come abbiamo spiegato qui.
Mettere alla porta la Cina
Trump l’ha detto chiaramente, l’aiuto profuso nei confronti del compare Milei è subordinato al fatto che l’Argentina smetta di avere rapporti economici significativi con la Cina. In effetti negli ultimi decenni le transazioni commerciali tra la Cina e molti paesi dell’America Latina si sono intensificate in diversi campi. In molti casi il paese asiatico è il principale partner commerciale.
Tra il 2002 ed il 2022 il commercio bilaterale tra Cina e Sud America è passato da 18 miliardi a 450. Le aziende cinesi hanno investito oltre 168 miliardi di dollari nella regione dal 2000, principalmente in Brasile, in settori come estrazione mineraria, agricoltura, telecomunicazioni ed energie rinnovabili. Anche per quanto riguarda lo sviluppo di infrastrutture strategiche gli investimenti sono stati importanti: lo scorso anno è stato inaugurato il porto di Chancay in Perù, costruito dai cinesi e gestito dal colosso logistico Cosco. Il porto riveste un’importanza strategica dato che è l’unico nella costiera sudoccidentale a poter ospitare navi container di nuova generazione, ma anche perché in prospettiva dovrebbe essere collegato alla Southern Intraoceanic Highway e alla ferrovia bioceanica, per il momento solo sulla carta, che dovrebbe collegare la costa atlantica del Brasile al porto di Chancay. Non si può poi dimenticare la disputa sul canale di Panama: lo snodo commerciale, tradizionalmente nella sfera di influenza degli Stati Uniti, negli ultimi anni ha visto un rafforzamento della presenza cinese. Trump fino dall’inizio del suo secondo mandato ha chiarito che il canale dovrà tornare sotto il controllo degli USA.
La Cina importa dall’America Latina materie prime quali le terre rare, ma anche la soia ed altri prodotti agricoli mentre esporta sul continente prodotti tecnologici ad alto valore aggiunto e veicoli. Quello latinoamericano è un mercato delle merci importante che si è progressivamente spostato dall’importazione di beni statunitensi a quelli cinesi.
Il rapporto con la Cina ha rappresentato un veicolo di sviluppo ed affrancamento dalla politica statunitense per il continente, ma ha istituito anche nuove dinamiche di dipendenza. Questo rapporto per gli Stati Uniti è intollerabile, sia dal punto di vista commerciale che da quello dell’appropriazione delle materie prime.
La balla della “war on drugs”
L’amministrazione Trump giustifica l’aumento della pressione militare nei confronti del Venezuela, ma più in generale dei paesi dell’area, con la retorica della “war on drugs”. Secondo gli USA vi sarebbe un complotto internazionale che coinvolgerebbe la Cina ed alcuni paesi del Sud America nell’epidemia di oppioidi che da anni sta sconvolgendo le metropoli statunitensi. In realtà la genesi del fenomeno è ben chiara a tutti gli studiosi, ed ha a che fare con l’avidità delle aziende farmaceutiche statunitensi, con il sistema medico privato e con la crisi sociale generalizzata.
In questo quadro si sono inseriti alcuni cartelli della droga messicani, che notando l’opportunità di una droga dai costi di produzione molto più bassi e con minori problemi logistici, hanno puntato fortemente su questo traffico. I cartelli comprano i precursori chimici sul dark web per poi produrre la droga in Messico ed esportarla negli Stati Uniti. Tra i produttori dei precursori vi sono aziende chimiche cinesi, concentrate per la maggior parte nelle province Hebei e Hubei. Il governo cinese ha ripetutamente imposto delle restrizioni al commercio di questi precursori su pressione delle amministrazioni statunitensi.
In questo quadro non vi è alcuna prova che i cinesi stiano intenzionalmente fornendo i precursori ai cartelli per provocare un allargamento dell’epidemia degli oppioidi e soprattutto non c’è nulla a sostegno dell’idea che i governi di Venezuela e Colombia, tra gli altri, siano coinvolti in questi traffici, o in quelli di altre sostanze verso gli Stati Uniti.
Anche la “war on drugs” non è un’idea nuova: è stata introdotta dal Presidente Nixon nel 1971 e portata avanti per decenni. Come è evidente la war on drugs non ha avuto alcun reale impatto sul traffico di droga negli Stati Uniti. Anzi, la crisi degli oppiodi ha molti tratti in comune con quelle precedenti del crack e dell’eroina, ma colpisce delle fette di popolazione molto più ampie. La “guerra alla droga” è stato per lo più un dispositivo neocoloniale di cui gli Stati Uniti si sono dotati per intervenire nella sovranità dei paesi latinoamericani. E’ ormai assodato dal punto di vista storico e raccontato persino in serie come Narcos che mentre il teatrino della war on drugs andava in scena la CIA collaborava con i cartelli del narcotraffico per fornire armi e fondi alle contras paramilitari impegnate nella repressione delle insurrezioni comuniste e socialiste in giro per l’America Latina.
Dunque è facile collocare la propaganda trumpiana a fianco di quelle sulla “guerra al terrore”, sulle “armi di distruzione di massa”, sull'”esportazione della democrazia” e tutto il resto del repertorio di balle atte a giustificare pubblicamente il perseguimento degli interessi imperiali statunitensi.
La situazione sul campo
Mentre alcuni politici repubblicani parlano apertamente di regime change e di operazioni militari della CIA in territorio venezuelano, diversi tentativi di trattativa da parte del governo di Maduro sono stati rifiutati. Pochi giorni fa è stata dispiegata nei Caraibi la portaerei Ford, la nave simbolo della potenza navale USA. Ieri una nave lanciamissili statunitense è arrivata a Trinidad e Tobago, il piccolo arcipelago situato a circa dieci chilometri dalle coste del Venezuela: la Uss Gravely, insieme a un’unità di marines, è in zona ufficialmente per esercitazioni con l’esercito di Trinidad.
Il 15 ottobre almeno due bombardieri B-52 della Louisiana avrebbero sorvolato per diverse ore la costa venezuelana nello spazio aereo internazionale, in quella che un alto funzionario americano – citato dalla testata – ha definito “una dimostrazione di forza”. Nel mese di agosto 2025 Washington ha schierato otto navi da guerra e un sottomarino nucleare al largo delle coste venezuelane, conducendo almeno cinque attacchi in mare contro imbarcazioni provenienti dal Venezuela. Il motivo ufficiale è la lotta al narcotraffico. Stessa cosa tra l’1 e il 19 settembre 2025, con altri quattro attacchi aerei in acque internazionali contro barche venezuelane.
Intanto il governo venezuelano ha disposto lo stato d’emergenza, sta fortificando il territorio in previsione di eventuali operazioni di terra statunitensi e sta organizzando la difesa del paese. Ad agosto migliaia di persone si sono radunate nel centro di Caracas e in altre città del Paese per arruolarsi nella Milizia Nacional Bolivariana, un ramo delle forze armate venezuelane fondato dall’ex presidente Hugo Chávez. Diverse organizzazioni popolari latinoamericane si stanno preparando all’invio di volontari civili per supportare la popolazione venezuelana in caso di guerra. L’inasprimento delle tensioni militari da parte degli Stati Uniti è stato duramente criticato dai governi della Colombia, del Messico e del Brasile.
Non è chiaro quale potrebbe essere lo scenario di un eventuale intervento americano, se si muoveranno sulla scorta di un tentativo di golpe interno al paese o se semplicemente decideranno di agire con un’invasione militare classica. Ciò che è certo è che lo schieramento di forze in campo va ben oltre la minaccia paventata.
Le sirene della confusione
Va detto chiaro, non nutriamo particolare simpatia per Maduro. Più in generale il modello del “Socialismo del XXI Secolo” teorizzato da Chavez, nonostante fosse portatore di elementi interessanti, sta mostrando tutti i suoi limiti.
L’economia basata su forme di estrattivismo statalizzato, la mancanza di reali istituzioni di autogoverno delle forze popolari, la tendenza all’accentramento del potere nell’uomo solo al comando hanno contribuito all’esaurimento di questo ciclo politico ben oltre il Venezuela. Ma non bisogna farsi affascinare dalle sirene del liberismo e della confusione.
Il Venezuela vive una condizione di crisi non solo per fattori interni, ma soprattutto per le politiche statunitensi atte a costringere il paese ad aprirsi al libero mercato ed ai capitali USA. L’embargo, i continui tentativi di destabilizzare i governi eletti hanno portato ad una precipitazione della situazione dal punto di vista economico e politico. Per lunghi anni lo stato latinoamericano, come molti altri della regione, è stato posto sotto assedio al fine di distruggere l’esperimento socialista.
E’ evidente a molti, compresa una buona parte della popolazione venezuelana che le condizioni di vita nel paese con la salita al potere della destra ultraliberista precipiterebbero ulteriormente, come hanno ampiamente dimostrato i precedenti storici. Non solo, l’imposizione del regime neocoloniale statunitense sottrarrebbe totalmente dal controllo popolare le risorse del paese.
Per adesso i media ed i politici europei glissano sulla manovra statunitense, troppo spregiudicata per essere propinata così com’è all’opinione pubblica. Ma se si arrivasse realmente allo scontro armato c’è da stare sicuri che il frame dell’esportazione della democrazia riempirebbe le pagine dei giornali e i discorsi dei nostri governanti. Non bisogna cadere nelle trappole di questa retorica. Anche se cogliamo tutti i limiti del governo di Maduro, il Venezuela va difeso senza distinzioni dall’aggressione imperialista statunitense, ben consapevoli che questa sarebbe solo l’inizio di una stagione di predazione sull’intera America Latina. Magari proprio nella difesa da questa aggressione possono nascere nuovi paradigmi più adeguati alle prospettive politiche del presente.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.
america latinabrasilecinacolombiaESTRATTIVISMOimperialismomaduronarco trafficoneocolonialismopetrolio