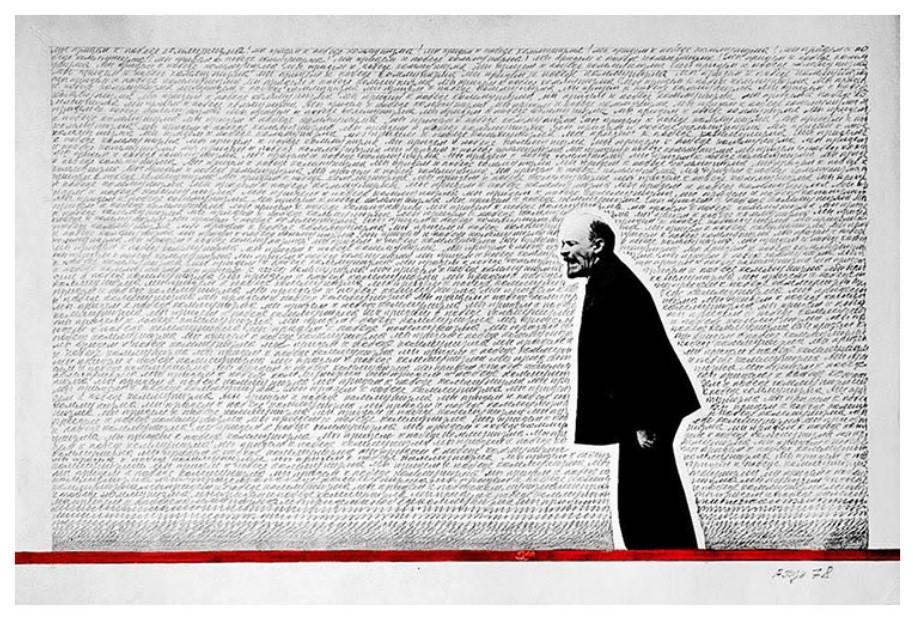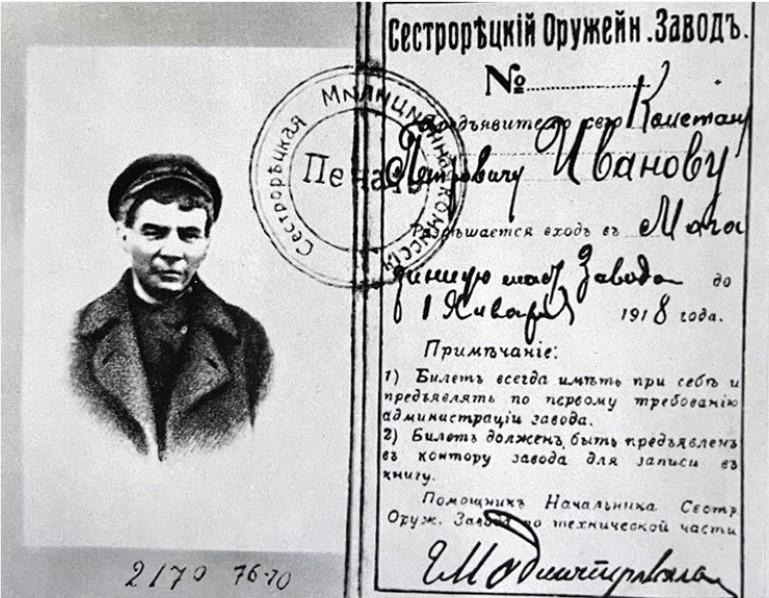Teoria del partito
Abbiamo tradotto questo importante articolo di Phil A. Neel apparso su Ill Will che tratta della teoria del partito.
Ci sembra che questo testo risuoni con alcuni dei problemi teorico-pratici che, su una scala certamente differente, si sono imposti nella riflessione militante dopo le incredibili settimane di piena del movimento “Blocchiamo Tutto”. Ora che la marea si è abbassata due sentimenti si sono fatti spazio tra le realtà politiche: da un lato il ritorno ad una certa disillusione dettata dall’andamento del movimento in relazione alla fase oggettiva imposta dalla “tregua” nella Striscia di Gaza, dall’altro una tensione a capitalizzare “politicamente” questo movimento. Avevamo avvertito che la traduzione e l’esondazione di questo fenomeno sociale su altri terreni non sarebbe stata né scontata, né facile, e che avrebbe richiesto una certa presa di responsabilità collettiva da parte delle realtà politiche. In questi giorni si sono moltiplicati generici appelli ad organizzarsi, appelli che condividiamo, ma ciò che non è chiaro è per quale scopo e con quale prospettiva. Per quanto ci riguarda abbiamo avanzato l’ipotesi che questo movimento sia un epifenomeno italiano dell’assemblaggio generale di un “nuovo” iper-proletariato dopo il lungo inverno neoliberale e che procedere con gli schemi organizzativi tipici della fase precedente è un lavoro inutile e dannoso. Utilizzando le parole di Phil A. Neel ci pare che ancora una volta ci si concentri sul tentativo di prendere “il comando” dei processi in corso, piuttosto che sullo sviluppo della “soggettività collettiva”, rischiando di rimanere ancora una volta con un pugno di mosche in mano. Ma non c’è da deprimersi, come sottolinea l’autore questi sono passaggi necessari e per certi versi inevitabili.
Tornando al testo ci pare un utile antidoto tanto ai “nuovismi ad ogni costo” quanto a chi vuole offrire la solita minestra riscaldata. La disamina analizza in primo luogo i problemi organizzativi che ci si pongono dopo la lunga eclissi del movimento comunista mondiale tra eredità nostalgiche e frammentarie, poi ritorna sull’utile distinzione tra “partito storico” e “partiti formali” e sulla dialettica tra questi due poli all’interno dei conflitti sociali. Infine sintetizza la nozione di partito comunista (eterno): questa è forse la parte più astratta e sfidante del testo in cui la dialettica tra il partito storico ed i partiti formali si sublima nella soggettività rivoluzionaria che comprende ed eccede entrambi dando vita alle comuni come “camera di gestazione della società comunista”. Questa ultima parte del testo è inevitabilmente un po’ più immaginifica ed a tratti rischia di ricalcare la concezione positivistica della storia tipica del canone marxista, ma ci costringe a pensare ai processi rivoluzionari non nei termini romantici del Partito (o dell’uomo addirittura in alcuni casi) che curva la Storia, ma in quelli di una “sovra-soggettività”, un “cervello sociale del progetto partigiano”.
Buona lettura!
I prezzi sono più alti. Le estati sono più calde. Il vento è più forte, i salari più bassi, e gli incendi divampano più facilmente. I tornado si aggirano come angeli vendicatori tra le città della pianura. Qualcosa è cambiato. Le piaghe bruciano nel sangue. Ogni due anni una grande inondazione scende, ornata di cadaveri come di gioielli, per rivoltare la terra di un’altra nazione punita.
Alle nostre spalle giace la grande pira carbonifera della storia umana. Davanti a noi, un’ombra che si affievolisce, proiettata dai nostri stessi corpi, intrappolata e in lotta nel vortice. Chiunque può sentire che qualcosa è terribilmente sbagliato — che un male si è insinuato fin dentro il suolo stesso della società — e tutti sanno che le potenze e le autorità di questo mondo ne sono la causa.
Eppure, tutti ci sentiamo impotenti nell’intraprendere qualsiasi forma di ritorsione. Come individui, non vediamo alcun modo di influenzare il corso degli eventi e dobbiamo semplicemente guardare mentre ci travolgono. Ci ritroviamo disarmati e soli, di fronte a un futuro oscuro in cui orrori tremanti si aggirano appena oltre il confine della nostra vista, trascinati inesorabilmente in avanti mentre le catene tintinnano e gli echi del tormento rimbalzano dal mondo a venire.
Ma, con gli occhi giusti, guardando nei luoghi giusti al momento giusto, si può forse scorgere l’ombra cupa del futuro fendersi in lampi di luce ultraterrena: momenti accecanti in cui la prospettiva della giustizia appare per un fugace istante. Il distretto di polizia brucia, gli operai escono in massa dalla fabbrica, i comitati si formano nelle strade e nei villaggi, il governo cade dolcemente come una piuma, tre bossoli cadono come dadi — un’incisione su ciascuno, come un incantesimo per evocare qualcosa di più grande.
Forse lo hai sentito. Il cuore si fa leggero. Un fuoco angelico attraversa la carne e, per quell’unico istante senza respiro, qualcosa di immortale ci abita.
La lama di una meteora taglia il ventre di un cielo senza luna — poi sbattiamo le palpebre ed è tutto finito: viene chiamata la Guardia Nazionale, i sindacati negoziano il ritorno al lavoro, i comitati si sciolgono, il presidente rovesciato è sostituito da un consiglio militare, l’amministratore delegato morto è rimpiazzato da uno vivo, e i proiettili della polizia cadono dalle torri di vetro come una pioggia fredda e dura.
Ma quella luce non può essere dimenticata.
Di conseguenza, proprio questa sconfitta è di per sé un risveglio. Ci rendiamo conto, lentamente, che il carattere collettivo ed esteso del male che ci affligge richiede una forma di risposta altrettanto collettiva ed estesa.
La vendetta sociale richiede un’arma sociale.
Il nome di quest’arma è il partito comunista.
Con l’aumentare del ritmo e dell’intensità del conflitto di classe, le questioni organizzative vengono poste con crescente frequenza. Esse emergono inizialmente come problemi immediati e funzionali, connessi a lotte specifiche e proporzionati alla loro scala.
All’indomani di ogni lotta, sorgono poi domande più ampie sull’organizzazione, assumendo sia una dimensione pratica sia teorica.
In termini pratici, la questione si concentra soprattutto sull’attività dei partigiani fedeli che si trovano privi di un immediato oggetto di fedeltà. Essi esprimono una soggettività residua, svuotata della sua forza di massa.
In termini più diretti, questi individui sono i “resti” di una certa alta marea del conflitto di classe.
A questo livello, la questione viene solitamente posta come il problema di cosa possa fare questo “noi” frammentato nell’intervallo tra le rivolte.
Di conseguenza, il processo di indagine è spesso appesantito da uno zelo frustrato: i dibattiti si mobilitano in circoli viziosi di recriminazione morale, mossi più da uno spirito di autopunizione che da un sincero interesse per l’analisi.
Ciononostante, la stessa linea di interrogazione si ramifica presto in una rete più ampia di domande relative alla “spontaneità”, al rapporto tra le tendenze strutturali (nell’occupazione, nella crescita, nella geopolitica, ecc.) e le probabili forme di organizzazione che verranno adottate dai proletari oltre questo strato residuo di partigiani — e, naturalmente, su come questi partigiani possano interagire con tali organizzazioni.
Da qui, l’indagine si elabora e si astrae nelle sue dimensioni teoriche, diventando una vera e propria “questione dell’organizzazione”.
Pur essendo inseparabilmente legata a teorie più ampie su come funziona la società capitalista e su quale forma dovrebbe assumere un mondo diverso, questa questione occupa una posizione intermedia: allo stesso tempo astratta (come teoria della rivoluzione) e congiunturale (come passo pratico necessario nella costruzione del potere rivoluzionario).
Presa da sola, ciascuna di queste dimensioni decade rapidamente: l’aspetto necessariamente astratto si trasforma in un determinismo meccanico, in cui un unico schema viene applicato a ogni caso (sia esso quello del “gruppo di affinità” o dell’“organizzazione di quadri”); mentre l’aspetto necessariamente congiunturale diventa una forma di inattività attivista, in cui il fermento stesso dell’attività locale di “organizzazione” (di solito una combinazione di advocacy tematica, servizi e lavoro mediatico) è esso stesso una forma di disorganizzazione che ostacola il progetto partigiano.
Unificare questi aspetti divergenti richiede forme di astrazione costruite a partire da — e materialmente legate a — momenti congiunturali di rivolta.
Qualsiasi discussione sull’organizzazione deve quindi avvenire o su una scala completamente localizzata — discutendo di come queste persone possano organizzarsi in questa situazione — oppure come raccolta generica e sincretica dei molteplici atti di organizzazione che già popolano il conflitto di classe, così come vissuto dai partecipanti, nel tentativo di comprenderne i limiti e affinare la nostra comprensione di cosa, esattamente, significhi “organizzazione”.
Qui, spero di collegare queste due funzioni, presentando un intervento teorico che operi a un livello relativamente alto di astrazione — informato tanto dallo studio attento quanto dall’esperienza diretta nelle ribellioni che hanno scosso il mondo negli ultimi quindici anni — inizialmente concepito come intervento locale volto ad affinare progetti organizzativi specifici nati da fratture sociali specifiche.
In altre parole, ciò che segue è una teoria del partito pensata per contribuire a catalizzare forme concrete di organizzazione partigiana.
Principi fondamentali
Mentre emergiamo lentamente dalla lunga eclissi del movimento comunista mondiale, ci troviamo in una situazione paradossale, ereditando al tempo stesso troppo e troppo poco. Da un lato, ci resta una ricca — sebbene in gran parte testuale — eredità d’intelletto ed esperienza costruita dalle generazioni passate. Eppure questa storia è ormai così distante da risultare facilmente romanticizzata: programmi e polemiche un tempo dinamici si sono cristallizzati in schemi, e le passioni ardenti di quell’epoca si sono raffreddate in una nostalgia paralizzante.
Dall’altro lato, in termini di esperienza concreta e di trasmissione diretta, il lungo inverno della repressione ci ha lasciato soltanto frammenti dispersi. I partiti del passato si sono sciolti nell’alambicco della repressione. Le grandi menti sono state spezzate. Tradimento ha seguito tradimento. I coraggiosi sono stati schiacciati, i codardi sono fuggiti. Solo i morti sono rimasti puri nel loro silenzio. La nostra generazione è dunque cresciuta allo stato brado, il nostro comunismo incolto e selvatico, plasmato soltanto dalla forza grezza del capitale. Di conseguenza, oggi scopriamo che qualsiasi indagine sulla “questione dell’organizzazione” è appesantita da due pesi: da un lato, un eccesso di storia troppo lontana, facilmente ridotta a una fan–fiction enfatica; dall’altro, la mancanza di istituzioni vive che continuino lo spirito incendiario del progetto partigiano.
Soggettività collettiva
A prima vista, la questione sembra ovvia: ciò di cui c’è bisogno è più “organizzazione”. Tuttavia, una volta affrontata, la stessa definizione di “organizzazione” si rivela ambigua, dissolvendosi nel tentativo di chiarire cosa, esattamente, si intenda con essa. Spesso, la domanda stessa non serve ad altro che da clava polemica. Lo schema è noto: il “teorico” osserva le lotte recenti, ne diagnostica i limiti evidenti, li attribuisce a una scelta consapevole di attori cattivi o perlomeno ingenui che hanno preferito forme di lotta “orizzontali” o “senza leader” a loro detrimento, e poi prescrive “organizzazione” come panacea — ciò che si sarebbe dovuto scegliere in passato e che si deve scegliere in futuro1. Così facendo, tali “teorici” non solo non offrono alcuna immagine concreta di ciò che l’“organizzazione” avrebbe potuto essere nelle condizioni reali affrontate dai ribelli — poiché non esisteva certo alcun esercito rivoluzionario in attesa di ordini —, ma, nella loro ossessione fanatica per la correttezza ideologica, non colgono neppure la dinamica più elementare della rivolta sociale: quella per cui una forma di intelligenza collettiva emerge dall’azione di massa, eccedendo il pensiero di qualsiasi singolo partecipante o gruppo politico programmatico.

La vera questione è dunque di tutt’altro ordine. Chiunque abbia partecipato a una delle grandi ribellioni degli ultimi quindici anni può dirlo: non è mai mancata la presenza di “teorici dell’organizzazione”, né di piccole formazioni militanti di “quadri” correttamente orientati che, nel mezzo della rivolta, promuovono la propria visione organizzativa legata a un programma politico coerente. Perché, allora, nessuno sembra interessato a ciò che questi individui propongono? La ragione è semplice: non propongono nulla, se non la parola “organizzazione” stessa, ripetuta all’infinito. Per quanto convinti del contrario, tali individui e le loro cosiddette “organizzazioni” raramente forniscono esperienze tattiche concrete o conoscenze strategiche, e risultano quindi incapaci di spingere la rivolta oltre i suoi limiti e di costruire forme sostanziali di potere proletario. Per questo motivo. vengono rapidamente superati dall’intelligenza collettiva della rivolta stessa. Anche nei rari casi in cui avrebbero qualcosa da offrire, non riescono a organizzarsi in modo abbastanza efficace da convincere chiunque a prestare attenzione a ciò che dicono. In altre parole: non possiedono alcun mezzo per interfacciarsi o interagire con la rivolta più ampia2.
Questo approccio alla questione dell’organizzazione è esso stesso un sintomo dei limiti tattici concreti che emergono dall’incapacità delle ribellioni di produrre cambiamenti sociali significativi o di generare forme di potere proletario durevoli. Ma è anche un errore metodologico: assume come punto di partenza le grandi organizzazioni programmatiche sorte da decenni di lotta rivoluzionaria nelle epoche passate, come se tali entità potessero essere rianimate con la sola forza di volontà.
In realtà, il processo di organizzazione è esattamente l’opposto: nel vivo delle lotte e delle ribellioni — di intensità variabile — sorgono miriadi di forme organizzative (spesso etichettate in modo dispregiativo come “spontanee” o “informali”) che nascono dai problemi tattici con cui si deve confrontare l’intelligenza collettiva dei partecipanti; solo dopo la formazione di questo substrato pratico di potere popolare possono emergere forme più “strategiche” o teoriche di coordinamento e costruzione del potere su scala più ampia. In altre parole, chi entra nella rivolta esclamando “dobbiamo organizzarci” presuppone un “noi” che ancora non esiste.
La questione dell’organizzazione deve quindi concentrarsi, prima di tutto, sulla costruzione della soggettività collettiva, non sul suo comando. Il punto di partenza della teoria del partito non è dunque la domanda “come dovremmo organizzarci?”, bensì un duplice interrogativo: come può una forma di soggettività rivoluzionaria specificamente comunista emergere a partire dalle lotte quotidiane della classe, intrinsecamente non-comuniste? E come possono specifici gruppi di partigiani comunisti, prodotti da queste stesse lotte, intervenire nuovamente in esse per sviluppare ulteriormente questa soggettività partigiana, dentro e oltre le singole lotte? L’emergere del partito è tanto un processo di raccolta e apprendimento dall’intelligenza collettiva della classe nel mezzo dei conflitti incendiari, quanto un intervento propositivo o una sintesi programmatica. Invece di guardare alle rivolte recenti in senso puramente negativo, interpretandone i limiti come errori ideologici, l’indagine partigiana vede tali fallimenti come limiti materiali, espressi tatticamente, che tuttavia contengono una forza soggettiva propulsiva. In questo senso, essi possono essere letti in modo positivo come un archivio accumulato di sperimentazione collettiva — purché queste esperienze vengano attivate e fatte valere nei futuri cicli di rivolta.
L’avanguardia tattica e il simbolo
I limiti tattici che sorgono per vincolare ogni rottura sociale possono essere superati solo attraverso l’azione — e solo l’azione elabora il pensiero collettivo. L’azione è l’interfaccia necessaria tra il pensiero isolato di individui o gruppi e la soggettività di massa espressa nella rivolta più ampia. Gli approcci convenzionali alla questione dell’organizzazione tendono a presumere che l’azione derivi dal sentimento morale o politico individuale. Questi approcci sono “discorsivi” nel senso che presuppongono che l’azione politica sia preceduta dalla proposta intellettuale di un determinato programma. In altre parole, si parte dall’idea che le persone vengano convinte ad adottare certe idee politiche attraverso la conversazione, la polemica o la propaganda, e che tali idee implichino poi l’adozione di certe strategie e pratiche tattiche affini. Ma la storia dimostra l’esatto contrario: le posizioni politiche emergono dall’azione tattica, non dall’imposizione discorsiva di argomenti morali o ideologici.
Mettere il programma al primo posto significa, quindi, procedere a ritroso e spesso, di fatto, alimentare la disorganizzazione. In realtà, l’organizzazione nasce dal superamento pratico dei limiti materiali e si trascina dietro, come scia, i suoi impegni intellettuali, estetici ed etici. In altre parole, le persone non aderiscono a un’organizzazione, non la sostengono e non ne assumono in massa posizioni politiche, simboli o disposizioni generali perché concordano pienamente con essi, ma perché l’organizzazione dimostra competenza e forza di spirito. Nella teoria militare, questo processo è inteso come una lotta per il controllo competitivo su un campo aperto di conflitto3. Solo dopo che questa leadership concreta nell’azione è stata stabilita, le persone diventano ricettive a una leadership più astratta di programma e di principio. Così, anche se un approccio propositivo possedesse un programma teoricamente valido e praticamente utile, se i suoi aderenti non fossero in grado di attuare le interventi tattici necessari a interfacciarsi con l’intelligenza collettiva dell’insurrezione esso non riuscirebbe comunque a influenzare il corso degli eventi.
Inoltre, questi programmi dovrebbero essere considerati articolazioni viventi del loro momento politico. Anche le loro analisi strutturali più ampie esprimono una forma di intelligenza collettiva localizzata in un determinato tempo e luogo. Di conseguenza, essi sono non solo provvisori, ma devono anche essere appendici e derivazioni dell’azione. Questo processo, a sua volta, riforma tali posizioni e genera forme nuove di pensiero politico. La politica, così, si diffonde ed evolve proprio attraverso questa interfaccia tattica. Compiendo atti coraggiosi che infrangono i limiti tattici di una determinata lotta, la simbologia di un gruppo di partigiani può acquisire una forza memetica aggiuntiva, diventando ciò che qui si definisce un simbolo (sigil): una forma simbolica flessibile che condensa e trasmette una certa dimensione dell’intelligenza collettiva della rivolta in una grammatica visiva semplificata e, così facendo, attinge a una forma più ampia di soggettività (il partito storico, come verrà esplorato più avanti)4.
Nella sua forma più rudimentale, il simbolo opera sul piano estetico: esempi come il gilet giallo o il casco giallo delle lotte di fine anni 2010. Nella sua forma più elaborata, esso comprende determinate pratiche tattiche o disposizioni organizzative trasmesse attraverso un nome e un insieme minimo di pratiche: consigli di fabbrica, comitati di resistenza di quartiere, occupazioni di piazze pubbliche, e così via. Il simbolo traduce le tattiche in forme ampiamente replicabili e offre un passaggio minimo attraverso cui gli inesperti (cioè quella parte della popolazione normalmente considerata “apolitica”) possono entrare nel momento della rottura. Il simbolo, quindi, apre l’azione a una base sociale più ampia di partecipanti, indipendentemente dall’adesione o meno a punti di unità discorsivi o programmatici.

Il simbolo solleva così una forma preliminare di soggettività collettiva dalla marea della storia. Evoca al contempo una forza partigiana dalla classe attraverso un potere apparentemente occulto e, come punto di orientamento tattico concreto, struttura questa soggettività informe in forme minime di organizzazione. Sebbene memetico, il simbolo non è primariamente estetico e non dipende da alcun mezzo tecnico particolare per la sua diffusione: i simboli emergono solo attraverso l’esempio tattico. Le disposizioni politiche seguono poi il simbolo, come articolazioni disordinate e perlopiù inconsce di questi atti radicali. Qualcuno indossa un casco giallo e infrange le finestre del parlamento; il pacchetto di sentimenti e conflitti politici associato a quell’atto simbolico — in questo caso, il localismo di destra a Hong Kong — può poi diffondersi ulteriormente per replicazione memetica, permettendo ai simboli e alle pratiche associati di egemonizzare più facilmente lo spazio estetico e tattico della rivolta, rafforzando così il carisma delle posizioni politiche correlate5.
Le lotte sulla riproduzione sociale6
Un’altra distinzione altrettanto importante è quella tra il progetto partigiano, che può essere costruito solo attraverso rotture sociali di vasta scala, e le forme più limitate di lotta che emergono nel ribollire continuo del conflitto di classe7. Ogni organizzazione comunista deve necessariamente orientarsi attorno alle lotte sulla riproduzione sociale che emergono costantemente nella classe, generate dalle dinamiche contraddittorie della società capitalista. Anche se gli eventi politici più vasti superano queste lotte — e questa eccedenza è il vero luogo in cui sorge una forza soggettiva —, i conflitti iniziali sui termini e sulle condizioni della riproduzione sociale costituiscono comunque la loro origine. Allo stesso modo, queste lotte sulla riproduzione sociale strutturano il campo in cui l’organizzazione deve persistere tra un’insurrezione e l’altra. Pertanto, ogni organizzazione comunista deve essere in grado di tradursi continuamente in interessi di classe concreti, assumendo funzioni pratiche in relazione sia ai termini specifici della riproduzione sociale in un dato momento, sia ai metodi attraverso cui tale riproduzione sociale viene imposta alla classe.
Tuttavia, i comunisti devono anche affrontare le lotte sulla riproduzione sociale come un limite da superare. Poiché le rivendicazioni espresse da queste lotte derivano da interessi imposti e da identità costruite dal capitale stesso (come si vede, ad esempio, nell’opposizione razzista al lavoro migrante), limitarsi a difendere il benessere materiale — ossia a “lottare per miglioramenti reali” per la classe lavoratrice — finisce col privare l’organizzazione comunista della sua fedeltà al progetto comunista più ampio. L’impulso incendiario di una lotta viene dissanguato da mille piccoli compromessi. Infatti, la “vittoria” in una lotta di riproduzione sociale è spesso essa stessa una sconfitta: il poliziotto assassino viene processato (forse persino condannato), l’aumento salariale è conquistato, il progetto ambientale distruttivo viene cancellato, la legge controversa ritirata, il presidente si dimette (e il potere passa al “governo di transizione”). Il modo più efficace per sconfiggere un movimento comunista è che il partito dell’ordine conceda guadagni reali nelle lotte sulla riproduzione sociale e li consolidi sotto la propria bandiera.
In senso lato, le lotte sulla riproduzione sociale sono quelle che si concentrano su questioni concrete di sopravvivenza nel capitalismo. Pur operando su molteplici dimensioni, possono essere suddivise, approssimativamente, in due categorie: lotte sui termini della riproduzione sociale; e lotte sull’imposizione di tali termini alla popolazione. Le prime si focalizzano su questioni di distribuzione e di accesso alle risorse sociali; le seconde su questioni più ampie di sopravvivenza e dignità che emergono nella distribuzione di tali risorse.
La prima categoria — le lotte sui termini della riproduzione sociale — è quasi sempre centrata sul livello dei prezzi. Si può ulteriormente suddividerla in: lotte sui prezzi generali delle merci (costo della vita, in particolare affitti), lotte sul prezzo della forza-lavoro (salari, pensioni, benefit), lotte sui prezzi dei servizi e delle risorse gestiti dallo Stato (welfare, infrastrutture, istruzione). Differenze istituzionali locali fanno sì che alcune questioni (come la sanità) possano collocarsi da una parte o dall’altra, o attraversare diverse categorie. Picchi improvvisi dei prezzi o redistribuzioni di beni sociali possono certamente innescare proteste di massa, e inflazione o corruzione croniche possono accrescerne la frequenza. Tuttavia, di norma, queste lotte sono più facilmente assorbite nella sfera delle politiche pubbliche, e acquisiscono un margine radicale solo in condizioni estreme o quando esistono organizzazioni partigiane in grado di spingerle in quella direzione. Per questo motivo, la loro espressione politica tende verso un populismo semplice, focalizzato sulla restaurazione di livelli di prezzo stabili, presumibilmente alterati da interferenze di élite parassitarie nell’altrimenti “efficiente” funzionamento del mercato.
La seconda categoria — le lotte sull’imposizione dei termini di riproduzione sociale — riguarda invece la sopravvivenza e la dignità nella vita e nel lavoro. Le più ovvie sono le proteste ricorrenti, su scala minore, contro gli omicidi di polizia nei quartieri poveri (almeno finché non degenerano in rivolte di massa), le lotte abolizioniste contro l’incarcerazione, le proteste locali contro le deportazioni, e così via. Ma queste lotte si intrecciano anche con le altre. Nel luogo di lavoro, ad esempio, le lotte sui termini della riproduzione sociale sono spesso motivate non tanto dal loro obiettivo immediato (come l’aumento salariale) quanto dall’opposizione a manager autoritari o a trattamenti differenziali per razza o status migratorio. Tali conflitti sono spesso i più incendiari sul piano lavorativo — come sa bene chiunque abbia organizzato un luogo di lavoro. Analogamente, quando le lotte sui termini della riproduzione sociale incontrano la violenza poliziesca, esse si trasformano immediatamente in lotte contro l’imposizione stessa di tali termini.
Queste lotte, dunque, sono più ampie e assumono più rapidamente un carattere apertamente politico, esprimendosi spesso come lotte contro la dominazione in quanto tale.

A differenza delle lotte sui termini della riproduzione sociale, che possono spesso essere previste, almeno in modo approssimativo, in base all’andamento delle politiche e dei livelli dei prezzi, le lotte contro l’imposizione di questi termini sulla popolazione sono estremamente difficili da prevedere. Al di là dell’intuizione generale secondo cui tali lotte scoppiano più facilmente in determinate aree e tra popolazioni soggette a forme estreme di abiezione, e che si diffondono più efficacemente quando un caso particolare riceve ampia risonanza, è difficile dire, ad esempio, quando un singolo omicidio da parte della polizia porterà a una protesta, ed è praticamente impossibile dire quando potrà invece innescare una rivolta su larga scala che superi i propri limiti iniziali. In generale, tuttavia, queste lotte sono più difficili da riassorbire o neutralizzare attraverso le istituzioni esistenti e si propagano più facilmente, poiché la loro stessa repressione genera ulteriori rivolte.
Particolari convergenze di lotte per la riproduzione sociale fungono da terreno su cui emergono le insurrezioni di massa, le quali poi superano questi limiti iniziali e cessano così di esprimere soltanto le lotte sulla riproduzione sociale da cui sono scaturite. Sebbene entrambe le modalità di lotta per la riproduzione sociale svolgano un ruolo in questo processo, di solito è il secondo tipo ad agire come detonatore immediato. Le proteste in corso in Indonesia ne sono un buon esempio: il lento ribollire di conflitti sui termini della riproduzione sociale (costo della vita, distribuzione statale delle risorse, accesso all’occupazione, ecc.) ha fornito l’insieme delle rivendicazioni di base per un primo ciclo di proteste limitate. Queste sono poi esplose in una rivolta giovanile di massa dopo che la polizia ha brutalmente assassinato un fattorino e successivamente represso le proteste con ulteriore violenza, causando ancora più morti. Tuttavia, anche le lotte più aggressive contro l’imposizione dei termini della riproduzione sociale rimangono entro gli stessi limiti di qualsiasi lotta per la riproduzione sociale, esprimendo interessi concreti che possono poi essere cooptati dal partito dell’ordine8.
Ecumenico e sperimentale
Qualsiasi pretesa, da parte di un gruppo o partito, di conoscere l’unico vero cammino verso la rivoluzione è, ovviamente, ridicola. Le rivoluzioni non sono monoculture, né in teoria né in pratica. L’unica cosa che dovrebbe unire i comunisti, quindi, è una rigorosa opposizione al settarismo e a ogni pretesa di certezza. La nostra pratica deve essere ecumenica e sperimentale fin dall’inizio, coltivando, raccogliendo e catalizzando le differenze, mettendole poi in costante conversazione tra loro. Solo incorporando approcci eterogenei nei nostri sforzi possiamo sperare di generare soluzioni nuove ai molteplici limiti intellettuali e tattici che ogni processo rivoluzionario deve affrontare. Ciò richiede di mantenere un atteggiamento di apertura verso correnti apolitiche o anti-politiche, così come verso coloro la cui espressione stilistica o tonale della politica differisce dalla nostra, e di evitare di trasformare goffamente tali differenze estetiche in presunte critiche politiche.
Allo stesso tempo, l’ecumenismo non equivale all’eclettismo. E lo sperimentalismo non coincide con la semplice fascinazione per la novità. Lo scopo non è “prendere ciò che è utile” da qualsiasi fonte per costruire un felice patchwork di idee radicali, né ossessionarsi per qualche “nuova” tattica o disposizione nella lotta (che nei fatti spesso rappresenta, invece, qualcosa di già visto), ma piuttosto estrarre e integrare verità frammentarie in un’idea comunista molteplice ma coerente, condivisa ampiamente da tutti i partigiani, ognuno dei quali elabora lo stesso progetto di base in molteplici dimensioni. Il comunismo si tiene insieme proprio attraverso la diversità delle espressioni che lo compongono. Ma questa diversità richiede, come suo fondamento, che tali espressioni circolino comunque intorno a un insieme di condizioni minime, così come un pendolo oscilla attorno a un centro di gravità distinto (ma anche virtuale o emergente). Semplificando al massimo, queste condizioni possono essere riassunte così: la convinzione che lo scopo di tale progetto sia la creazione di una società planetaria fondata sui principi della deliberazione, della non-dominazione e dell’associazione libera, utilizzando le vaste capacità (scientifiche, produttive, spirituali, culturali, ecc.) della specie umana per riabilitare il suo metabolismo con il mondo non umano.
Queste condizioni minime si dispiegano poi in una serie di ulteriori domande e conclusioni da elaborare attraverso il progetto partigiano stesso. Per definizione, una società che operi secondo tali principi deve abolire le forme indirette o occultate di dominio incorporate nel valore come forma sociale (inclusi denaro, mercati, salari, ecc.) e nelle forme di identità legale e illegale che ne derivano (cioè lo status di “cittadino” di un “paese” con diritti differenziali), così come le forme dirette di dominio espresse dallo Stato, dall’inclusione obbligatoria in unità familiari autoritarie, da pratiche patriarcali o xenofobe, ecc. Allo stesso modo, poiché implica una transizione di fase tra forme di organizzazione sociale fondamentalmente differenti, il comunismo deve emergere da una rottura rivoluzionaria con il vecchio mondo e non può essere raggiunto gradualmente attraverso mezzi evolutivi di riforma o sviluppo delle forze produttive. Da ciò deriva forse la linea di demarcazione più importante: quella che separa i comunisti da tutti coloro che temono, disprezzano o trattano come infantile il comportamento tumultuoso della folla nel momento dell’insurrezione, preferendo invece tattiche di protesta ordinate e “pacifiche” o qualche forma mitica di disciplina militante, come se le insurrezioni fossero operazioni chirurgiche piuttosto che sollevazioni di massa caotiche.
In apparenza, ciò sembra porre un paradosso: se consideriamo l’unità come sinonimo di uniformità e quindi come opposta alla diversità o alla differenza, queste condizioni assumerebbero un carattere esclusivo, contrario allo spirito dell’ecumenismo. Ma ciò che qui si propone non è un’unità rigida o sovra-ordinata che annulli e omogeneizzi gli elementi secondari, bensì una misura necessaria di coerenza. Sebbene queste condizioni minime debbano essere mantenute per garantire un ambiente ecumenico che permetta la proliferazione di idee veramente comuniste, questo processo di restrizione è al tempo stesso generativo. Senza tale applicazione, idee “radicali” o “di sinistra” non comuniste, più vicine al senso comune dell’ideologia dominante, finirebbero rapidamente per diluire qualsiasi contenuto comunista. Pur rimanendo importante il dialogo con queste correnti vagamente “socialiste”, “abolizioniste” o “attiviste” — poiché le loro contraddizioni tendono a condurre una minoranza dei partecipanti più lucidi verso il comunismo — è ancora più importante mantenere una distinzione netta, rifiutando di liquidare il progetto comunista in questo tiepido radicalismo liberale. Ciò ci consente di stabilire le basi per la nostra stessa sperimentazione, permettendo ai partigiani comunisti di tentare diverse forme di intervento e di impegno, e di raccoglierne poi i risultati con chiarezza di mente.
Teoria del Partito
Quando parliamo di organizzazione comunista, non stiamo parlando di organizzazione in generale. Sebbene varie teorie dell’organizzazione in quanto tale — derivate dalla cibernetica, dalla biologia o persino dagli esempi di strutture di coordinamento usate in contesti aziendali o militari — possano certamente offrire spunti utili, esse mancano tuttavia di un elemento necessariamente trascendente: l’orientamento partigiano verso un’idea. L’essere partigiani richiede una teoria non semplicemente dell’organizzazione, ma dell’organizzazione di partito in senso specifico. Inoltre, per i comunisti, si tratta di una questione che può essere formulata solo attraverso una “teoria” del partito elaborata nella pratica: costruita continuamente a partire dalle lezioni pratiche apprese nelle lunghe storie del conflitto di classe, e costantemente reinserita in questo conflitto per essere verificata e ulteriormente affinata. Sebbene questa teoria possa, in un dato momento, essere raccolta e articolata da determinati pensatori, essa esprime in ultima analisi un’eredità collettiva continuamente re-imparata e reinventata attraverso l’azione della classe.
Il partito storico (invariante)
A un alto livello di astrazione, possiamo suddividere la teoria del partito in tre concetti distinti ma interconnessi. Il primo di questi, il partito storico, è anche il più ampio: esso comprende la somma delle forme apparentemente spontanee di disordini di massa che riemergono continuamente dalle lotte sui termini della riproduzione sociale. Se ne parla al singolare: esiste un solo partito storico che ribolle sotto la società capitalista in tutti i luoghi e in tutte le epoche, anche se diventa visibile solo nei momenti di sua eruzione. Marx si riferisce a questo come al “partito dell’anarchia”, poiché è così che viene trattato dal “partito dell’ordine”, che tenta di sopprimerlo, e dall’“antipartito”, che tenta di soffocarlo completamente9. Questo partito è sempre almeno debolmente rintracciabile nel ribollire delle lotte sulla riproduzione sociale. Tuttavia, le lotte sulla riproduzione sociale di per sé non esprimono un contenuto comunista e non assumono “naturalmente” un carattere partigiano. Al contrario: esse tendono a esprimere gli interessi determinati di identità socialmente modellate e, di conseguenza, la loro traiettoria più probabile è quella di sviluppare rivendicazioni relativamente limitate e rappresentative che, anche se espresse attraverso “movimenti sociali dal basso”, operano interamente all’interno del regno della politica convenzionale — chiedendo riforme ai poteri esistenti, appellandosi al sentimento pubblico o affermando gli interessi particolari di un segmento della classe contro altri.

Le lotte sulla riproduzione sociale, prese da sole, vanno quindi comprese come forme espressive di coscienza politica, in cui la “soggettività” è ridotta alla mera rappresentazione della posizione sociale. Al contrario, l’orizzonte emancipatorio visibile nel movimento del partito storico emerge solo in eccesso rispetto alla rappresentazione, anche se nasce necessariamente da una specifica collocazione sociale (cioè dai conflitti e dalle configurazioni di potere peculiari di quel luogo). La soggettività rivoluzionaria è l’elaborazione di una universalità pratica in tensione con le proprie condizioni di emersione10. Pertanto, l’esistenza del partito storico risulta più evidente quando le lotte sulla riproduzione sociale raggiungono una certa intensità, momento in cui esse assumono un carattere autoriflessivo che esonda dai limiti delle loro rivendicazioni iniziali. In termini convenzionali, è il punto in cui lotte singolari diventano moltiplici insurrezioni di massa. Queste rotture sociali eccessive possono anche diventare singolarità politiche, o ciò che il filosofo Alain Badiou chiama “eventi”, i quali deformano la trama di ciò che appare possibile in un determinato luogo, riorganizzando così le coordinate del paesaggio politico nel loro seguito11.
Di per sé, il partito storico è una forza non del tutto soggettiva. Sebbene generi certamente forme di “coscienza di classe”, esso opera a un livello che può essere descritto al meglio come il subconscio della classe. Per questo motivo, spesso appare informe, indecifrabile e reattivo. Inoltre, l’intensità di una data reazione è spesso estremamente difficile da prevedere. Gli omicidi da parte della polizia, ad esempio, avvengono di continuo, ma solo alcuni casi — in sostanza identici a molti altri — generano insurrezioni di massa. Ciononostante, il movimento del partito storico è chiaramente connesso alle tendenze strutturali di lungo periodo in un determinato luogo e nella società capitalista nel suo insieme. Possiamo persino pensarlo come spinto in avanti dalla tensione intrinseca tra le identità sociali esistenti (la “coscienza politica” anti-emancipatoria delle lotte sulla riproduzione sociale e dei movimenti sociali) e la loro eccessiva sovra-espressione nell’evento.
Ciò spiega gli alti e bassi del partito storico, determinati dalla confluenza di queste tendenze oggettive e dalla loro elaborazione soggettiva nel conflitto di classe, nonché la sua invarianza. Le leggi fondamentali della società capitalista non cambiano, e la crisi e la lotta di classe sono i mezzi attraverso cui questa società si riproduce. Per questo motivo, le lotte sulla riproduzione sociale sorgeranno sempre e, raggiunta una certa intensità, tenderanno inevitabilmente a traboccare dai propri limiti, generando eventi politici in cui il partito storico diviene visibile. Attraverso il suo conflitto con il mondo esistente, il partito storico proietta così in avanti un’immagine del comunismo in negativo. Questa immagine è invariante in due sensi. Primo: poiché la logica sociale di base della società capitalista è immutabile, anche le condizioni minime per la sua distruzione rimangono le stesse. Possiamo pensare a ciò come a un’invarianza teorica o strutturale. Secondo: il processo attraverso cui la soggettività rivoluzionaria prende forma è anch’esso invariante, nel senso che i comunisti si troveranno sempre ad affrontare gli stessi enigmi centrali e riceveranno risposte simili dalle forze dell’ordine sociale, dando luogo a un campo strategico che, nei suoi aspetti fondamentali, è identico a quello affrontato dalle forze rivoluzionarie del passato. Possiamo chiamarla un’invarianza pratica o soggettiva.
La spoliazione alla radice dell’esistenza proletaria — resa evidente nelle lotte quotidiane per la riproduzione sociale — e la possibilità del potere proletario — resa visibile nell’eccesso politico dell’evento — si uniscono così per creare un’immagine potenziale, virtuale o spettrale del comunismo, sempre percepibile da alcuni partecipanti e non da altri, a seconda della combinazione di circostanze e temperamento. Tracciando i limiti di una determinata lotta, questi partecipanti finiscono per elaborare un disegno, un principio o una verità più ampi: l’idea invariante del comunismo. Per questa stessa ragione, gli eventi si aprono direttamente su una certa dimensione dell’assoluto, collegando tra loro insurrezioni di epoche e luoghi diversissimi all’interno della stessa eternità, che è essa stessa un riflesso, nel presente, del possibile futuro comunista.
Il partito formale (effimero)
I partiti formali rappresentano tentativi di elaborare questo schema dentro e oltre gli eventi, trasponendo quell’idea invariante nella stoffa effimera delle assemblee auto-coscienti di individui. Dei partiti formali si parla al plurale: esistono sempre molteplici partiti formali che operano simultaneamente, ciascuno tracciando la propria rotta secondo un metodo di navigazione a vista, elaborando così il modello o principio in direzioni distinte, che spesso si tirano l’una contro l’altra. Nessun singolo partito formale può mai essere considerato come “l’avanguardia” della classe nel suo insieme. Tuttavia, proprio come le onde che si infrangono rappresentano un moto fluido più profondo, il partito storico genererà sempre i propri distaccamenti d’avanguardia. Ogni partito formale ha dunque il potenziale di fungere da una delle molte avanguardie del partito storico. Queste avanguardie operano spesso lungo dimensioni differenti: alcuni partiti formali esprimono una comprensione teorica più avanzata e complessiva, altri possiedono un sapere tattico più raffinato, oppure semplicemente lasciano brillare il proprio spirito in battaglia — ogni atto coraggioso accende un nuovo fuoco di segnalazione che chiama la classe al combattimento.
Questi partiti emergono di solito dall’eccesso autoriflessivo dell’evento, sebbene possano anche apparire in periodi intermedi in forme deboli, in particolare quando il livello complessivo di soggettività partigiana è elevato. Alla radice, un partito formale nasce ogni volta che gruppi di individui si uniscono con l’intento cosciente di espandere, intensificare e universalizzare ulteriormente un evento. I partiti formali spesso sopravvivono al picco del partito storico e, nel periodo intermedio tra le rotture sociali, possono tentare di elaborare la verità collettiva rivelata dall’evento, di preparare futuri sollevamenti, o (se ne hanno la capacità) di intervenire nelle condizioni esistenti per rendere più probabile l’emergere di nuovi eventi e assicurarsi che abbiano maggiori probabilità di superare i limiti precedenti. In questo senso, i partiti formali esprimono una forma debole o parziale di soggettività, o, più accuratamente, il processo iniziale e balbettante attraverso cui un soggetto rivoluzionario viene generato.
La grande maggioranza dei partiti formali è costituita da piccoli raggruppamenti di orientamento pratico o tattico, che sorgono spesso da collettivi funzionali improvvisati nel pieno di una lotta: un comitato organizzativo in un’ondata di scioperi, una cucina comune in un’occupazione, gruppi di prima linea impegnati in scontri con la polizia, collettivi di studio e ricerca formati per comprendere meglio la lotta, o vari consigli di quartiere che immancabilmente emergono nel mezzo di un’insurrezione. Ma i partiti formali possono anche essere più grandi, più esplicitamente politici e persino “strategici” nel loro orientamento, purché conservino questo carattere partigiano. I gruppi tattici che non si dissolvono tendono in questa direzione. Di conseguenza, possono perfino evolversi in “partiti comunisti” nominali, ciascuno espresso come il partito comunista di un determinato luogo e spesso contrapposto ad altri “partiti comunisti” sovrapposti. Nessuno, tuttavia, è il partito comunista in quanto tale.
Anche se può sembrare un paradosso, i partiti formali esistono sia che riconoscano la propria esistenza, sia che non lo facciano. In altre parole, i partiti formali descrivono anche raggruppamenti “informali” che potrebbero non considerarsi organizzazioni coerenti. Per esempio: gruppi di amici che si riuniscono ogni notte nel mezzo della lotta, sottoculture che partecipano all’insurrezione e vengono poi lacerate dalle sue conseguenze, e naturalmente i vari “gruppi di affinità” e “organizzazioni informali” che, ironicamente, tendono ad avere alcune delle forme di disciplina e di comando più rigorose e raffinate. Indipendentemente dalla loro presunta “informalità”, questi gruppi operano in realtà secondo formalità di costume, carisma e semplice inerzia funzionale.
La differenza tra gruppi “informali” e “formali” non consiste dunque nel fatto che siano o meno partiti formali (entrambi lo sono), ma nel grado in cui questa formalità è un tratto esplicito e dichiarato dell’organizzazione. Allo stesso modo, il loro aspetto partigiano — l’impegno nell’elaborare la verità collettiva dell’evento in generale e nel superare i limiti di un dato evento — non ha nulla a che vedere con le loro dichiarazioni programmatiche. I partiti formali vengono invece messi alla prova, e mantengono o perdono il loro status di organizzazioni partigiane, quando si confrontano con nuovi eventi politici. Tali eventi mostrano se il partito ha mantenuto la propria fedeltà al progetto comunista, creando le condizioni in cui il suo atteggiamento e comportamento possono essere verificati contro l’“anarchia” scatenata da una data insurrezione. Si impegna nella nuova rivolta? E, se sì, la sua forma di intervento tende a deviare quella rivolta verso percorsi più conservatori? Oppure svolge una funzione pratica nel spingere la rivolta oltre i suoi limiti?
Se viene trovato mancante, il partito formale precedente viene ridotto: non è più un partito, ma una mera organizzazione o, peggio ancora, un organo operativo del partito dell’ordine, ovvero dell’antipartito. Questa è una delle ragioni per cui il partito formale è sempre effimero. In quanto gruppi funzionali e spesso occasionali, i partiti formali tendono a sciogliersi spontaneamente quando non sono più necessari, oppure a cambiare forma, evolvendo da gruppi tattici coesi nel mezzo di un’insurrezione a un più amorfo ambiente sociale nel suo seguito. Nel frattempo, organizzazioni più grandi spesso conservano l’apparenza di essere un partito formale solo per fallire completamente alla prova dell’evento stesso; a quel punto, si ritirano nell’oscurità, sommerse dalle maree della storia, o si calcificano in gruppi settari che non svolgono più alcuna funzione pratica. Per la stessa logica, organizzazioni preesistenti possono improvvisamente assumere funzioni partigiane e diventare così partiti formali, siano esse state in precedenza esplicitamente politiche (gruppi abolizionisti, sindacati, società di mutuo soccorso) o solo marginalmente politiche (ultras calcistici, chiese, organizzazioni di soccorso in caso di disastri).
Tuttavia, lo “scarto” dei partiti formali ormai ossificati è di per sé produttivo, poiché futuri partiti formali emergono proprio in opposizione a questi organi cristallizzati, esprimendo così forme più avanzate di soggettività. Per questo motivo, i partiti formali appena dissolti e quelli calcificati formano una sorta di struttura del suolo da cui possono emergere forme più complesse di vita politica. Comprendere tale complessità richiede quindi di operare distinzioni più granulari tra diverse forme di organizzazione (in particolare quelle apolitiche e pre-politiche più inclini ad assumere caratteristiche partigiane nel mezzo di un evento, o più utili per i partigiani nel relazionarsi con esse) e tra diverse specie di partito formale: il puramente tattico e occasionale, il gruppo militante “informale”, il gruppo militante “formale”, il sindacato radicale, la milizia di autodifesa, la cosiddetta “armata popolare”, il “partito comunista” nominale, ecc.
La forma atomica dell’organizzazione partigiana è ciò che chiamo il “conclave comunista”. I comunisti nascono nel pieno degli eventi politici e spesso emergono da soli o, al massimo, in piccoli gruppi. Allo stesso modo, i comunisti spesso si incontrano l’un l’altro nel mezzo delle lotte e cominciano a coordinarsi in modo informale. Questi piccoli gruppi di comunisti possono essere chiamati “conclavi”, data la loro natura privata e in parte rituale — e, naturalmente, il fatto che siano organizzati in fedeltà a un progetto trascendente. Ovunque due o tre si riuniscano in quanto comunisti, lì esiste un conclave, indipendentemente dal fatto che essi si pensino o meno come tale. I conclavi operano principalmente per affinità. Alcuni poi elaborano questa affinità in forme più strutturate di divisione del lavoro o in subculture informali più ampie. Spesso, i conclavi fungono da seme per partiti formali più articolati.
Anche quando emergono progetti partigiani formali, tuttavia, i conclavi persistono dentro e attraverso di essi. Questi legami di affinità informale sono essi stessi importanti partiti formali. Servono a colmare il divario tra organizzazioni partigiane e non partigiane, a integrare più densamente i progetti formali partigiani e a fornire resilienza e ridondanza quando le organizzazioni formali si sforzano o si frammentano. In altre parole, piccoli partiti formali esisteranno sempre all’interno del corpo di partiti formali più complessi. Informalità e formalità, spontaneità e mediazione, opacità e trasparenza non sono opposte. Nessuna delle due può essere privilegiata sull’altra, né eliminata del tutto. Conclavi segreti esisteranno (devono e dovrebbero esistere) all’interno di organizzazioni comuniste formali con adesione trasparente, e conclavi ancora più segreti esisteranno all’interno del conclave stesso.
Teoria, invenzione tattica e cameratismo si forgiano in questi spazi oscuri e intimi, prima di essere elaborati in sedi più aperte attraverso discussione, dibattito ed esperimento trasparenti. Sebbene un conclave possa essere visibile dall’esterno, rimane comunque un’istituzione relativamente opaca. Da un lato, ciò rappresenta sempre una minaccia per l’organizzazione più ampia, nella misura in cui consente manovre occulte e lotte di potere segrete. Dall’altro lato, questa stessa privacy è ciò che permette al conclave di essere sperimentale e creativo. I partiti formali più complessi devono essere progettati per difendersi e, al tempo stesso, accogliere la persistenza di gruppi relativamente opachi al loro interno, e idealmente trarre da questi organi una fonte di vitalità. Sebbene questi conclavi possano talvolta essere integrati in fazioni aperte all’interno di organizzazioni più grandi, non sono sinonimi di essi e spesso sono allineati per fattori contingenti (come un’esperienza condivisa di lotta) piuttosto che per accordo teorico. Essi precedono dunque il lavoro di fazione, e una singola fazione include probabilmente molteplici conclavi.
Il partito comunista (eterno)
Il partito comunista emerge dall’interazione tra il partito storico e i molteplici partiti formali che esso genera, comprendendo ed eccedendo entrambi. A un certo punto, una combinazione di fattori strutturali causa una turbolenza crescente all’interno del partito storico. Nel frattempo, la forza soggettiva debole o parziale dei vari partiti formali, uniti dalla volontà o dalle circostanze, riesce infine a intervenire nuovamente nelle condizioni circostanti, rivitalizzando ulteriormente il partito storico che li aveva generati. Il risultato è una forma emergente di organizzazione che opera su una scala del tutto diversa rispetto alle insorgenze contingenti del partito storico o alle attività provvisorie, tattiche e largamente localizzate (anche se di ampia portata) dei partiti formali. Il partito comunista è singolare, ma al tempo stesso molteplice.
In quanto ambiente espansivo di partigianeria sempre più organizzata, il partito comunista non è mai il nome di un particolare e ufficiale “Partito Comunista” operante in qualche parte del mondo. Sebbene i molti “partiti comunisti” con la maiuscola siano spesso elementi importanti del “partito comunista” con la minuscola, quest’ultimo non può essere ridotto ad essi. Inoltre, è sempre un grave errore strategico tentare di subordinare il partito comunista in quanto tale agli interessi di un singolo Partito Comunista (anche se questo Partito Comunista è giunto a rappresentare una locale ondata rivoluzionaria). Il partito comunista può essere concepito al meglio come una sorta di “meta-organizzazione”, che da un lato favorisce l’elaborazione di nuovi partiti formali, e dall’altro stimola ulteriormente la vitalità del partito storico che scorre al di sotto. È dunque possibile parlare del partito comunista come di un “ecosistema partigiano”, nella misura in cui l’interazione tra il partito storico e i molti partiti formali radicati in esso crea letteralmente un territorio partigiano, che poi, come mezzo per successive organizzazioni, pone i propri vincoli e incentivi emergenti.
Ma questa immagine del partito come “ecosistema” è, in realtà, ideologica. La metafora ecologica, infatti, è cara alla filosofia politica liberale proprio per la sua presunta logica “orizzontale”, che sembra replicare le (altrettanto presunte) operazioni “orizzontali” del mercato. In questo caso, tuttavia, essa non coglie l’intero quadro: il partito comunista non è un ecosistema di lotte che si espandono ciecamente nella storia. Esso è piuttosto il punto in cui la soggettività debole visibile nel partito formale si sublima in una soggettività forte, adeguata al compito della rivoluzione. Questa soggettività rivoluzionaria oltrepassa le singole organizzazioni, ed è essa stessa organizzata, intenzionale, relativamente auto-cosciente (anche se ciò dipende dalla posizione di ciascuno al suo interno), e distribuita in modo diseguale nella sua geografia e nella sua composizione demografica.
Tradizionalmente, il partito comunista è stato descritto tanto nel linguaggio eccessivamente vago del “movimento comunista internazionale”, quanto in quello troppo ristretto di una data “internazionale”, cui viene assegnato un numero d’ordine nella sequenza storica. In definitiva, esso può essere visto come situato tra l’informe vaghezza di un ecosistema o movimento e la struttura rigida e capitolare delle varie iterazioni delle internazionali formali e federative. Tuttavia, è anche più esteso di entrambe le forme, nella misura in cui le sue reali capacità organizzative risiedono al di fuori sia del vasto “movimento comunista” sia delle strette federazioni dei “Partiti Comunisti”. Esse si misurano, invece, nella loro relazione con le specifiche associazioni consiliari o deliberative che emergono dalla classe nel mezzo di un’insurrezione e che iniziano a prendere misure comuniste — che ciò sia o meno loro imposto — dando così forma alle comuni che (se sopravvivono) diventano il cuore e il motore della sequenza rivoluzionaria. Le comuni possono emergere, tuttavia, solo quando il circuito tra i partiti formali e il partito storico è ben stabilito, creando un ambiente soggettivo nel quale forme deliberative, espropriative e trasformative di associazione libera divengono un prodotto organico dell’attività di classe.
Come l’evento, anche il partito comunista può emergere, cadere in eclissi e poi riemergere in un momento successivo — ma è sempre lo stesso partito comunista, legato da un filo rosso alle sue precedenti incarnazioni. La sua crescita estensiva (geografica, demografica) e intensiva (organizzativa, teorica, spirituale) costituisce essa stessa l’onda della rivoluzione che dà inizio al processo di costruzione comunista. Analogamente al partito formale, il partito comunista può apparire calcificato, decadente o infedele al progetto comunista, come accadde quando i partiti socialdemocratici della Seconda Internazionale si trasformarono in campioni nell’arte del governo riformista e della guerra di Stato. In tali situazioni, tuttavia, il partito comunista non si calcifica realmente, ma viene eclissato.Un’eclissi può essere causata da molteplici fattori, ma è sempre segnalata dal fallimento dei partiti formali che un tempo componevano il partito comunista nel mantenere la loro fedeltà al progetto. Per questo motivo, la riemersione esplosiva del partito comunista si sviluppa spesso in opposizione ai resti ossificati del passato, come avvenne quando la Terza Internazionale emerse da una serie di ammutinamenti, insurrezioni e rivoluzioni che inizialmente tentarono di emulare la costruzione di partito della Seconda Internazionale, ma furono infine costrette a elaborarsi in opposizione a tale eredità.
Il partito comunista si trova da tempo in un periodo di eclissi e, sebbene vi siano segni della sua riemersione, non si può ancora dire che esista in forma sostanziale. Ancora una volta: il partito in quanto tale non è la mera somma delle attività “di sinistra” di un dato momento, ma una forma di sovra-soggettività che sussiste solo nella conflittualità incendiaria con il mondo sociale esistente, fungendo da passaggio attraverso il quale il comunismo può essere elaborato come realtà pratica. Il partito comunista non è, dunque, una semplice aggregazione caotica di interessi minori, ma rappresenta il fiorire materializzato della ragione umana, necessario affinché la specie possa amministrare coscientemente la propria struttura sociale, che è al tempo stesso il suo metabolismo sociale con il mondo non umano12. Per questo motivo, possiamo parlare del partito comunista come del cervello sociale del progetto partigiano, e persino come della camera di gestazione della società comunista stessa.
Il partito comunista è dunque eterno, nel senso che costituisce la forma larvale di un corpo immortale: la fioritura della ragione e della passione all’interno di una specie autocosciente che coordina consapevolmente la propria attività come sistema13. In altre parole, il partito comunista è l’unica arma capace di distruggere davvero la società di classe — annullando la millenaria lotta tra semplice egualitarismo e dominio sociale, sussumendo entrambi sotto un principio superiore di prosperità — ed è anche, attraverso questa stessa distruzione, il veicolo mediante il quale la verità rivelata dal partito storico e elaborata dalla moltitudine di partiti formali fiorisce in una nuova era di esistenza materiale, che sostiene un metabolismo sociale razionale su scala planetaria.
NOTE:
- Per una critica simile di questo approccio, applicata a un esempio concreto, si veda: Jasper Bernes, “What Was to Be Done? Protest and Revolution in the 2010s” (Cosa bisognava fare? Protesta e rivoluzione negli anni 2010), The Brooklyn Rail, giugno 2024. Disponibile online qui. ↩︎
- Forse ancora più significativa è la domanda sul perché, anche quando questi individui e le organizzazioni a loro affiliate hanno apparentemente “conquistato il potere” attraverso le elezioni sulla scia della rivolta (come nei casi di Syriza, Podemos o del governo Boric in Cile), non siano poi riusciti ad attuare alcun cambiamento sociale significativo. In realtà, la deviazione della rivolta popolare verso campagne elettorali ha quasi universalmente funzionato come una forza repressiva, contribuendo a disintegrare le esigue forme di potere proletario che stavano emergendo al di fuori della sfera istituzionale. Ciò avviene indipendentemente dalle preferenze politiche o dalle intenzioni dei singoli leader. ↩︎
- Per una panoramica dell’idea, cfr.: David Kilcullen, Out of the Mountains: The Coming Age of the Urban Guerrilla, Oxford: Oxford University Press, 2015, pagg. 124-127. ↩︎
- Il concetto di “simbolo” (N.d.T. sigil nella versione originale) è un’elaborazione del “meme con forza” sviluppato da Paul Torino e Adrian Wohlleben nel loro articolo “Memes with Force: Lessons from the Yellow Vests” (Mute Magazine, 26 febbraio 2019; online qui), e ulteriormente ampliato in Adrian Wohlleben, “Memes without End”, Ill Will, 17 maggio 2021 (disponibile online qui). ↩︎
- L’uso di un esempio tratto dalla destra non è casuale in questo caso, poiché le organizzazioni di destra si sono dimostrate particolarmente abili nell’applicare questa logica negli ultimi decenni. Una delle ragioni dell’ascesa della destra è proprio il fatto che questo tipo di leadership viene spesso rifiutata senza mezzi termini da coloro che si collocano “a sinistra”, che la considerano un’imposizione intrinsecamente autoritaria sullo slancio spontaneo della classe, piuttosto che una dinamica autoriflessiva prodotta proprio da quello slancio. Il momento fugace viene così perso e i simboli sono lasciati a bruciare da soli. Esploro le ramificazioni di questo problema per la politica negli Stati Uniti in Hinterland: America’s New Landscape of Class and Conflict (Reaktion, 2018) ed esamino lo stesso dilemma a Hong Kong nei capitoli 6 e 7 di Hellworld: The Human Species and the Planetary Factory (Brill, 2025). ↩︎
- N.d.T. Nel testo originale il termine utilizzato era subsistence, sussistenza in italiano. Abbiamo scelto di adottare come traduzione “riproduzione sociale” che è un concetto più usuale nel dibattito italiano. I due termini non sono esattamente sovrapponibili: nella letteratura marxista di tradizione anglosassone means of subsistence (mezzi di sussistenza) sono gli elementi alla base della riproduzione della forza lavoro. Il concetto di riproduzione sociale è leggermente più ampio, ma ci sembra che calzi comunque nelle argomentazioni dell’autore. Ci si perdoni questa piccola forzatura. ↩︎
- Il progetto partigiano si riferisce ai tentativi in corso di organizzare una qualche forma di soggettività rivoluzionaria collettiva orientata verso fini comunisti. In altre parole, fa riferimento sia al passato che al futuro della lotta per emancipare l’umanità dalle catene storiche della società di classe e inaugurare un futuro comunista. È quindi vagamente sinonimo di “organizzazione comunista” o “movimento comunista”. ↩︎
- Anche all’interno delle rivolte politiche di massa che superano i limiti della sussistenza espressi sotto forma di interessi concreti, persiste comunque una tensione tra questo eccesso e le sue ragioni espressive. Sfruttando questa tensione a favore dell’espressività, queste fratture politiche vengono soppresse e riassorbite nello status quo. ↩︎
- Marx parla del «Partito dell’Anarchia» e del «Partito dell’Ordine» in una serie di articoli scritti per la Neue Rheinische Zeitung nel 1850, che sarebbero stati poi raccolti in un libro, Le lotte di classe in Francia: 1848-1850, pubblicato da Engels nel 1895 (disponibile online qui). In questa versione cartacea, i termini compaiono nel capitolo 3. Gli stessi termini ricompaiono in opere successive, come Il diciotto brumaio di Luigi Bonaparte del 1852. Il termine “anti-partito” è una mia aggiunta, introdotta in Hinterland (selezioni disponibili qui). ↩︎
- Questo quadro teorico è tratto dall’opera del filosofo politico Michael Neocosmos. Si veda il suo Thinking Freedom in Africa: Toward a Theory of Emancipatory Politics, Wits University Press, 2016. ↩︎
- Tuttavia, la natura al tempo stesso universale e aleatoria dell’evento rende difficile descrivere questo riassetto delle coordinate. Ad esempio, è chiaro praticamente a chiunque che «tutto è cambiato» dopo la rivolta di George Floyd, eppure sarebbe difficile per chiunque spiegare esattamente in che modo le cose siano cambiate o indicarne un singolo esempio. ↩︎
- Per ulteriori approfondimenti su questo argomento, consultare: Phil A. Neel e Nick Chavez, “Forest and Factory: The Science and Fiction of Communism”, Endnotes, 2023. Disponibile online qui. ↩︎
- Più rigorosamente: l’autorealizzazione della “specie” come soggetto, al di là del suo status di apparente fatto biologico che in realtà esprime l’unità materiale dell’attività produttiva umana nella società capitalista. Si tratta della realizzazione, nella pratica, di ciò che il geologo sovietico Vladimir Vernadsky (divulgatore del termine ‘biosfera’) una volta definì speculativamente “noosfera”. L’idea è approfondita in modo più dettagliato in Neel, Hellworld, capitolo 2. ↩︎
Phil A. Neel è un geografo comunista ed autore di diversi libri e saggi. La sua prima opera “Hinterland. America’s New Landscape of Class and Conflict” è una delle più interessanti ricostruzioni della relazione tra catene del valore, geografia politica e composizione di classe negli Stati Uniti che hanno portato alla prima elezione di Donald Trump. In Italia è stato pubblicato di recente da Porfido Edizioni “La foresta e la fabbrica. Contributi ad una fantascienza del comunismo“ con co-autore Nick Chavez. Abbiamo avuto l’occasione di fare una lunga intervista con Neel lo scorso dicembre dal titolo “Un pugno di odio grondante”, la trovate qui.
Immagini di René Burri
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.