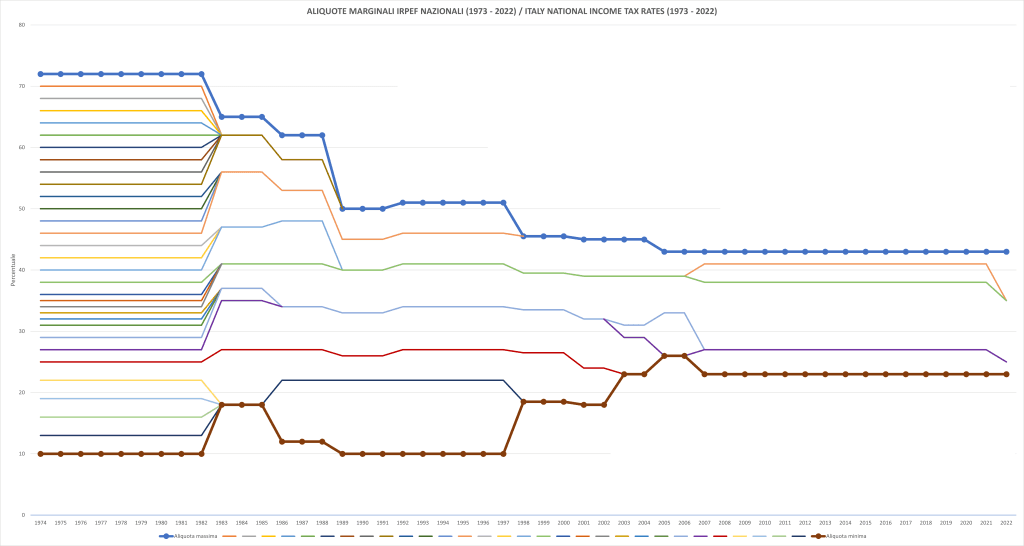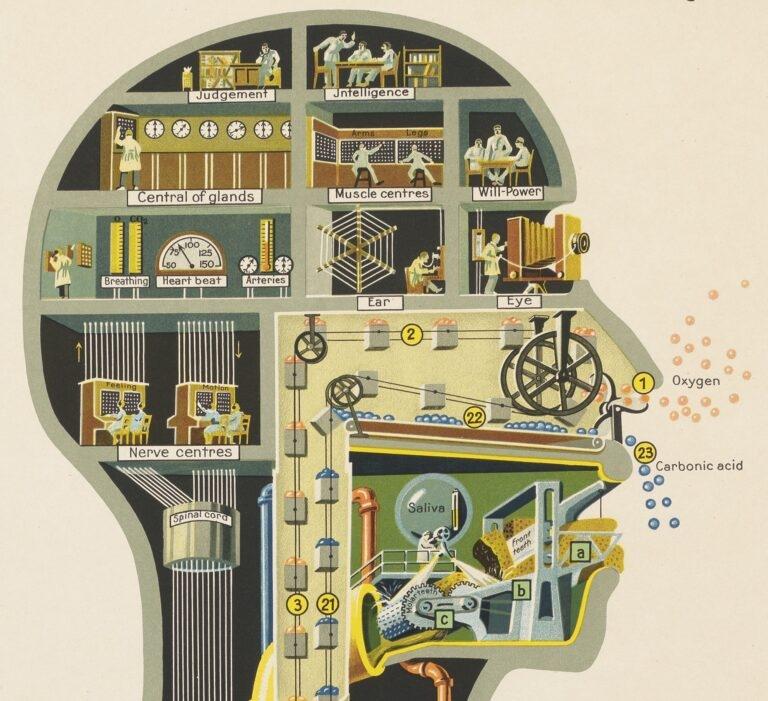
Frammenti di welfare: formare al lavoro nei piani di ripresa post-pandemica
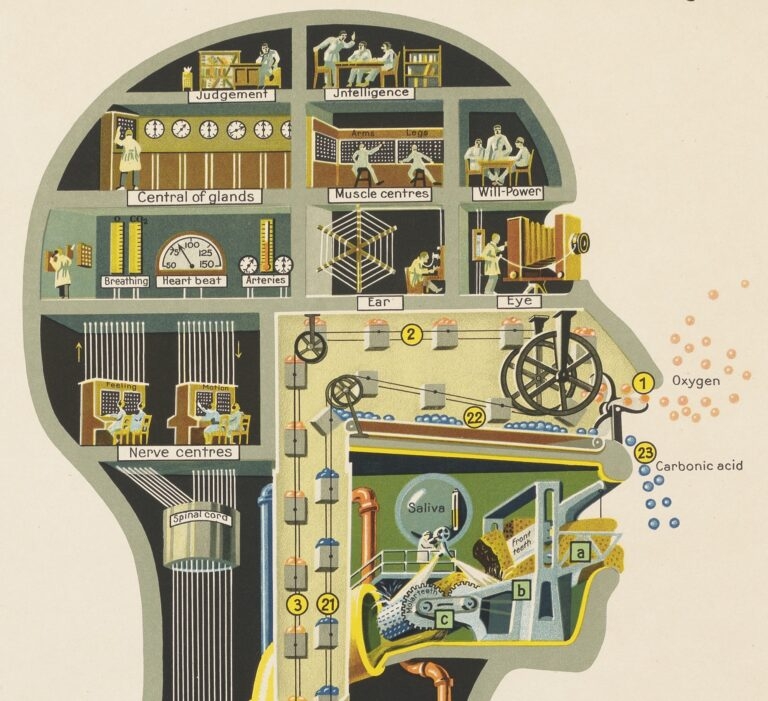
Nell’Europa dei Recovery Plan la formazione è destinata a ricoprire un ruolo centrale nel welfare post-pandemico. Nella corsa dei governi nazionali per accedere ai fondi con cui ristrutturare i propri sistemi produttivi e sociali, il welfare assume il volto di una competizione tra progetti: quelli dei governi nazionali e quelli di lavoratori e lavoratrici alla ricerca di un’occupazione sempre più sfuggente e precaria, che richiede di accumulare costantemente quella condanna che è il capitale umano. Valorizzare sé stessi, aggiornare costantemente le proprie conoscenze e competenze diventa il motivetto che donne, precari e migranti dovranno ripetersi perché questo è il criterio sempre più stringente per accedere a una cittadinanza gerarchicamente differenziata secondo la quota di sapere sociale che ciascuno porta con sé.
Di fronte alla crisi pandemica che ha rimesso al centro del discorso politico la necessità di un intervento pubblico nella gestione della riproduzione sociale, e dunque della capacità di assicurare le condizioni economiche e sociali della produzione, l’Europa pianifica per la prima volta avendo a disposizione dei fondi per farlo. L’obiettivo dei suoi piani però non è una novità, anzi si pianifica quel che resta di un vecchio sogno europeo già perseguito in vari in modi negli ultimi vent’anni: fare della formazione e del lavoro un tutt’uno, legare a doppio filo il welfare con le politiche attive per il lavoro, a cui viene interamente piegata la formazione, normalizzare la precarizzazione rompendo il confine tra pubblico e privato. Non a caso, più che di novità si parla di «recupero»: il Recovery Plan deve recuperare quel progetto che la pandemia ha messo a nudo in tutte le sue contraddizioni. Non si pianifica a partire da un ripensamento complessivo della riproduzione sociale, la cui urgenza è come non mai davanti ai nostri occhi, ma si pianifica per negare tale urgenza, per scongiurare un orizzonte di novità che metterebbe in discussione i vecchi piani. Il welfare, che pure qualche decennio fa ha effettivamente garantito a lavoratori e lavoratrici una qualche forma di assicurazione sulle incertezze del futuro, fa quindi della formazione il suo nuovo abito da cerimonia, che dovrebbe garantire una maggiore occupabilità degli individui attraverso l’erogazione di conoscenze e competenze sempre più specializzate e di fatto frammentate. Un’erogazione che il più delle volte ha poco a che fare con la reale trasmissione di conoscenze. Le vetuste amministrazioni statali – anch’esse da aggiornare e (ri)formare ‒ dovranno quindi veicolare piani transnazionali di riarticolazione dei rapporti sociali addestrando una forza lavoro che dovrà sostenere la «transizione gemella», verde e digitale, che l’Unione Europea promette di intraprendere. La formazione in questo quadro è il re-skilling e l’up-skilling che ci chiede l’Europa: la riqualificazione di una forza lavoro che ha perso il suo tempo a inquinare il pianeta e ora minaccia di resistere al fascino del 4.0. Essa è anche una forma di adattamento imposta alla forza lavoro.
Mettere le mani sulla formazione di giovani e meno giovani – finora perlopiù materia di competenza degli Stati membri – è un’ambizione delle istituzioni europee da diversi anni ormai. A cominciare dal Consiglio di Lisbona del 2000, il Vocational Education and Training (VET) è diventato uno dei punti attraverso cui si snodano le riforme che mirano a rendere più mobile e flessibile la forza lavoro. Nasce in quel contesto, per esempio, l’idea degli individual learning accounts (ILA), dei crediti concessi a lavoratori e lavoratrici «occupabili» per pagarsi la formazione professionale, ovviamente dietro la stretta supervisione di un burocrate. Introdotti in Italia in via sperimentale nel 2006 in alcune province della Toscana, dell’Umbria e del Piemonte, questi voucher per la formazione prendevano il nome di «carta prepagata di credito formativo individuale», con la quale il lavoratore poteva andare a riscuotere la sua parte di formazione presso determinate agenzie.
Restando in tempi non pandemici, BusinessEurope – piattaforma lobbistica di cui fa parte la nostrana Confindustria – raccomandava all’European Social Fund di direzionare fondi e regolamenti destinati a formazione e istruzione verso la creazione di legami più solidi con le imprese, così da evitare che si formassero competenze «inutili» rispetto ai bisogni del mercato del lavoro. Competenze digitali e STEM (scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche) diventano dunque le parole d’ordine della formazione 2.0, dalla scuola primaria all’apprendistato, in un’Europa che ha solo il 6,5% di laureati in discipline STEM contro il 23% dei paesi asiatici.
Nella Proposta di Raccomandazione al Consiglio e nella European Skills Agenda del luglio 2020 emergono nello specifico i vari volti che dovrà assumere la ristrutturazione del welfare associato alla formazione. Si raccomanda in primo luogo l’implementazione dell’ECVET, un sistema di riconoscimento di crediti europei nell’istruzione e formazione. Quindi si avanza la proposta di creare moduli formativi sempre più specifici, «frammentando» in parti sempre più piccole quelle che saranno «qualifiche parziali» e articolandole in «microcredenziali», così da permettere l’aggiornamento costante delle competenze, personalizzandone i contenuti. Nel tentativo di trasformare lavoratori e lavoratrici sempre più, secondo il vecchio adagio, in «imprenditori di sé stessi», si investirà in nuove figure a cui dovremo nostro malgrado abituarci. Per fare un solo esempio: tra le righe dei documenti fanno capolino «insegnanti ibridi» occupati sia nelle scuole professionali sia nelle aziende, così da permettere una «divisione dei costi salariali». Il nome con cui la nuova strategia industriale europea chiama la forma che deve assumere il lavoro per il mondo post-pandemico è quello di «apprendistato permanente», che eleva la precarietà a destino e ne fa un orizzonte insuperabile, permanente appunto, chiudendo ogni possibilità di progettazione del futuro. Individui più competenti, ma sempre e soltanto su un ‘frammento’, possessori di un sapere sempre più parcellizzato e dunque ad alto tasso di obsolescenza.
Queste le poco nobili intenzioni europee. Ma come verranno tradotte in pratica in Italia? Finora il Fondo sociale europeo ha finanziato enti accreditati per la formazione che si sono limitati a erogare corsi perfettamente inutili per la ricollocazione di lavoratrici e lavoratori. Al termine del corso, questi enti si prodigano infatti per ‘contrattare’ con le imprese partner degli stage che forniscono loro forza lavoro a condizioni particolarmente favorevoli, creando un vero e proprio business della formazione, in cui i disoccupati vengono parcheggiati in attesa di tornare merce spendibile sul mercato del lavoro. Il valore dequalificante di questa formazione lo conoscono bene le donne che, soprattutto se migranti, nonostante le alte qualifiche, vengono «formate» per lavori compatibili con il lavoro domestico e familiare, come avviene nei corsi che sono costrette a frequentare durante il percorso di «accoglienza». La formazione non viene però solo appaltata a enti appositi. Le stesse imprese sono incoraggiate a erogare formazione ai propri dipendenti, per la gioia di Confindustria. Non solo le imprese possono accedere al Fondo Sociale Europeo, ma la legge di bilancio 2021 concede un credito d’imposta del 50% a quelle che erogano formazione 4.0. In più, il Fondo Nuove Competenze appena bandito dall’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal) spinge le imprese a dedicare una parte delle ore di lavoro del dipendente alla formazione perché è così che si favorisce la resilienza dei lavoratori. Quelle ore saranno pagate dallo Stato e poi, come già accade, le imprese potranno comunque recuperarle con gli straordinari (magari non pagati). La formazione ce la chiede l’Europa perché, a quanto pare, siamo insieme al Portogallo uno dei paesi UE con il più basso livello di qualificazione per la forza lavoro. Un’affermazione incredibile se pensiamo a quante lavoratrici e quanti lavoratori qualificati italiani trovano lavoro solo all’estero, ma che in realtà rivela la logica di un mercato del lavoro in cui una formazione di alto livello finisce per essere disfunzionale. Non è previsto un sapere che permetta a lavoratrici e lavoratori di liberarsi dalle maglie strette della precarietà dell’apprendistato permanente. Per alcuni, la formazione potrà effettivamente essere il canale d’accesso a lavori meglio retribuiti nei settori industriali emergenti, nonché una valida alternativa a un lavoro già dequalificante. Tuttavia, l’obiettivo con cui si pianifica la formazione non è la qualificazione (che di certo non è stata finora fornita dagli stage), ma la produzione di un sapere sociale medio duttile, multitasking e adattabile alla domanda delle imprese, le cui lamentele sul mismatch – il mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro – altro non esprimono che il malcelato desiderio di un lavoro occupabile secondo le esigenze del momento: un sapere pieghevole per un lavoro pieghevole.
Rendere più efficiente, ovvero più coatta e stringente, la formazione di lavoratrici e lavoratori resilienti è uno dei pilastri del Recovery Plan italiano, nella bozza appena licenziata dal governo. Non a caso essa compare frequentemente nel piano, soprattutto sotto la voce «politiche attive sul lavoro», con cui si punta a superare l’assegno di ricollocazione che, nella sua indeterminatezza, lasciava troppa libertà ai percettori, per stabilire una più minacciosa «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL) e fissare «standard» più esigenti per i beneficiari di strumenti di sostegno al reddito (Dis-coll, NASPI, RdC, CIGS). Detta in soldoni, nessuno deve sognarsi di ricevere qualche briciola senza dare il proprio tempo in cambio. L’obiettivo rimane in fondo quello di accorciare la distanza tra le competenze del lavoro e i bisogni delle imprese. Per farvi fronte sono stati approntati nuovi strumenti pensati soprattutto per le nuove generazioni, quali l’introduzione dell’apprendistato duale, che unisce formazione e lavoro all’insegna di un inquietante motto «imparare sul lavoro» [learning on the job], e il servizio civile universale. Viene cioè rafforzata l’idea di una formazione tutta piegata al valore, nel quadro di una trasformazione complessiva del sistema di istruzione e formazione in una «industry academy» (cit.), che chiama in causa dalla scuola primaria sempre troppo indietro nel fornire competenze digitali fino alle università a cui è chiesto di offrire corsi professionali per disoccupati. Non si tratta però solo di colmare il mismatch, ma di supplire alle debolezze del capitale italiano, e alla sua cronica riluttanza all’investimento, finanziando con i soldi pubblici un’innovazione che, mentre alleggerisce le «responsabilità» del capitale, graverà sempre più sulle spalle di lavoratori e lavoratrici. A queste ultime è destinata una particolare attenzione, poiché la ‘parità di genere’ è criterio trasversale di erogazione dei fondi europei di recupero. Così, per sostenere l’occupabilità femminile, il PNRR prevede l’incoraggiamento di una formazione scientifica per le donne sin dalla giovane età – come se la divisione sessuale del lavoro intellettuale che le spinge verso una formazione umanistica fosse una colpa individuale ‒, fa della formazione permanente una delle risposte all’elevatissima disoccupazione femminile e indica la necessità di conciliare un «riconoscimento del valore sociale dell’attività di cura» con il sostegno all’attività imprenditoriale. Così, mentre milioni di donne dovranno sperare di poter beneficiare dei fondi – ridotti rispetto alla bozza precedente – destinati al rafforzamento di asili e scuole dell’infanzia, i 400milioni di euro destinati al «Fondo Impresa Donna» serviranno a concedere prestiti agevolati e crediti d’imposta ad alcune per trovare la propria emancipazione privata nel ‘farsi impresa’.
I piani nazionali che l’Europa ci chiede devono dunque mettere in conto un cambio di passo nel rapporto formazione-welfare-lavoro, perché adesso le cose si fanno serie e vanno fatte sul serio. Mentre la crescente digitalizzazione, l’automazione e la diffusione del comando degli algoritmi mettono a rischio il 14% dei posti di lavoro a bassa formazione nel manifatturiero e nella vendita al dettaglio – con punte del 18% solo nel primo ‒, l’urgenza della transizione verde e l’importanza della digitalizzazione sdoganano lo smart working che allunga la giornata lavorativa per tutti e, in special modo, per quelle donne che hanno visto dentro le mura domestiche assommarsi lavoro riproduttivo e produttivo. Se con la digitalizzazione una quota di lavoro si farà sempre più smart – e forse anche più cheap – il lavoro dequalificato dovrà sempre più fare i conti con i processi di formazione richiesti dal capitale. A guardar bene, non si tratta però solo di dare una spintarella a un mondo dell’industria che si attarda a compiere il salto tecnologico, ma di accelerare dei processi trasformativi che riguardano i canali d’accesso di lavoratori e lavoratrici ai diritti sociali, rafforzando le gerarchie interne alla cittadinanza. Chi vive sotto il ricatto del permesso di soggiorno conosce già molto bene il funzionamento del circuito formazione-precarietà-formazione, dove la quota di salario diretto e indiretto (vedi la voce welfare) che ti spetta dipende dalla tua disponibilità a sottometterti alla coazione al lavoro. La formazione, quando questa riguarda donne e uomini migranti, è infatti una condizione per poter firmare i patti d’accoglienza e ottenere così i documenti e non cadere nell’illegalità. Una costrizione che ha anticipato la trasformazione generale della cittadinanza in atto già da tempo, dove l’accesso alle prestazioni sociali dipende dalla propria disponibilità a ‘integrarsi’ partecipando a percorsi di formazione palesemente inutili quando non sono addirittura un ostacolo al miglioramento delle proprie condizioni.
Formare alla precarietà e dividere la forza lavoro, moltiplicandone le gerarchie all’interno anche attraverso percorsi di formazione e criteri d’accesso al welfare sempre più differenziati sono le mission europee che non troveremo dichiarate in nessun Recovery Plan. I piani europei affermano una logica di fondo: lavoro e formazione devono adeguarsi al comando algoritmico e ai suoi codici e frazioni di codici. Al lavoro è richiesta una formazione permanente che non procuri nessuna conoscenza qualificata e padroneggiabile da chi la possiede, bensì addestri a obbedire ad algoritmi in continuo aggiornamento. A questo sistema che impone un sapere sempre più frammentato e parziale, è necessario opporsi a partire da uno sguardo complessivo sulle trasformazioni della società per individuarne i punti di rottura. Per questo da qui in avanti diventa essenziale indagare le trasformazioni pianificate del welfare – di cui la formazione è un pezzo fondamentale – nel suo momento di riarticolazione transnazionale, con l’intento di individuare le contraddizioni praticabili da parte di chi rifiuta la resilienza che esso impone. Solo a partire da questo sguardo complessivo è possibile creare connessioni tra segmenti di lavoro in formazione altrimenti sparpagliati, per rovesciare i meccanismi di riproduzione della società.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.