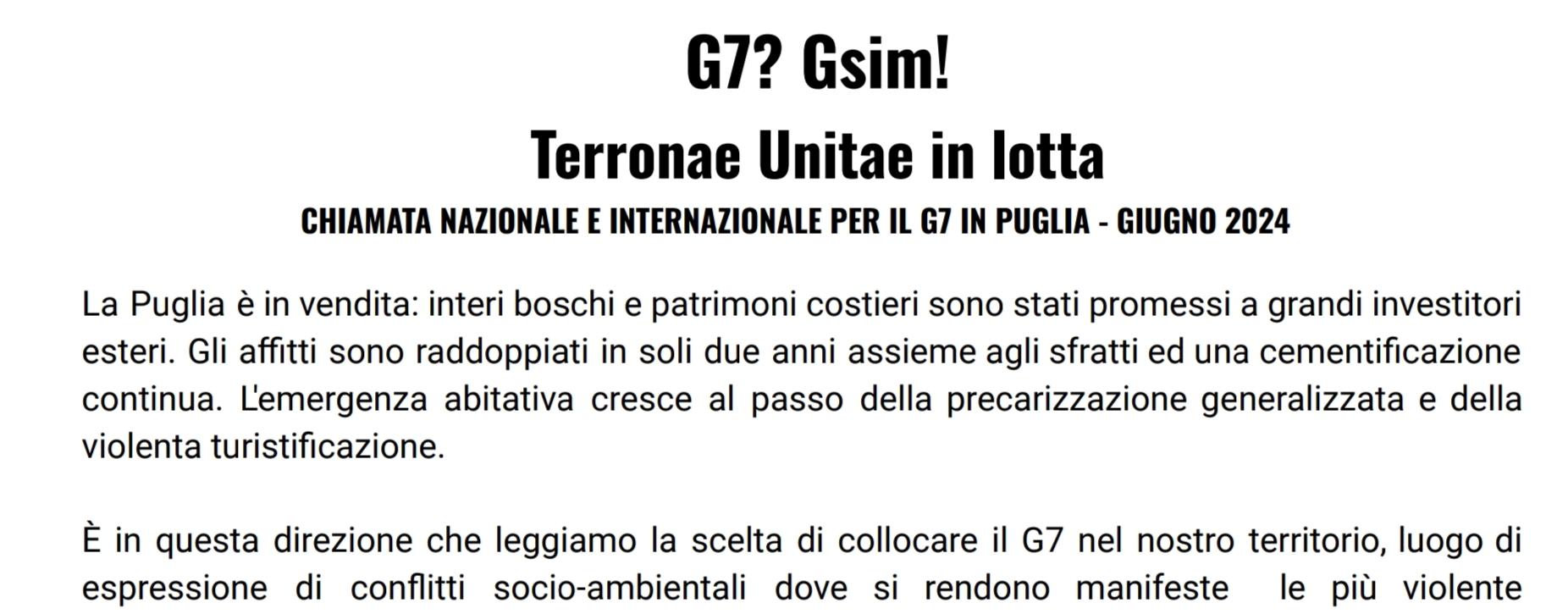La sfida della giustizia climatica

Intervista a PATRICK BOND – di EMANUELE LEONARDI (per Uninomade 2.0)
Contro la COP17 di Durban; oltre i negoziati multilaterali; per un’ecologia politica radicale
Abbiamo incontrato Patrick Bond, direttore del Centre for Civil Society alla University of KwaZulu-Natal e figura di rilievo del dibattito sul cambiamento climatico nel contesto della sinistra globale[1], a Durban, Sud Africa, nel corso della conferenza Dirty Energy Week 2011. Al termine dell’iniziativa si è aperta ufficialmente la mobilitazione contro la COP17, il summit sul clima dell’ONU che annualmente rilancia (o, meglio, tenta di rilanciare) i negoziati internazionali nell’intento di mantenere le previsioni di riscaldamento climatico al di sotto dei 2 gradi entro il 2050. Considerato che l’aumento delle emissioni di gas serra si aggira attorno al 38% dal 1990 ad oggi, il compito sembra più problematico e complesso che mai, sebbene non abbia perso nulla della sua urgenza.
Emanuele Leonardi: Dopo il disastro di Copenhagen nel 2009 e le belle dichiarazioni prive di sostanza rilasciate lo scorso anno a Cancún, cosa ci si può realisticamente aspettare dalla COP17 che inizia in questi giorni a Durban?
Patrick Bond: Permettimi di essere chiaro fin dall’inizio: la COP17 non è nulla più che un imbroglio, un raggiro. Le elites stesse hanno annunciato di non aspettarsi un accordo relativo al taglio delle emissioni prima del 2020, pur sapendo che è proprio di una riduzione significativa che il pianeta ha disperato bisogno. Questa incapacità di raggiungere un accordo è esemplificata dal Green Climate Fund: l’anno scorso Hillary Clinton lo stimava attorno ai 100 miliardi di dollari, ma queste cifre (così come altre di ben diversa entità) non si vedranno mai a causa delle politiche di austerity che vengono implementate un pò ovunque nel Nord globale. Per questo gli Stati-Nazione stanno coinvolgendo sempre più il settore privato: la speranza è che il Green Climate Fund possa venir rimpinguato dai profitti creati nei mercati del carbonio [istituiti nel 2005 con la ratifica del Protocollo di Kyoto] attraverso lo scambio dei diritti di emissione. Ciò significa – ammesso e non concesso che una tale operazione possa avere successo – che si sta privilegiando il lato della mitigazione delle cause del riscaldamento globale rispetto a quello dell’adattamento ai suoi effetti. Da questo punto di vista i paesi cosiddetti “sviluppati” rifiutano addirittura di riconoscere il debito ecologico nei confronti dei paesi “in via di sviluppo” (specialmente dell’Africa, dove le vittime dei mutamenti del clima si contano a decine di migliaia), debito che pure hanno innegabilmente contratto nel corso degli scorsi due secoli. Insomma, si tratta di un disastro totale. E resteranno delusi coloro che ancora percepiscono l’ONU come sede adatta a questo tipo di negoziati: anche stavolta non ci sarà alcun accordo vincolante.
Questa tuttavia è solo una parte dello scenario che ci troviamo di fronte: l’altra è molto più interessante! Siccome le elites (il famoso 1% attaccato dal movimento Occupy) che si rinchiuderanno nell’International Convention Centre hanno già dimostrato – e nuovamente dimostreranno – di non essere all’altezza del compito urgente che il pianeta gli pone innanzi, è tempo che il movimento per la giustizia climatica intervenga senza intermediazioni e imponga le sue soluzioni all’attenzione generale. Occorre trasformare alcuni settori chiave della nostra economia (trasporti, produzione di energia, trattamento dei rifiuti, ecc.) in modo tale che divengano sempre meno dipendenti dai combustibili fossili e sempre più basati su fonti di energia rinnovabili. Occorre modificare in profondità le fondamenta stesse del nostro modo di produrre ricchezza e di vivere: il consumo materialistico come fine supremo non è sostenibile.
EL: In Europa assistiamo alla convergenza (profonda quanto perversa) di comando politico e potere finanziario. Non hai l’impressione che un fenomeno simile si stia verificando anche nel campo delle politiche di contrasto ai mutamenti climatici? Mi riferisco in particolare al privilegio quasi esclusivo accordato allo scambio dei permessi di emissione [carbon trading]. Più in generale, ritieni che questa possa considerarsi una soluzione “reale” ai problemi che dobbiamo affrontare?
PB: La questione della convergenza tra politica e finanza è cruciale per capire l’evoluzione dei negoziati sul clima. Nel 1997, anno di stesura del Protocollo di Kyoto, il vice-presidente americano Al Gore ha ottenuto di inserire il carbon trading nel documento finale, sostenendo che tale meccanismo avrebbe prodotto una distribuzione equa ed equilibrata delle quote di inquinamento. Come funziona il carbon trading? È semplice: i paesi del Nord che intendono continuare ad inquinare mettono in opera un processo di privatizzazione dell’aria che gli consente di acquistare permessi di emissione dai paesi del Sud, ai quali per il momento non è imposto alcun limite di emissione. Per quanto i mercati del carbonio negli USA non abbiano funzionato, il processo di finanziarizzazione del cambiamento climatico è ancora in corso e non sembra destinato ad arrestarsi. Su questo hai ragione: se metti insieme il potere politico accumulato da Wall Street, City of London, Banca Centrale Europea (che manovra il nuovo premier italiano, no?) e la finanziarizzazione dei decisori istituzionali, capisci il perché la COP17 di Durban ha assunto la forma che la contraddistingue. Il punto principale riguarda la speranza (vana) che i mercati del carbonio possano risolvere la crisi climatica, e che addirittura possano farlo eleggendo la Banca Mondiale a proprio organo di garanzia. Altri meccanismi in cui viene dissennatamente riposta fiducia sono i progetti CDM [Clean Development Mechanism] e il programma REDD [Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation]. Robert Zoellick, il presidente della Banca Mondiale, l’anno scorso è persino riuscito a ventilare l’ipotesi che la protezione di specie animali “carismatiche” possa e debba essere demandata ai mercati finanziari. Il risultato è una distorsione irreversibile della politica climatica che la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) è realmente in grado di mettere in atto. I rapporti di forza al suo interno sono, al momento, troppo avversi per essere ribaltati. Insomma: si tratta di un disastro totale.
EL: Il movimento per la giustizia climatica ha rappresentato il primo e più serio oppositore della progressiva finanziarizzazione della politica del clima. Quali sono le peculiarità di questo movimento transnazionale?
PB: Il Climate Justice Movement è un movimento in crescita, vibrante, di grande prospettiva. È emerso sul finire degli anni Novanta per merito in particolare degli attivisti ecuadoregni di Acción Ecológica, che per primi hanno legato il concetto di giustizia alle campagne per il pagamento del debito ecologico (di cui il debito climatico rappresenta una parte). Nel 2000 sono state organizzate le prime conferenze e nel 2004 è stato fondato il Durban Group for Climate Justice. Nel 2007, a Bali, durante la COP13, è avvenuta la fusione tra alcuni movimenti per la giustizia globale e alcune organizzazioni ambientaliste e così a preso vita Climate Justice Now!. Infine, a Copenhagen nel 2009 la Climate Justice Alliance ha incluso in questo processo costituente anche la sinistra europea. Dopo la COP15 danese il movimento si è mostrato in qualche modo refrattario ad una forzata coerenza interna (non c’è alcun comitato centrale al vertice del movimento), ma in compenso continua a comunicare un grande senso di vitalità alla base. Le azioni son vibranti: picchetti contro le raffinerie, manifestazioni di fronte alle miniere di carbone, blocchi delle prospezioni idrauliche [fracking] nei terreni ricchi di gas naturale. Molte di queste lotte hanno avuto successo in aree geografiche anche molto lontane le une dalle altre (ad esempio, dal delta del Niger al West Virginia fino alla Francia). Si tratta di vittorie importantissime perché spesso le lotte sono composte da cittadini ordinari che, molto semplicemente, rifiutano l’estrazione continua di combustibile fossile nelle proprie comunità. Essi chiedono al contrario che si apra una vera, radicale transizione verso una low carbon society. Chiedono ad esempio che i trasporti pubblici urbani non contemplino mezzi alimentati a benzina o gasolio. Chiedono inoltre investimenti consistenti nel solare e, in generale, nelle fonti rinnovabili, le quali possono essere controllate più facilmente a livello popolare.
È lungo queste linee rivendicative che il movimento dovrà costruire, passo dopo passo, una propria unità. Difensivamente, le parole d’ordine riguardano l’opposizione ai procedimenti estrattivi: “leave the oil in the soil, leave the coal in the hole, leave the tar sand in the land”. Anche dal punto di vista offensivo, tuttavia, il movimento per la giustizia climatica propone una serie di trasformazioni: ogni settore economico andrà rivoluzionato in modo da conformarsi ad un mondo post-petrolifero. Ancor più in generale, si tratta di mettere in questione il significato del nesso produzione-consumo, di individuare la nostra fonte di soddisfazione in un modo di vivere meno impattante. Occorre contrastare un modello di vita basato sulla dipendenza da petrolio, in cui il “tasso di infelicità” è altissimo, nonché un sistema segnato in profondità da un degrado finanziario che coinvolge nella sua spirale speculativa individui (perfino le loro pensioni!), governi, e la quasi totalità degli attori economici. Non possiamo permettere che le soluzioni alla crisi attuale non contemplino cambiamenti radicali indirizzati congiuntamente alla politica economica e alla politica ecologica.
EL: Alcuni movimenti sociali, tanto in Europa quanto in Nord America, propongono ormai da qualche anno il reddito di esistenza, universale e incondizionato, come (parziale) soluzione della condizione precaria nel mercato del lavoro. Il movimento per la giustizia climatica ha da poco inserito nella lista dei propri obiettivi prioritari il reddito di base verde [green basic income]. Di cosa si tratta precisamente? Vedi analogie tra i due concetti?
PB: In parte sì. Siccome il debito ecologico deve essere pagato dal Nord al Sud, e siccome occorre rivendicare un milione di posti di lavoro climatici in Sud Africa [One Million Climate Jobs[2]], ma lo stesso potrebbe dirsi per ogni paese, ne consegue la necessità di inquadrare il problema nei termini di una “giusta transizione” [just transition]. Parte cruciale di questa strategia – caldeggiata dai sindacati radicali che si battono contro la precarietà, ma anche contro le condizioni di estrema povertà che sono in drammatico aumento ovunque – è il reddito di esistenza. Tuttavia il problema del green basic income è leggermente diverso: si tratta di un meccanismo volto a scongiurare l’eventualità che il pagamento del debito, da parte del Nord, finisca nelle mani di estremisti neoliberali quali il nostro Trevor Manuel [Ministro delle Finanze sudafricano], il quale certamente indirizzerebbe le risorse verso il settore privato ed i mercati del carbonio. Al contrario, abbiamo bisogno che le risorse partano dal Nord e arrivino direttamente alle comunità del Sud, senza l’intermediazione di governi o multinazionali, né tantomeno di agenzie ibride in cui la corruzione trova ampi spazi. Questo significa indirizzare immediatamente il green basic income verso posti come alcune aree in Namibia, dove sono partite alcune sperimentazioni: circa 100 dollari namibiani al mese (10 euro) vengono erogati direttamente alle donne di un villaggio rurale. Si tratta di un progetto legato agli aiuti allo sviluppo tedeschi, che ha ricevuto la supervisione della Fondazione Rosa Luxemburg, la quale ha opportunamente specificato i criteri di utilizzo di questo denaro. In altre parole, è stata sottolineata la necessità che queste donne vengano messe al corrente di come utilizzare al meglio le risorse al fine di contrastare gli effetti negativi del cambiamento climatico (in fondo, è per questo che il Nord ha contratto un debito verso il Sud). Mi sembra un sistema intelligente per fare in modo che gli autori dei danni ambientali saldino il proprio debito con coloro che ne subiscono le conseguenze negative, senza che questo denaro entri in tasche ben poco interessate alle condizioni di vita delle popolazioni danneggiate.
EL: Alla luce dei limiti invalicabili del multilateralismo della UNFCCC, chi sono a tuo parere gli interlocutori del movimento per la giustizia climatica? In termini più politici, ritieni che l’opposizione Stato/Mercato rappresenti una chiave di lettura ancora valida per comprendere gli sviluppi futuri dell’ecologia politica?
PB: Poni il problema nel modo giusto, anche perché la gran parte dei soggetti che dovrebbero essere nostri alleati (sindacati, comunità locali, ambientalisti) ancora non hanno abbracciato la causa della giustizia climatica perché noi per primi non siamo riusciti ad esprimere concretamente e chiaramente le nostre rivendicazioni. In particolare siamo stati carenti nell’analisi della futura regolazione statale e del modo in cui potrebbero funzionare i mercati. Sono questioni molto complesse. Prendiamo l’esempio di Durban e proviamo a stilare una sorta di programma minimo. Credo abbiamo di fronte cinque aree cruciali all’interno delle quali si giocherà la partita della coscienza climatica e delle politiche di mitigazione e adattamento.
1- Il sistema elettrico. La nostra elettricità viene prodotta attraverso il carbone e venduta a prezzi elevati alla popolazione, mentre alle grandi aziende viene quasi regalata. Tieni conto che una sola azienda utilizza l’11% dell’elettricità prodotta a livello nazionale pagandola un decimo di quanto la pagherebbe un cittadino comune. Inoltre, molte townships ancora non ricevono regolarmente la fornitura di energia, il che ha provocato un numero enorme di proteste e conflitti. Tuttavia il movimento per la giustizia climatica ancora non è stato in grado di tirare le fila e mostrare come i profitti delle grandi aziende vengano tanto dallo sfruttamento del carbone quanto dalle riduzioni dei prezzi. Dobbiamo mostrare che gli abitanti delle townships e gli attivisti climatici combattono una sola e medesima lotta.
2- L’acqua. La lotta per il basilare diritto di accesso all’acqua (troppo spesso negato in Sud Africa) passa attraverso l’integrazione dei sistemi idrici e la demercificazione della loro gestione.
3- La xenofobia. Si tratta di una piaga che purtroppo tende ad allignare tanto nelle file della classe operaia quanto nelle comunità disagiate: i poveri temono che coloro che stanno anche peggio (gli immigrati) gli “rubino” il lavoro. Il problema diventerà ancor più acuto con l’arrivo dei rifugiati climatici, cioè di quelle persone costrette a migrare a causa degli effetti nefasti del riscaldamento globale. Tra l’altro, il Sud Africa è responsabile di un gran numero di danni ambientali in questo continente… In ogni caso, occorre che il movimento per la giustizia climatica sia in grado di disinnescare la bomba xenofoba e si ponga come obiettivo la costruzione di comunità solidali nei confronti delle vittime del cambiamento climatico.
4- L’estrazione di combustibili fossili. Il problema principale riguarda il carbone, ma anche il petrolio sta cominciando a preoccupare: proprio a South Durban si stanno mettendo a punto una serie di prospezioni idrauliche. Il movimento ribadisce con forza che l’estrazione di combustibile fossile non solo non risolve la questione climatica, ma la aggrava. Su questo punto i sindacati sono divisi, ma negli ultimi mesi è cominciato un dibattito vero e siamo convinti di poter convincere i lavoratori che la transizione verso una low carbon society rispecchia i loro interessi molto più che una manciata di nuovi posti di lavoro nelle raffinerie.
5- La disoccupazione. Il legame con il punto precedente è molto forte. Il tasso di disoccupazione in Sud Africa è drammatico e il movimento per la giustizia climatica semplicemente non può ignorarlo. Un milione di posti di lavoro climatici nel settore delle rinnovabili è l’obiettivo che ci siamo dati per persuadere gli operai che affrontare la sfida del riscaldamento globale può risultare molto più vantaggioso (anche e soprattutto in termini di salute) dello status quo industriale. Queste occupazioni, specialmente quelle nel solare e nell’eolico, dovrebbero essere finanziate dallo Stato.
In Sud Africa il movimento della giustizia climatica deve in primo luogo trovare i modi per connettere questi punti programmatici all’interno di una visione unitaria della “giusta transizione”. In altri posti questo lavoro di integrazione è maggiormente avanzato. In America Latina, ad esempio nel Parco Nazionale dello Yasunì[3], il rischio di ripiegamenti identitari di stampo localistico sembra definitivamente superato. Quando si dice leave the oil in the soil si percepisce chiaramente che non si tratta di sindrome NIMBY (Not In My Back Yard), ma piuttosto del Not In My Planet’s Back Yard. In parte è quel che sta succendendo anche nel delta del Niger, dove nel corso degli anni gli ambientalisti che si battono per conservare ne sottosuolo i combustibili fossili hanno cominciato a lottare nell’interesse del pianeta più che nel loro (falso) tornaconto immediato. Si è così passati da una resistenza micro-cosmica ad un’ecologica politica in grande stile che mira a trasformare i rapporti sociali nella loro totalità. Potremmo chiamarla Occupy the Climate. E penso davvero che questo sia il passo successivo, lo scenario prossimo dello sviluppo di questo movimento. Lo spirito democratico che lo pervade è quello della primavera araba, che è poi lo stesso dei precari greci, irlandesi o italiani e quindi anche quello di Occupy Wall Street in tutte le sue ramificazioni. Credo che questi movimenti, che sono per noi fonte di ispirazione, siano pronti per farsi carico della sfida climatica. Sono convinto che saranno con noi il 3 dicembre per il Global Day of Action, per portarci la loro solidarietà internazionale. E sarà un gran bene, perché quando gli occhi del mondo saranno puntati su Durban, bisognerà che essi vedano chiaramente la differenza tra il parlottio disastroso della Conferenza degli Inquinatori [COP = Conference of Polluters] e la creatività radicale e trasformatrice di Occupy COP17 e del movimento per la giustizia climatica.
Maggiori informazioni:
http://conferenceofpolluters.wordpress.com/
http://durbanclimatejustice.wordpress.com/
http://cop17insouthafrica.wordpress.com/tag/occupy-cop-17/
http://durbanknights.wordpress.com/
http://www.climate-justice-now.org/
[1] Nei mesi scorsi, Patrick Bond ha pubblicato i seguenti volumi: Politics of Climate Justice, University of KwaZulu-Natal Press, Durban; Durban’s Climate Gamble, University of South Africa Press, Johannesburg.
[2] Si veda: http://www.climatejobs.org.za/ .
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.