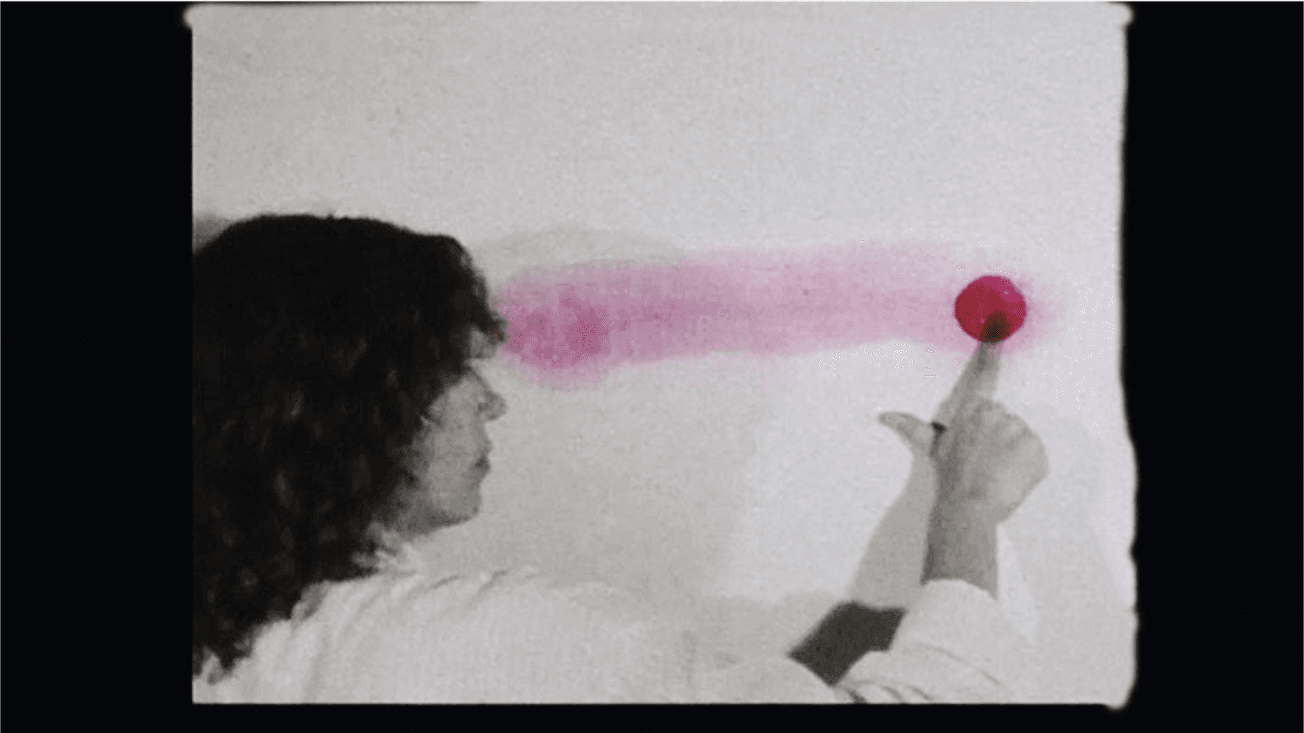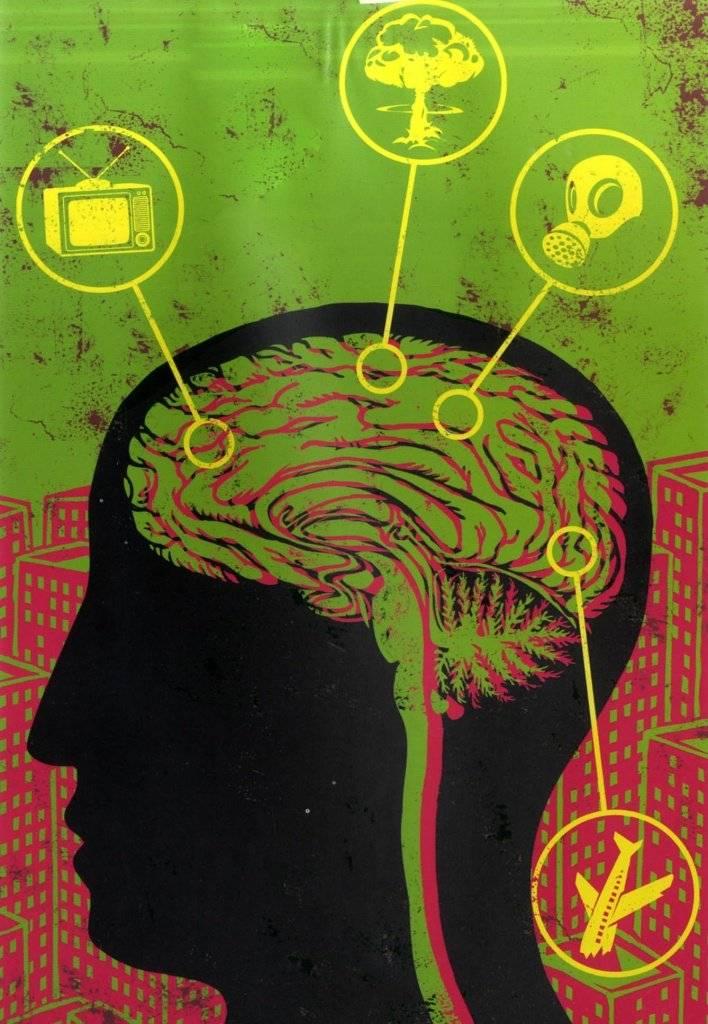
Oltre il primo maggio: dentro e contro la realtà
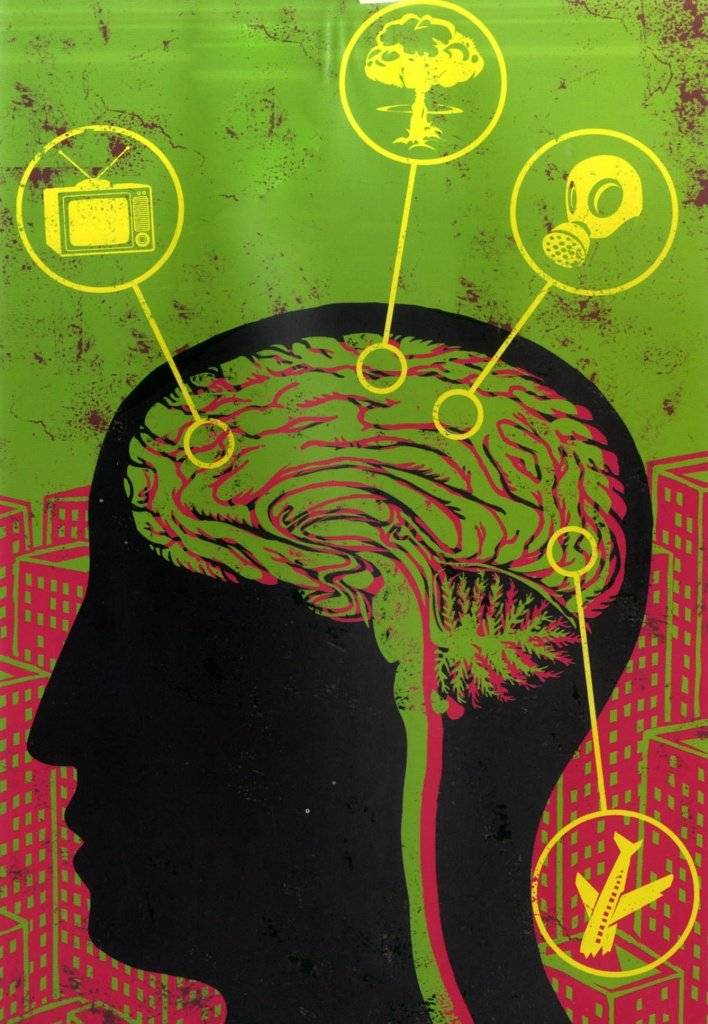
Abbiamo lasciato passare qualche giorno dal primo maggio per seguire il dibattito che ne è seguito, negli ambiti di movimento e sui media. Ci sono spazi in cui i militanti partecipano in modo diretto all’organizzazione e alla presa di posizione, ci sono spazi in cui riflettono e discutono senza l’ansia di schierarsi tatticamente, di dare indicazioni, di trovare soluzioni – l’unico vincolo da cui non si può prescindere, in questi contesti, è di natura etica, dimenticando cioè che vi è un nemico che ha le orecchie dritte per alimentare e utilizzare spaccature o, peggio ancora, messe all’indice di soggetti ben identificati.
Gli uni e gli altri spazi non vanno completamente separati, pena la reciproca autonomizzazione del discorso politico da una parte e della pratica politica dall’altra, così come non vanno confusi, pena la perdita di distinzione tra livelli e temporalità certamente collegate ma comunque differenti dell’agire militante.
L’importante è, quando si parla, situarsi. Commonware, il noi collettivo che qui e su questo livello parla, è un percorso di ricerca, elaborazione e formazione politica che prova ad affrontare i nodi irrisolti e i problemi aperti dei percorsi di lotta. Lo facciamo dall’interno del movimento, inteso qui in senso piuttosto ampio, assumendo quel “noi” più complessivo di chi cerca non solo di interpretare ma innanzitutto di trasformare lo stato di cose presente. Quando parliamo e riflettiamo del movimento, non ci rivolgiamo a un “loro”, ma ci interroghiamo in modo collettivo; se indichiamo un limite, ci chiediamo che contributo possiamo dare per superarlo; se riscontriamo errori o cose che non funzionano, ne assumiamo e condividiamo la responsabilità. Insomma, non ci tiriamo fuori, perché siamo dentro a quello che c’è e si esprime. E se quello che c’è e si esprime non è all’altezza di ciò che è necessario, noi siamo parte in causa del problema. Tra l’essere opinionisti e militanti la differenza è netta, di fondo.
Data questa doverosa premessa di metodo, è difficile non restare sorpresi da chi il giorno dopo ha detto “si sarebbe dovuto…”, scagliandosi contro i supposti responsabili che non l’avrebbero permesso. A prescindere dalla valutazione su quello che proponete, dov’eravate prima mentre si discuteva e perché non avete fatto quel che ritenete andasse fatto? Ecco, questo ci pare il problema, quello che c’era (o non c’era) ed è stato fatto (o non fatto) prima della MayDay No Expo. Suggeriamo allora di cominciare con il rovesciamento della questione che dalle colonne (perlomeno imbarazzanti) dei giornali di sinistra è rimbalzata in comunicati e articoli: il primo maggio milanese (indipendentemente dal fatto che lo si giudichi positivamente o negativamente) non ha determinato la chiusura o l’indebolimento degli spazi politici, ma è semmai la chiusura o la debolezza degli spazi politici ad aver determinato il primo maggio milanese. Cercare altrove le giustificazioni dei propri limiti – di percorso, di discorso, di mobilitazione – è poco utile, oltre che disonesto. È infatti evidente che il primo maggio non vi era nessuno in grado di determinare una espressione unitaria, né della manifestazione, né del discorso. È dunque impossibile “asfaltare” un movimento che, nei termini in cui ne parlano gli irati commentatori della MayDay, non c’è stato. Allora, prima ancora di avviare il dibattito sulle “forme di lotta”, sarebbe opportuno porsi anche altre questioni.
La prima è che la composizione delle MayDay tradizionali è evaporata, e un’altra ancora non si vede. È dunque necessario ragionare sui processi storici e sociali che sottendono tale questione: è infatti difficile non considerare che tra le MayDay dei primi anni Duemila e oggi c’è di mezzo una crisi epocale e permanente, con il suo portato di impoverimento e devastazione sociale. Se quindici anni fa i precari (che allora si sentivano solo in parte tali) vivevano la coda della fase espansiva della globalizzazione, pensando in buona misura di poter giocare a proprio favore i vantaggi della flessibilità, oggi i precari (diventati a tutti gli effetti disoccupati o working poor) si sono visti progressivamente erodere quello spazio di ambivalenza che la flessibilità aveva: oggi è quasi esclusivamente imposizione e ben poco scelta. Perché quell’ambivalenza non era un elemento astorico, ma il prodotto di un rapporto di forza storicamente determinato. La flessibilità è stata la risposta capitalistica alla rigidità operaia e al rifiuto del lavoro. Se allora pensavano di poter recuperare il futuro, oggi dubitano perfino di salvare il presente. Ci sono allora buone ragioni per credere che una parte consistente dei precari non abbia poi più tanta voglia di colore e di fare festa.
Non c’è dubbio che tra il 2000 e il 2005 le MayDay abbiano, insieme ad altri percorsi, contribuito a imporre la questione della precarietà nello spazio pubblico, rovesciando così le retoriche sulle progressive e magnifiche sorti della flessibiltà, ma senza ricadere nell’idea del lavoro “normale” da restaurare propria di sinistra e sindacato (idea che tutto sommato rimane un cardine di opzioni sindacali che pure hanno guardato e guardano con interesse coalizionale verso una parte dei movimenti, come Landini e la Fiom). Tuttavia, dopo essersi riconosciuto come precariato, quel “soggetto” non ha prodotto forme di lotta e organizzazione collettiva all’altezza della sua potenzialità conflittuale. Qui ci sarebbe da approfondire e analizzare, più di quanto non abbiamo finora fatto. Quel “soggetto”, mai omogeneo e forse talora erroneamente considerato tale, è stato ulteriormente frammentato dalla crisi, fino a esplodere in una profonda stratificazione e segmentazione. Oggi, in assenza di un suo ripensamento alla luce di queste trasformazioni e battute d’arresto, il termine precario rischia di appartenere più a una constatazione sociologica che non a una categoria politica.
Vi è stato, da una parte, ciò che si potrebbe definire un processo di industrializzazione del lavoro cognitivo, o comunque di rafforzamento del controllo sulle capacità e sui saperi che vengono mangiati e sussunti dalle nuove forme di impresa capitalistica: la creatività celebrata nelle MayDay o in molti centri sociali “di seconda generazione” era anche un know-how accumulato da molti giovani a metà strada tra attivismo politico e mercato del lavoro. Non è un caso che molti di quegli attivisti si siano collocati nelle industrie creative, della comunicazione e dell’innovazione, a diversi livelli. Oggi quella (ambigua) possibilità è ridotta ai minimi termini: la creatività lascia il posto all’incazzatura o alla depressione e all’isolamento. Insomma, abbiamo avuto la possibilità, a lungo, di giocare sull’ambiguità (e non solo sull’ambivalenza) della condizione precaria, e capitalizzare distorsioni e asimmetrie del modello sociale italiano – portando sul nostro terreno anche frazioni interessate più ad una modernizzazione che liberasse spazi occupati da senior e privilegiati che ad una alternativa radicale. Otto anni di crisi e l’emergere di un gruppo di potere che mostra di voler demolire quei privilegi hanno sciolto in parte l’ambiguità. Una parte di quei precari e dei loro fratelli e sorelle minori si è ridislocata, cercando (e talvolta trovando) canali di affermazione e – più importante – un processo di soggettivazione nelle pratiche di innovazione sociale, nell’economia digitale e nel consumo consapevole e più o meno collaborativo. Forse anche ambivalenti, ma oggi, per essere espliciti, molto più dentro (magari “criticamente”) che contro Expo. Rimangono i precari, più impoveriti che creativi, e quelli rimasti al di fuori di qualsiasi forma d’inclusione, e a quanto pare senza troppa voglia di street parade. Bisogna farsene una ragione. La festa o c’è o non la si può imporre. Lo diciamo in termini di pacata constatazione, non di valutazione. Crediamo però che ogni seria valutazione del primo maggio dovrebbe essere basata anche su questa constatazione.
Questo scenario dovrebbe portarci anche a una riflessione sullo sviluppo e la necessità di rielaborazione di categorie come lavoro cognitivo e general intellect: non si tratta di buttare via quello che abbiamo elaborato nell’ultimo paio di decenni, ma proprio per non buttarlo via dobbiamo analizzare quello che non ha funzionato e, più ancora, i processi storici che costringono a ripensare queste categorie. Ripetere oggi quello che si sosteneva quindici anni fa è il modo migliore per offrire il fianco a chi vuole buttare via tutto. Diciamola così, in modo brutalmente schematico, come appunto da approfondire ed estendere. Le ipotesi sull’espansione della cooperazione sociale come base della produzione del comune si fondavano su un’ipotesi che per comodità definiamo “consiliarista”, ovvero sull’idea per cui i lavoratori cognitivi possono in autonomia mandare avanti la produzione molto meglio del capitale: è l’economia della conoscenza contro il capitalismo cognitivo. Questa ipotesi si reggeva sulla figura di un “lavoratore cognitivo di mestiere”, con tanta passione per i propri oggetti e strumenti di produzione (i saperi), magari precario, con conoscenze da difendere dall’espropriazione capitalistica. Questa figura non è oggi scomparsa, ma certo è assai più marginale e periferica di ieri. E i suoi saperi sempre meno capaci di garantire una sia pure instabile inclusione nelle classi medie destrutturate del nuovo capitalismo in crisi. Le riorganizzazioni nel settore dei servizi (pubblici e privati, ambiti che da tempo condividono linguaggio e scopi), la crisi, l’introduzione di nuovi assetti organizzativi (ciò che potremmo anche chiamare “industrializzazione del lavoro cognitivo) hanno prodotto il passaggio a quello che, sempre per semplificare e per giocare con la storia, possiamo chiamare l’“operaio cognitivo massa” (tranquillizzatevi, nessun soggetto centrale, anche perché senza lotte i soggetti sono al più centrali solo per il capitale): fa un lavoro banale, è impoverito di capacità, oltre che con un salario di merda quando ce l’ha (perché magari va a lavorare gratuitamente per Expo o nelle università, per poterlo mettere sul curriculum o più semplicemente per dare senso alla propria quotidianità e dire ai genitori – e magari a se stesso – che fa qualcosa). Davvero questi operai cognitivi hanno così tanta passione per quello che fanno? Oppure l’accettazione dipende da altre forme di ricatto e da un quadro di aspettative decrescenti? Forse anche da una promessa sempre più aleatoria che diventa soprattutto ricerca di riconoscimento? E se cominciassero a prendere corpo, in modi completamente diversi dal passato e che per ora non sappiamo leggere, delle forme di rifiuto del lavoro? Forse già ci sono, magari sul piano individuale, incapaci di prendere forma collettiva. Rifiuto che certo può diventare nichilismo, così come la passione è diventata autosfruttamento; ma che può essere il motore di nuovi cicli di conflitto di queste figure colpite e prodotte dalla crisi.
Cosa c’entra tutto questo con il primo maggio? Poco, o forse tantissimo. Chi cerca il coworking, la sharing economy e la cooperazione creativa del “quinto stato” ne trova molta tra chi lavora o ha cercato di lavorare per Expo, e probabilmente una parte considerevole idealmente con la spugna in mano a ripulire la città durante la “marcia dei 20.000”. A occhio e croce pochina dentro il corteo, comunque non visibile, in qualsiasi spezzone. È quindi difficile giudicare quello che il corteo avrebbe dovuto essere in nome di un soggetto che era assente, o stava dall’altra parte. Soprattutto, non possiamo innamorarci così tanto dell’idea di una composizione del lavoro cognitivo “naturalmente” orientata in senso anticapitalista da non vederne la materiale dislocazione di campo. Ritorna qui, in forma ampliata e resa ancora più aggressiva dall’evoluzione della crisi, il nodo del ciclo di movimento “occupy” tra il 2011 e il 2013: la combinazione tra un ceto medio declassato e un proletariato no future, con le rispettive e ulteriori stratificazioni interne. Il corteo ci restituisce questo problema, non necessariamente perché dentro di esso trovassero piena rappresentazione questi due macro-strati, ma quanto meno perché erano presenti le loro proiezioni più o meno concrete o più o meno simboliche. Detto questo, non basta prenderne atto, né può essere sufficiente porsi il problema di tenere insieme le cose: bisogna capire se ciò è possibile e se sì in che modo. La ricomposizione, infatti, non è una questione di sommatoria di pezzi, ma di potenziali linee egemoniche attorno a cui il processo può avvenire. È su questo piano peraltro che va declinata la questione del “consenso”, altro termine circolato con insistenza in queste settimane: dovrebbe essere inteso come produzione, appunto, di senso comune, non come progressiva conquista di spazi di benevolenza presso l’opinione pubblica che peraltro ha mostrato in questi anni, anche con il voto, di apprezzare più chi organizza rotture di chi problematizza (in modo diverso Grillo, Renzi, Salvini ci dicono anche questo). Da questo punto di vista, quello che forse non sappiamo ancora cercare adeguatamente è quello che si muove sotterraneamente alla metropoli e che non assume forme collettive, cioè tutti quei comportamenti da cui partire per trasformare il rifiuto in costruzione di autonomia.
Usciamo dalla ripetizione del giudizio sulla fase: cupa o radiosa che sia, è una fase storica, e come tale ha dei nodi e dei compiti politici specifici. Noi dobbiamo capire quali sono i nostri oggi. Per fare questo serve a poco partire dai nostri desideri, da quello che ci piacerebbe; conviene invece partire da quello che c’è, che ci piaccia oppure no. Perché quello che a molti di “noi” piace al momento è piuttosto indifferente a quello che c’è, e viceversa.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.