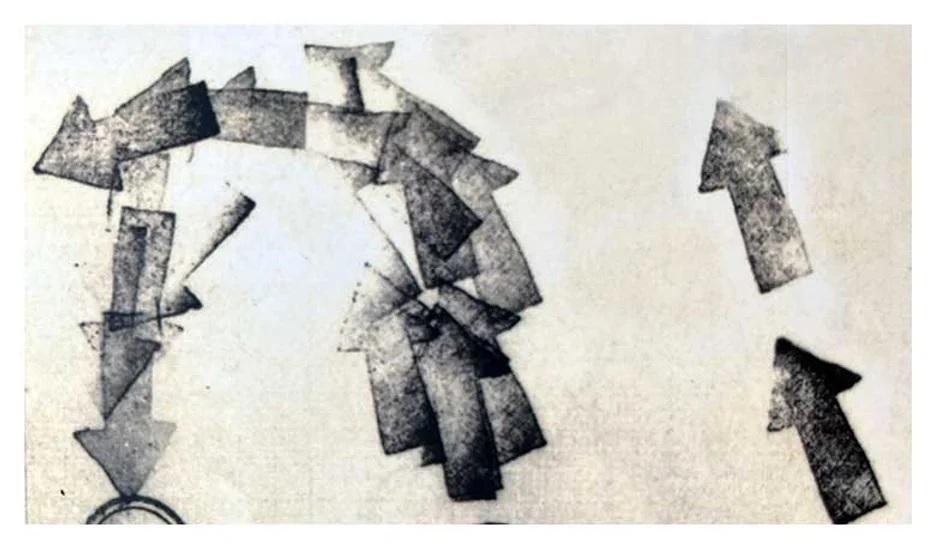
Diario della crisi – Gli spettri del debito cinese
In questa estate infuocata, una possibile tempesta (non solo meteorologica) potrebbe abbattersi sul sistema finanziario globale. Christian Marazzi, in questa nuova puntata del «Diario della crisi» analizza i rischi connessi al possibile scoppio di una bolla immobiliare in Cina. Il crescente indebitamento di alcuni colossi del real estate evidenziano le difficoltà dell’economia cinese a riprendersi dopo i lockdown del Covid. Anche se il sistema finanziario cinese è chiuso e non vi è libera circolazione dei capitali (per loro fortuna), le ripercussioni sui mercati finanziari globali potrebbero essere rilevanti. Tutto ciò si inquadra in un processo di ridefinizione degli assetti geopolitici, stretti tra il tentativo Usa di mantenere l’egemonia economica-finanziaria (sempre più in difficoltà) e l’aspirazione dei paesi Brics di costruire un mondo multipolare.
L’articolo è pubblicato in contemporanea su Effimera e El Salto.
da Machina
* * *
Il superciclo del debito
Intervistato da Eugenio Occorsio sulla crisi cinese («la Repubblica», 19 agosto), l’economista americano Kenneth Rogoff (Harvard) fissa così i termini della questione: «Purtroppo sta verificandosi quanto, con altri economisti come Larry Summers, avevamo immaginato da tempo: il “superciclo del debito”, lo stesso che aveva messo in ginocchio gli Stati Uniti nel 2008 e l’Europa nel 2010, ora si abbatte sulla Cina. Le conseguenze possono essere molto dolorose per tutti». Il premio Nobel Robert Shiller, intervistato sempre da Occorsio il 21 agosto, introduce un altro fattore nella spiegazione della crisi in Cina, per ora circoscritta al settore immobiliare: «A questo punto non rimane che attendere i risultati delle misure d’emergenza approntate a Pechino, compreso il cambio di narrazione. Certo: tutte le crisi mondiali, a partire dalla Grande Depressione del 1929, sono state precedute da fasi di estremo entusiasmo sulle potenzialità infinite di crescita e di innovazione, siano esse le ferrovie o l’intelligenza artificiale. Lo stesso succedeva in Cina. È un comportamento tipico degli esseri umani, non c’è lezione che tenga. Il comune sentire, con le difficoltà di graduare entusiasmo e prudenza, è una componente fondamentale dell’economia, e la Cina ha perso la fiducia». Simone Pieranni, su «il manifesto»del 20 agosto (Il vero pericolo per la Cina è un popolo disilluso), sviluppa ulteriormente questo aspetto: «Dato che i problemi sono sempre gli stessi e che il Pcc ogni volta sembra mettere una pezza alla crisi del momento, bisogna concentrarsi su un terzo aspetto [dopo l’auspicio da parte dell’Occidente di un crollo economico e soprattutto politico, del regime cinese, e dopo il pericolo della deflazione già manifestatosi sul finire degli anni Novanta]: che cosa c’è di diverso oggi e perché questa odierna traballante situazione economica potrebbe essere più pericolosa o meno che in passato. E questo aspetto si incrocia con un soggetto che spesso nelle analisi (tutte geopolitiche o finanziarie) si dimentica: il popolo cinese. Nel 2001, così come nel 2011, i cinesi erano spinti dalla crescita e da quello che alla fine consente all’economia di andare bene: erano fiduciosi nel futuro (…). E così è stato fino al periodo pre-Covid. Dopo, per il popolo cinese, è cominciato un periodo strano: il Covid ha abbattuto l’ottimismo, ha instillato il dubbio che forse non tutto sarebbe stato come prima. E così un popolo risparmiatore di suo ha aumentato questa propensione e oggi è chiaro a tutti: i cinesi non spendono in beni per il futuro (come la casa) ma per l’oggi, per l’ora. Aumentano le spese sanitarie, quelle per l’educazione, ma diminuisce la sensazione di poter programmare il proprio futuro».
Sintetizzando: i giganti dell’immobiliare cinese per decenni hanno costruito a debito, sperando di ripagare i creditori con la vendita degli appartamenti. La ripresa post-pandemia, però, stenta ad ingranare, importazioni e esportazioni sono in calo, si è entrati in deflazione, la disoccupazione giovanile è in forte crescita («Imparate a mangiare amarezza», pare abbia detto Xi Jinping ai suoi giovani), aumentano i pignoramenti di immobili e il rischio d’insolvenza dei mutui. Si parla di «zombificazione» del settore immobiliare, cioè il mancato avanzamento dei progetti di costruzione a causa dell’impossibilità di pagare i costi di costruzione (si prevede che per almeno i prossimi due decenni vi sarà una contrazione dell’attività di costruzione, che rappresenta oltre un terzo del Pil cinese). Si allunga la lista dei grandi gruppi in difficoltà finanziaria, tanto che il «Wall Street Journal», forse incautamente, ha parlato di «momento Lehman». Sta di fatto che in due giorni, i due colossi immobiliari per antonomasia, Evergrande (entrata in crisi nel 2020-22) e Country Garden, hanno svelato i loro debiti accumulati, anche se il primo ha puntualizzato di aver «solo» chiesto la protezione dei creditori in America tramite il Capitolo 15 (un quarto dei suoi 340 miliardi di «attivi» sono stati venduti a investitori americani). La Zhongrong, un venditore di prodotti finanziari con l’equivalente di 108 miliardi di attivo, traballa, così come diversi altri fondi finanziari nascosti nel settore bancario ombra. Sembra di ricordare quanto successo in Giappone negli anni Novanta, con la crisi scoppiata nel settore immobiliare che diede avvio a un lungo periodo di stagnazione e deflazione (definito il «decennio perduto»).
In generale, è il modello di business immobiliare cinese che è entrato in crisi. «Secondo questo modello le società immobiliari o di costruzioni prendevano nuovo debito per finanziare lo sviluppo. Il debito, a sua volta, veniva rimborsato vendendo appartamenti alla classe media [molti costruttori si affidavano ai clienti che pagavano in anticipo prima ancora che il loro appartamento fosse completato]. Lo spazio abitativo medio in Cina era così cresciuto da 7 a quasi 50 metri quadri pro-capite e ha costituito una delle basi del “sogno cinese” promosso da presidente Xi. Ma quando la crisi della classe media ha cominciato a mordere, le vendite di immobili hanno ovviamente rallentato e i debitori non sono più riusciti a ripagare le cedole del debito» (Domenico Siniscalco, I rischi del dominio cinese, «la Repubblica», 20 agosto). È il superciclo del debito di Rogoff, forse anche il cosiddetto Minsky moment, il crollo improvviso dei valori degli attivi alla fine di un ciclo del credito particolarmente espansivo. La crisi è partita dalla classe media, dissanguata dalle politiche zero-Covid, si è poi propagata al debito eccessivo delle società immobiliari e di costruzioni, e ora retroagisce sulla classe media.
Come sempre in questi casi, il governo si trova a un bivio. Lasciare fallire Country Garden, ad esempio, potrebbe scatenare un panico più ampio, innescando una catena di default. Tuttavia – sostiene l’«Economist»– intervenire con un pacchetto di salvataggio metterebbe i funzionari nella condizione di dover effettuare molti altri salvataggi e di sostenere un’industria insostenibile. Per il momento, la Banca centrale cinese, cogliendo tutti di sorpresa, ha abbassato di molto poco (0,10%) il tasso di interesse a un anno (riferimento del credito al consumo), senza però toccare quello a cinque anni (il tasso di riferimento dei prestiti ipotecari), e ha affermato di voler attuare misure di intervento finanziario a sostegno del settore immobiliare solo a partire dal 2024. Il governo ha mandato in venti province squadre di ispettori per esaminare quanto sia grave la situazione del debito delle amministrazioni locali, che proprio dalla vendita dei terreni ai colossi dell’immobiliare avevano fatto una delle voci più importanti delle loro entrate. Insomma, sono ancora poche le misure di stimolo, per il momento sembra prevalere la linea dura contro i responsabili della bolla immobiliare.
Disaccoppiamento?
Ci si chiede quali possano essere le conseguenze di questa crisi sull’economia mondiale. Dal punto di vista della finanza, ci si è affrettati a dire, i rischi di contagio sono limitati o addirittura inesistenti, dato che il settore finanziario cinese è isolato dal resto del mondo. Ad esempio, il renminbi non è convertibile fuori dai confini nazionali e come riserva internazionale conta meno del 3%. E in Cina è vietata la libera circolazione dei capitali. Resta il fatto che i grandi colossi cinesi dell’immobiliare si sono indebitati anche in dollari a Wall Street. Ma, soprattutto, la Cina è un grande (il secondo, dopo il Giappone) acquirente di Treasury Bond americani e dall’inizio del 2023 questi acquisti si sono già ridotti del 12%. «Una crisi conclamata in Cina – sostiene Robert Shiller – non passerebbe inosservata né indolore su tutti i mercati azionari mondiali, così come non lo è stata nessuna delle crisi del passato: dai subprime agli attacchi speculativi contro le tigri asiatiche del 1997, una crisi che tra l’altro per contagio portò al fallimento dei bond russi e al crollo del rublo. In tutto questo non dimentichiamoci che gli investitori cinesi, in massima parte statali, detengono mille miliardi di Treasury Bond americani e consistenti tranche di titoli azionari e obbligazionari di altri Paesi. Ecco, i mercati azionari potrebbero essere la prima vittima se la crisi si aggravasse».
Sono anche gli effetti sui rapporti di scambio a far paura, in particolare per la Germania (grande esportatore verso la Cina) e, di conseguenza, per paesi come l’Italia, dove la mancata crescita tedesca si propagherebbe rapidamente. Insomma, la crisi cinese potrebbe dare il colpo finale all’Eurozona che secondo alcuni economisti è già di per sé a rischio recessione (come sostiene sul «Sole 24 Ore» di domenica 20 agosto Isabella Bufacchi, Dopo la pandemia, guerra e inflazione: Eurozona in autunno a rischio recessione). Anche se Paul Krugman cerca di relativizzare il possibile impatto della crisi cinese sull’economia statunitense, è un fatto che per Pechino l’America resta il primo partner commerciale, con esportazioni negli Usa per 583,6 miliardi nel 2022 e 179 miliardi di import cinese dall’America (in calo del 14% da inizio anno). Importante, soprattutto sotto il profilo geopolitico, è il rapporto commerciale tra la Cina e la Russia: l’interscambio era aumentato del 27% l’anno scorso, e quest’anno è già cresciuto del 41%.
Paradossalmente, visto che a Jackson Hole, al summit delle tre banche centrali (la Fed, la Bce e la Banca d’Inghilterra), la strategia di lotta contro l’inflazione è rimasta identica a quella decisa a marzo dello scorso anno, con tassi d’interesse elevati fino a riportare l’inflazione al 2% (con effetti pesanti sul costo dei mutui e sul credito alle imprese), la crisi cinese potrebbe perlomeno raffreddare le quotazioni delle materie prime come petrolio e gas. Comunque, un colpo alla crescita globale, che andrebbe rovesciato in critica al paradigma della globalizzazione neoliberista degli ultimi trent’anni.
In un certo senso questa crisi rappresenta un test della globalizzazione, soprattutto del rapporto conflittuale tra interessi del capitale globale e interessi politici statuali. Da una parte risulta evidente che ci troviamo tutti in un arcipelago complesso e fortemente interconnesso, in cui i tentativi di decoupling, di disaccoppiamento tra Stati Uniti e Cina, avviati da Trump e reiterati da Biden, si sono per ora rivelati poco efficaci, a tratti autolesionisti. Dall’altra parte, in un quadro cinese di minor crescita, con problemi crescenti di governabilità politica interna, si capisce come la Cina stia spostando la strategia di competizione con gli Stati Uniti dall’arena economica a quella politica. Regolazione economica e governabilità politica sono due facce della stessa medaglia, e oggi queste due facce del potere si declinano necessariamente sul piano globale.
È all’interno di questo quadro contraddittorio, in cui le esigenze del capitale globale confliggono con la ricerca di un’autonomia del politico all’altezza dei conflitti sociali, che vanno lette la riconciliazione protettiva nippo-coreana realizzata dagli Usa a Camp David il 20-21 agosto (difesa anti-missilistica e accordi di intelligence) e, di contro, la sfida lanciata subito dopo dai paesi del gruppo Brics a Johannesburg sotto l’egida della Cina. Si tratta a tutti gli effetti di un nuovo ordine geopolitico, se è vero che il Brics allargato uscito dal summit consterà di 11 paesi, rappresenterà il 32% del Pil mondiale e il 46% della popolazione del pianeta (il Pil del G7 è prossimo al 44% del Pil mondiale. La Cina oggi vale il 16% dell’economia globale contro il 22% degli Stati Uniti). Quanto basta per rimettere seriamente in discussione istituzioni del vecchio ordine mondiale quali il Fondo monetario internazionale, la Banca mondiale e le Nazioni Unite e per procedere sulla via della de-dollarizzazione (qualunque essa sia. Vedi Diario della crisi 2). Proprio quest’anno le esportazioni della Cina verso i paesi in via di sviluppo – rappresentati dai paesi della Belt and Road Initiative – hanno superato le esportazioni verso Stati Uniti, Unione europea e Giappone messi assieme. Attraverso l’indebitamento di una parte importante di questi paesi in via di sviluppo, la Cina è riuscita a «fidelizzarli» politicamente, rafforzando il suo potere di voto all’interno delle più importanti istituzioni internazionali, dall’Onu all’Organizzazione mondiale del commercio.
P.S. Le conclusioni di Christian Marazzi mettono in evidenza le problematiche legate alla transizione da un ordine mondiale unipolare (a guida Usa) ad uno multipolare, in grado di inglobare oltre Usa, Europa, UK anche i paesi Brics. Contemporaneamente, si sono svolti gli incontri del gruppo Brics a Johannesburg e delle Banche Centrali occidentali (Fed, Bce, BoE), che hanno di fatto prodotto un confronto a distanza. Se è chiara la strategia Brics di puntare appunto ad un ordine multipolare, la riunione delle Banche centrali vuole confermare il primato del dollaro sui mercati creditizi e finanziari, l’ultimo ambito (avendo perso quello logistico e militare) che rimane agli Usa per ribadire la sua supremazia economica. In quest’ottica, la decisione di mantenere alti, se non aumentare ulteriormente, i tassi d’interesse sembra essere più finalizzata a mantenere elevato il valore del dollaro (condizione, anche, necessaria per far fronte all’indebitamento interno ed esterno dell’economia Usa) più che a raffreddare un’inflazione già declinante. (A.F.)
* * *
Christian Marazzi, dopo aver insegnato all’Università di Padova, alla State University di New York e alle Università di Losanna e di Ginevra, è diventato docente presso la Scuola universitaria della Svizzera italiana. È autore di numerose pubblicazioni in campo socio-economico e politico; in particolare di saggi sulle trasformazioni del modo di produzione postfordista e sui processi di finanziarizzazione, tra le quali segnaliamo: E il denaro va. Esodo e rivoluzione dei mercati finanziari (Bollati Boringhieri, 1998), Il posto dei calzini. La svolta linguistica dell’economia e i suoi effetti sulla politica (2° ed., Bollati Boringheri, 1999), Capitale e linguaggio. Dalla new economy all’economia di guerra (DeriveApprodi 2002), Finanza bruciata (Casagrande, 2009), Il comunismo del capitale. Finanziarizzazione, biopolitiche del lavoro e crisi globale (Ombre corte, 2010), Diario della crisi infinita (Ombre Corte, 2015) e Che cos’è il plusvalore? (Casagrande, 2016).
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.




















