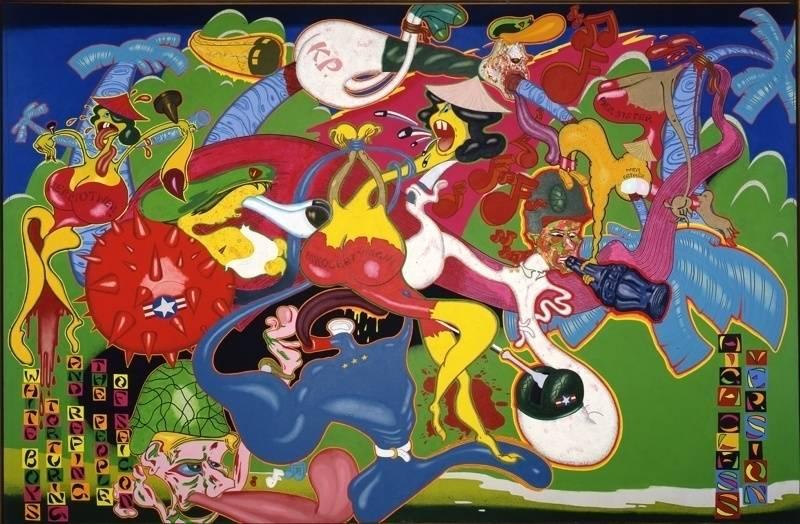
Spine e possibilità della lotta alla corruzione
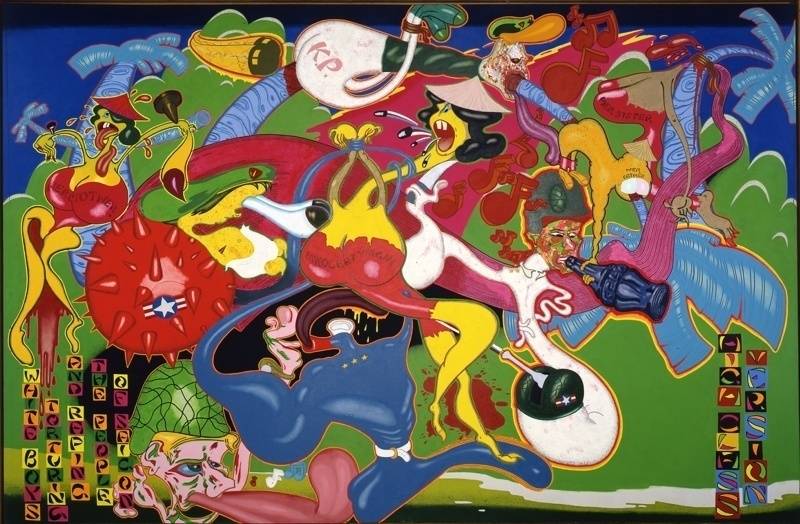
Come il tema religione è troppo importante per lasciarlo ai preti, così il tema corruzione si sta rivelando troppo pervasivo per lasciarlo ai moralizzatori, a questi preti della politica, e volgersi alle “contraddizioni reali”. Bene fa dunque Commonware a richiamare una discussione meno rapsodica e non ideologica sul tema. Nonostante l’incedere della crisi globale, anche la più articolata delle critiche ai limiti tangibili della lotta alla corruzione non riesce a dissolvere da sé il suo oggetto, il rinvio dai casi singoli di corruzione alla corruzione sistemica non elimina l’illusione diffusissima che eliminando le “mele marce” – in particolare oggi: la casta dei politici – il resto può tornare nei binari del normale funzionamento.
È opportuno dunque, come primo passo, provare a cogliere la differenza specifica che connota oggi la lotta alla corruzione come uno dei tratti fin qui persistenti dei movimenti e degli umori sociali in Occidente. Col beneficio d’inventario di analisi più specifiche su singoli contesti e movimenti, qui si abbozzerà qualche ipotesi generale di lettura per mettere a fuoco quella differenza specifica in prospettiva storica dando per assodato l’assunto materialista che in qualche modo – né nitido né risolutivo – la lotta alla corruzione e la coscienza “populista” che la contiene sono espressione della lotta tra classi, o almeno anche di questa.
Se prendiamo le fasi “alte” e di massa del populismo storico tra fine Ottocento/inizio Novecento fino alle espressioni nazional-popolari del New Deal – non riducibili alla mera critica della corruzione politico-finanziaria, va da sé, né tra di loro omogenee – rinveniamo alcune caratteristiche comuni forse utili per il nostro confronto (anche a rischio di generalizzare un po’ troppo). Lì avevamo: la contrapposizione tra la finanza e corruzione politica da un lato e il lavoro dall’altro, un lavoro in gran parte manuale e spesso ancora contadino; un discorso classista con punte “socialiste” (per composizione e obiettivi) che ricopriva però un interclassismo di fondo nella prospettiva politica; movimenti (e organizzazioni) effettivamente “puliti”, non ancora inseriti cioè nei gangli della mediazione politico-sociale capitalistica; la prospettiva della “popolarizzazione” del potere statale per gestire e nazionalizzare, in varia misura, l’economia “reale” (in analogia, del resto, con il programma borghese di controllare e gestire il capitalismo che andava allora sostituendosi al laissez-faire).
In ogni caso, questi tratti si inserivano in una fase ascendente del movimento di classe, il quale non a caso nel mentre se ne demarcava teoricamente e politicamente (v. Lenin) ne poteva in parte riassorbire la spinta interclassista nei momenti più alti dell’antagonismo al capitale, tra rivoluzione russa e primi anni Venti prima che la spinta anticapitalista andasse a esaurirsi. Qualunque sia il giudizio politico e storico che ne diamo oggi, quella complessa fase ascendente fatta di vittorie e sconfitte è andata a costituire nel conflitto quello che con una formula potremmo definire il passaggio capitalistico dalla sussunzione formale alla sussunzione reale. Passaggio di cui New Deal, stalinismo e fascismo sono varianti assai differenti – e anche opposte quanto a connotazioni di classe – ma pur sempre varianti. (Il che spiega talaltro perché l’esito bastardo della rivoluzione russa, lo stalinismo, abbia “riciclato” molti tratti del precedente populismo. Per l’America Latina il discorso è più complesso).
Insomma, l’anima “populista” della lotta di classe si è dapprima variamente rifusa nell’anticapitalismo per poi cristallizzarsi come residuo/rimosso negli strati profondi delle diverse forme di compromesso conflittuale tra proletariato e borghesia all’uscita dal secondo conflitto mondiale che hanno fatto da base ai “trenta gloriosi”: silente ma non del tutto irriconoscibile nelle battaglie del movimento operaio ufficiale (almeno in Europa occidentale) contro i “monopoli” e le presunte tendenze stagnazioniste del capitalismo “reazionario”, a favore della proprietà cooperativa, nelle espressioni culturali nazionalpopolari, ecc. È la fase che apre alla “lotta di classe democratica”, all’acquisizione del ceto medio occidentale alla democrazia welfaristica, alla prospettiva di un’inclusione sociale e politica progressiva e sempre più ampia delle “masse popolari”. Il farsi nazione del proletariato come premessa del suo ingresso nello stato…
Quel residuo populista (ovviamente assai mutato) e tanto più la composizione di classe complessiva sono però usciti radicalmente trasformati dal nesso lotte/sviluppo capitalistico nel boom economico, dal lungo Sessantotto (unico vero momento di rottura con quel populismo latente) e dalla crisi degli anni Settanta. Il passaggio sussunzione formale/reale verso una compiuta società del capitale si è andato definitivamente realizzando con l’estinzione di quei residui sociali non compiutamente capitalistici cui ancora aveva potuto riallacciarsi, ad esempio, la lettura polanyiana della reazione sociale al mercato.
Facciamo un salto agli ultimi trent’anni. La ristrutturazione della relazione classe/capitale, la globalizzazione e finanziarizzazione, ecc. hanno portato in Occidente alle estreme conseguenze quelle tendenze. Nella con/fusione che ne è seguita tra lavoro-vita e impresa, nella trasformazione dello stato, nel venir meno dell’alternativa “socialista” e di ogni riformismo e classismo, e altro ancora, un nuovo “populismo” è riemerso, neanche tanto paradossalmente se vale quanto detto finora. Ma in un ambiente e con caratteristiche consone al capitalismo relazionale e informazionale, o come lo si vuol chiamare, allo strapotere della finanza e della comunicazione, all’intreccio politica-denaro nella governance, ecc. Un “populismo” (se ancora si vuole usare questo termine a questo punto assai insoddisfacente) della piena sussunzione reale – la fase del capitale come comunità materiale anticipata dal Camatte degli anni Sessanta – che inevitabilmente si incrocia con gli ambienti costitutivamente spuri delle nuove soggettività in formazione (e delle vecchie in via di disfacimento).
Nella fase ascendente della finanziarizzazione il tema corruzione è ricomparso solo a sprazzi, in situazioni che parevano “anomale” (tangentopoli in Italia) in Occidente e da ricondurre nell’alveo del buon corso neoliberista, anche ai margini o fuori. Faceva premio la prospettiva di ascesa legata e subordinata alla finanza e alle nuove tecnologie. Ma con la crisi globale quella speranza è letteralmente esplosa. La lotta alla corruzione è così diventata il discorso comune delle mobilitazioni e reazioni alla crisi che non hanno potuto che partire dal terreno dato.
In questo quadro, quali le criticità passibili di ulteriori sviluppi?
Sul piano degli umori e delle reazioni sociali:
– l’interclassismo dell’attuale lotta alla corruzione non ha oggi il minimo richiamo soggettivo a un discorso classista e anticapitalista, ma al tempo stesso è di fatto collocato in termini assai più stringenti di un tempo dentro la sussunzione dell’intera vita al capitale, ovviamente in forme differenziate a seconda dei contesti;
– come risvolto soggettivo, essa sconta però rispetto a fasi passate una debolezza fondamentale: è la reazione immediata e di massa, quasi disperata, alla sensazione di non avere praticabili vie d’uscita dalla crisi, essendosi esaurito qualunque appiglio “esterno” al mercato, ma è anche una reazione che non sa crescere verso la ricerca di una qualche alternativa sistemica perché si accompagna alla inconfessata percezione di questa stessa massa di essere come invischiata nei dispositivi finanziari cui ha “collaborato” e in cui ha riposto speranze di autonomia; di fronte ad essi si trova oggi come disarmata in un paradossale recupero di consapevolezza che è risultato fin qui paralizzante piuttosto che liberatorio;
– in parallelo, è insieme inevitabile e poco convinto il richiamo allo spodestato primato dell’economia “reale” e del “lavoro”, di cui la coscienza comune percepisce l’intreccio inestricabile con la finanza.
A livello di prospettive politiche:
– quanto sopra rende fragile se non inconsistente non solo una ripresa di qualsivoglia neo-keynesismo di sinistra, ma anche ogni discorso neo-polanyista sui beni comuni che non sia (al limite) discorso per il commoning: per la ricostruzione di una cooperazione non mercantile che non può far leva, almeno in Occidente, su alcun “presupposto” non mercificato, tra comunità di lotta in divenire che non possono far leva su alcuna soggettività “pulita”;
– di qui le difficoltà di risposta alla crisi, e non a caso i movimenti che dalla lotta alla corruzione (dei politici, della rappresentanza, ecc.) sono partiti per porre il nodo della “democrazia reale” hanno dovuto scontare, tra i diversi limiti fondati nella materialità della situazione attuale, proprio la presupposizione “spontanea” di piattaforme sociali già date e utili a democratizzare la società e lo stato, il che ha contribuito a lasciare sullo sfondo, quando non a rimuovere, la necessità di un proprio discorso sul potere, sul modo di produrre, sulla società da costruire.
In definitiva si può forse dire che la generalizzazione della lotta alla corruzione è un po’ la spia e la summa di questo insieme di difficoltà che non sono esterne ma interne alle nuove composizioni sociali. Ciò rende questo terreno al tempo stesso vischioso, persistente e però aperto a possibili smottamenti. Non è oggi ancora il segno dell’egemonia stabile di un discorso complessivo forte (di stampo nazionalista?) con cui il capitalismo possa rivitalizzarsi recuperando i movimenti sociali e le reazioni alla crisi; né è un terreno di per sé linearmente favorevole all’anticapitalismo. È piuttosto il segno della rottura dei precedenti equilibri, aperto a diversi esiti possibili.
La prima fase dei movimenti contro la crisi si è conclusa, le varie forme di lotta alla corruzione – ovviamente non esaustive delle molteplici istanze presenti – ne sono state i cahiers de doléance e il vettore di amplificazione del messaggio presso le più ampie masse con effetto di delegittimazione degli assetti costituiti. La prossima fase, anche alla luce di un auspicabile bilancio di quanto fin qui messo in campo, potrebbe approssimare di più il problema del potere e del modo di produrre. Finora abbiamo provato a “sporcarci le mani”, tra poco potrebbe non più bastare. Una discussione ampia sui nodi di “programma”, e non solo sulla “tattica”, che emergono dalla dinamica delle varie resistenze, anche le più spurie, si rende più urgente.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.




















