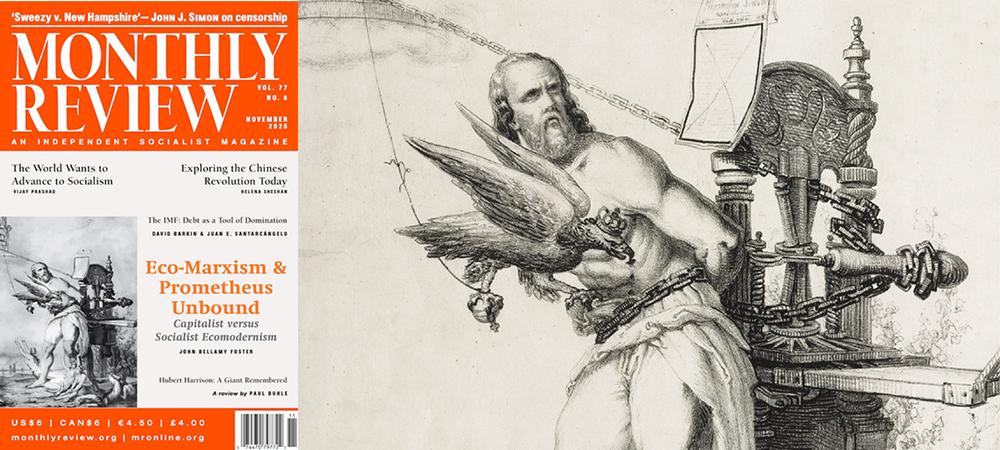Digitalizzazione o giusta transizione?
Sfinimento delle capacità di riproduzione sociale, economia al collasso e aumento del degrado ecologico: di fronte a queste sfide per il settore agricolo non basta il capitalismo verde
di Maura Benegiamo, da Jacobin Italia
Le recenti «proteste dei trattori» hanno evidenziato le tensioni attorno al tema di una transizione ecologica per l’agricoltura industriale. Si è discusso molto della giustezza di misure «green», come la riduzione dei pesticidi, che la Politica agricola comune (Pac) ha recepito dalla strategia Farm to Fork, a sua volta pilastro del Green Deal europeo. Molto meno invece si è parlato della sensatezza di una politica verde che continua a mettere al centro il mercato e l’iniziativa privata piuttosto che una reale pianificazione pubblica che prenda sul serio la proposta di un’agricoltura riparatrice delle sue condizioni ecologiche e del cibo come diritto e bene comune. In questo contesto, le recenti politiche atte a promuovere una transizione digitale del settore agricolo forniscono alcuni spunti utili, seppur situati, per esaminare le contraddizioni insite in questo modello e la relazione tra l’espansione delle forme di estrattivismo agrario e lo sviluppo di un «capitalismo verde». Quest’analisi risponde anche all’esigenza di pensare una transizione giusta per il settore agricolo, in grado di costruire percorsi di convergenza dal basso in un contesto, quello tardo-capitalista, marcato dallo «sfinimento» delle capacità di riproduzione sociale, da un’economia al collasso e dall’aumento del degrado ecologico.
La prospettiva di una «rivoluzione digitale per l’agricoltura» ha infatti suscitato particolare consenso tra i decisori politici all’indomani della crisi alimentare e finanziaria del periodo 2007-2009, finendo per affermarsi come una delle principali strategie di transizione per il settore a seguito della pandemia da Covid-19. Organizzazioni quali la Fao, l’Ocse o l’Unione europea hanno accolto nei loro programmi l’idea che le tecnologie digitali e di precisione, connesse allo sviluppo di un «agrarian data economy», costituiscano fattori determinanti nella transizione verso sistemi alimentari più resilienti, produttivi ed efficienti dal punto di vista sia economico che ambientale. In Europa in particolare, la Pac attribuisce un ruolo centrale alla digitalizzazione agricola che emerge, anche nel dibattito, come lo strumento attraverso cui le imprese potranno raggiungere gli obiettivi del Green Deal. Una visione che il governo Italiano recepisce in pieno, come mostrano anche i nuovi incentivi alla digitalizzazione inscritti nel Pnrr Italiano. Ovviamente si tratta di una «parola d’ordine» tutt’altro che definita, che rinvia a diverse tecnologie e diversi livelli d’applicazione, ma che nella sua versione più «futuristica» si rifà all’idea di agricoltura 4.0, che a sua volta traduce la proposta di un’industria 4.0 formulata dal governo tedesco nel 2013 e divenuta, nel 2016, il tema dell’incontro annuale del World Economic Forum. In questa visione, la «fattoria del futuro» è spesso rappresentata come un’utopia tecnologica in cui sistemi automatizzati e iperconnessi – tra cui trattori a guida autonoma, droni, animali dotati di sensori, serre automatizzate e fattorie urbane verticali – sono gestiti da evoluti software decisionali, dando spazio a una nuova figura di agricoltore digitale, il cui lavoro è reso più facile, più dignitoso e meno gravoso da queste stesse tecnologie.
Un’agricoltura digitale che aumenta lo sfruttamento
In queste rappresentazioni non troviamo invece traccia delle centinaia di lavoratori e lavoratrici agricole, stagionali, spesso migranti, che raccolgono e processano il cibo che arriva sulle nostre tavole; né tantomeno delle loro innumerevoli lotte e richieste. La transizione verso un’agricoltura digitale non sembra essere pensata per loro, semmai contro di loro, come diversi studi testimoniano. Allo stesso tempo però, l’effettiva capacità delle tecnologie digitali di sostituirsi a queste tipologie di lavoro rimane una questione aperta: oggi le ricerche condotte attestano piuttosto un’intensificazione del lavoro agricolo e del suo sfruttamento per queste categorie. Del resto questo è lo scopo già dichiarato nella stessa definizione di macchinari super intensivi e multitasking – dai trattori da usare in campo alle catene di montaggio 4.0 – che offrono la possibilità di svolgere più operazioni contemporaneamente, più velocemente e con maggiori volumi di produzione. Probabilmente vale la pena ricordare ciò che la storia dello sviluppo capitalista ha più volte mostrato, ovvero che scienza e tecnologia, oltre a essere uno strumento di produzione, hanno agito soprattutto come strumento di controllo, disciplina e riduzione della forza lavoro.
Non basta però evidenziare come la promessa di una transizione digitale sia tesa a rafforzare, piuttosto che emancipare, la dipendenza del capitalismo da relazioni di produzione ed espropriazione fortemente diseguali, razzializzate e di genere, incluso nei luoghi stessi adibiti alla loro produzione (dal lavoro semi-schiavistico che addestra l’intelligenza artificiale ed è impiegato nella produzione dei principali devices, all’impatto ambientale diseguale delle infrastrutture digitali). Altrettanto importante è comprendere la relazione tra questi (nuovi) modelli di sfruttamento e gli immaginari sociali veicolati dalle prospettive di automazione e digitalizzazione promosse «dall’alto» .
Gli immaginari tecno-liberali
Nel loro libro Surrogate Humanity: Race, Robots, and the Politics of Technological Futures, Neda Atanasoski e Kalindi Vora esplorano le radici coloniali e razziali che sostengono gli immaginari tecnoscientifici dell’automazione e del futuro del lavoro. Mettendo in discussione il sogno di un futuro post-lavorativo guidato dal progresso tecnologico (una visione spesso condivisa anche nei circoli marxisti), si concentrano sulla promessa, spesso associata a tali proiezioni, di una piena realizzazione della «natura umana», le cui caratteristiche, tuttavia, smascherano il soggetto liberale ed espongono le gerarchie, storicamente coloniali, che sostengono le visioni produttiviste del lavoro:
I futuri tecnologici legati allo sviluppo capitalistico iterano una fantasia secondo la quale, man mano che le macchine, gli algoritmi e l’intelligenza artificiale si impadroniscono del lavoro noioso, sporco, ripetitivo e persino riproduttivo, la piena umanità del soggetto (già) umano sarà liberata per le capacità creative. Anche se i compiti più apprezzati all’interno dei regimi capitalistici di produzione e accumulazione, come il lavoro di conoscenza, diventano automatizzabili, l’obiettivo dichiarato dell’innovazione tecnologica è quello di liberare il potenziale umano (la sua essenza non alienata, o nucleo) che è sempre stato definito in relazione ad altri degradati e svalutati – coloro che non sono mai stati pienamente umani.
Non è quindi un caso che il soggetto al centro della transizione digitale sia una nuova figura di manager-imprenditore, principalmente maschio e bianco, che reitera una visione predatoria del lavoro, piuttosto che riparatrice e di cooperazione che miri a sostenere la riproduzione socio-ecologica.
Una transizione giusta, in grado di scartare questi immaginari tecno-liberali, dovrà piuttosto sviluppare alleanze trasversali e intersezionali tra conoscenze, competenze e molteplici punti di vista situati, per fornire soluzioni tecnologiche alternative che non riproducano le gerarchie razziali e di genere del lavoro svalutato, ma che richiedano piuttosto un impegno con la diversità dei soggetti che sostengono la (ri)produzione capitalista, per promuovere la loro capacità di partecipare ai futuri immaginari del lavoro, realmente liberatori.
Una transizione adatta solo alle grandi imprese
Per quanto riguarda l’agricoltura, e affinché ciò avvenga, è però importante riconoscere come la logica capitalista abbia trasformato questa attività. Nel contesto dell’attuale regime alimentare globale, dominato dalle grandi corporazioni, solo le imprese in grado di intensificare ed espandere la produzione, dentro adeguate economie di scala, possono sopravvivere alle pressioni esercitate a monte e a valle delle catene del valore agroindustriale. Il fenomeno dell’abbandono delle imprese agricole e la loro diminuzione a livello globale mostra come tali prospettive di espansione non siano adatte alla maggioranza degli agricoltori, costretti piuttosto a un’insostenibile corsa all’intensificazione, con conseguente aumento del livello di indebitamento e l’emergere di nuove traiettorie di espropriazione terriera e di espulsione dalle campagne.
Allo stesso modo, e nonostante l’enfasi posta da pianificatori ed esperti sulle strategie digitali per far fronte alla crescente incertezza, alle minacce e ai rischi che attanagliano il mondo agricolo, la fattibilità di un’intensificazione digitale resta un’ipotesi piuttosto remota per molte piccole e medie aziende agricole, incluso nel più ricco contesto occidentale ed europeo. Infatti la prospettiva dell’agricoltura digitale così come viene raccontata (i cui strumenti tecnologici sono per lo più tarati sul modello estensivo-intensivo nordamericano delle piantagioni), sembra conveniente solamente al di sopra di una certa soglia di dimensione aziendale. Si tratta di una prospettiva agro-industriale pensabile solo se diamo per buono l’aumento crescente delle dimensioni delle aziende agricole e della concentrazione fondiaria che caratterizza l’attuale evoluzione del regime agro-alimentare corporativo. Lo stesso regime che priva le agricoltrici e gli agricoltori della possibilità di negoziare un prezzo equo per i loro prodotti e di adottare paradigmi di produzione più ecologici, come quelli proposti dall’agroecologia.
Queste contraddizioni delineano i contorni di un’ulteriore promessa «verde» che sostiene e allo stesso tempo nasconde traiettorie molto più concrete di intensificazione dello sfruttamento e del degrado ecologico.
Una transizione che non ripara
Se infatti questi approcci trasformativi non sembrano adatti alla maggior parte degli operatori agricoli, non lo sono neanche ai territori in cui sono chiamati a operare. Questo non solo perché il modello agroindustriale non ha ancora dimostrato una sufficiente capacità rigenerativa in grado di riparare la frattura metabolica, risanare i suoli e sopperire alla perdita di biodiversità; mentre permane fortemente dipendente dai combustibili fossili per la coltivazione, il trasporto e la commercializzazione dei prodotti. Ma anche perché questi stessi territori su cui si pretende di agire in un futuro indeterminato sono già minacciati o in preda al collasso sistemico: la loro capacità di sostenere la vita sociale è profondamente compromessa da molteplici traiettorie di abbandono, e dagli impatti del cambiamento climatico e del degrado ecologico. Pensiamo ad esempio cosa possa significare una «transizione 4.0» in un contesto come quello italiano, dove urbanizzazione, salinizzazione dei corsi d’acqua, frequenti alluvioni, ondate di calore e siccità stanno già intaccando la capacità produttiva di intere aree rurali e sono all’origine di grandi disastri ecologici, come la doppia alluvione che ha colpito la regione Emilia Romagna tra il 2 e il 17 maggio 2023 e la regione Toscana nel novembre 2023, per fare gli esempi più recenti.
Questi processi mostrano non solo i limiti, ma anche il carattere altamente speculativo ed estrattivista di una transizione verde/digitale che non riparando né rispondendo alle attuali emergenze, accelera la distruzione delle basi socio-ecologiche su cui si fondano le comunità.
Alla luce di tutto ciò, una transizione giusta, in agricoltura come altrove, non può basarsi unicamente su incentivi green, reskilling del lavoro e sostegno alle imprese, con l’idea che sia poi il mercato – con un pò di supporto e indebitamento pubblico – a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Abbiamo bisogno di visioni più ambiziose, capaci di decolonizzare gli immaginari tecno-scientifici e di ripensare il rapporto tra lavoro e metabolismo sociale, ma anche di rimettere i territori e la loro difesa al centro delle rivendicazioni del lavoro, perseguendo una politica dell’attenzione capace di riparare i fondamenti socio-ecologici della convivenza, contro la concreta svalutazione dei mezzi di sussistenza umani e il degrado ambientale perseguito dallo sviluppo capitalista.
*Maura Benegiamo, ricercatrice in Sociologia economica e del lavoro all’Università di Pisa, è autrice del libro La terra dentro il capitale, Orthotes editrice (2021), si occupa di ecologia politica, estrattivismo e transizione ecologica.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.
agricolturaCRISI CLIMATICAdigitalizzazionemaura benegiamoMovimento dei trattoriRIPRODUZIONE SOCIALEsfruttamento