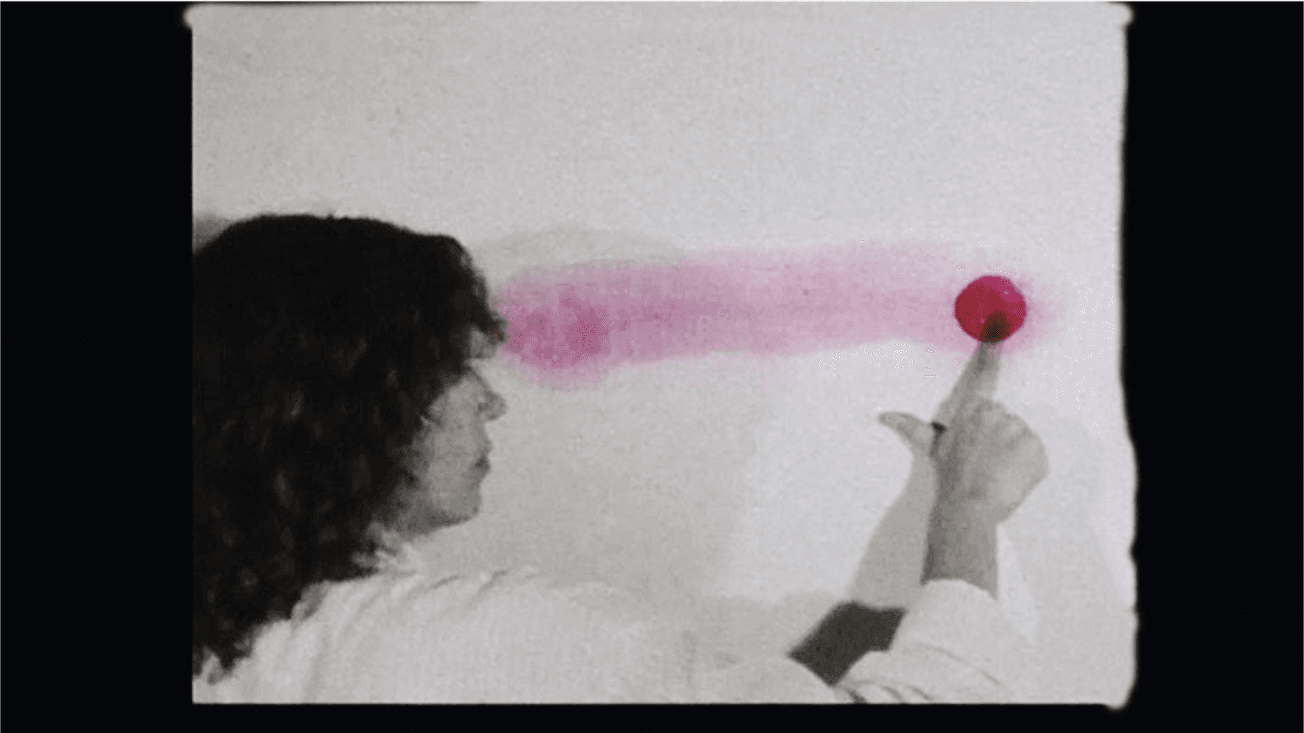La crisi ha il volto delle donne

Violenza di genere e sfruttamento economico, ma anche violenza tra donne che si verifica quando non si tiene debitamente conto del ruolo che gioca la classe e si corre il rischio che solo determinati soggetti con precise caratteristiche di status e razza abbiano visibilità nello spazio pubblico e si facciano portavoce di tutte le donne; violenza dentro e fuori le pareti domestiche e importanza delle modalità di comunicazione di queste forme di violenza sono solo alcuni degli aspetti su cui si concentra l’analisi proposta di seguito per indagare in maniera più approfondita la cosiddetta “questione femminile” ormai nell’agenda di tutti i partiti ma che sicuramente non si affronterà includendo un maggior numero di donne all’interno delle liste.
Pubblichiamo questo contributo tratto dal sito Clash City Workers che intende fornire alcuni spunti di riflessione per un dibattito su violenza di genere e crisi economica.
“La crisi ha il volto delle donne” si trova da qualche parte scritto sui muri. Ed è proprio vero, mai come in questa fase di profonda crisi economica è necessario tornare a riflettere sul nesso tra subordinazione di genere e sfruttamento economico, tra violenza domestica e violenza sui posti di lavoro, tra la “spietatezza” degli uomini – dei mariti, dei padri – e “spietatezza” dei padroni, sul rapporto/scontro di genere in relazione al modo di produzione capitalistico che lo informa e lo impiega a suo uso e consumo. Soprattutto è necessario, di fronte al proliferare dei presunti paladini dei diritti delle donne, all’inserimento – almeno formale – nell’agenda politica di tutti i partiti della “questione femminile”, smascherare alcuni luoghi comuni che non consentono, a nostro avviso, di inquadrare la questione nei termini dovuti.
Confidiamo nel progresso! Ovvero l’emancipazione femminile e l’illusione illuminista
Questa crisi economica ha avuto il merito (sic!) di mettere in luce una delle grandi aporie del pensiero dominante: l’idea che il patriarcato, la violenza sulle donne, la loro esclusione dal mercato del lavoro non fossero che fattori residuali destinati ad assorbirsi, ad essere superati “naturalmente” e in maniera indolore col susseguirsi delle generazioni.
L’idea illuminista di progresso – sulla quale ha fatto perno la borghesia in ascesa due secoli fa – quella dello svolgersi necessario delle forze storiche verso un futuro più radioso, sono idee arrugginite, ma ancora non da buttar via. Se la Storia si fa da sé, allora non serve che aspettare, pazienti, che ogni cosa vada al suo posto: perché ribellarsi? Perché fare forzature?
Il libero mercato sovrappone il suo orizzonte a quello del regno dei cieli.
Così il percorso di emancipazione della donna, la sua fuoriuscita dalle mura domestiche, è stato raccontato, dalle soglie della modernità, dalla rivoluzione industriale del 1700 ai giorni nostri, come una linea sempre crescente: le donne iniziano a lavorare, ad avere un’istruzione sempre più simile a quella dei maschi, acquisiscono i diritto di voto, il divorzio etc. etc.
Durante la prima guerra mondiale, gli uomini erano al fronte e le fabbriche languivano, alle donne fu detto: “siete libere (libere di essere sfruttate of course), uscite di casa, non badate ai bambini, andate a lavorare!”. Salvo poi ricacciarle per altri trent’anni tra le mura domestiche, una volta finita l’emergenza occupazionale causata dalla guerra. Come sostenuto da Carla Filosa nel suo La questione femminile a proposito dell’uso della differenza come “risorsa” capitalistica: “La donna trova la sua libertà proprio nel processo di dissoluzione feudale al termine del quale ha luogo il suo ingresso nel processo sociale lavorativo – per la sola libertà del capitale – (…). Resa eguale all’uomo nella mercificazione della propria forza-lavoro, la donna – già portatrice del fardello dell’inferiorità sociale originata nella sottomissione patriarcale – diviene un prezioso prototipo per l‘indebolimento della capacità contrattuale gettato nelle file della proletarizzazione”. Insomma sebbene l’ingresso nel mondo del lavoro rappresenti una conquista e l’unica chance reale di prendere parola per i soggetti subalterni, il processo di “integrazione” e di “emancipazione” che ne derivano vanno letti come risultato delle lotte vinte, ma anche, al contempo, come legati, per il verso opposto, alla caratteristica pervasività di questo modo di produzione, alla sua tendenza ad inglobare e ridurre a sé ogni possibile “sacca di resistenza”.
Certamente il modo di produzione attuale non ha “inventato” la subordinazione della donna all’uomo (così, e ci si perdonerà il parallelo certo forzato, ma evocativo, come non ha inventato il razzismo), ma ha saputo ben sfruttare l’eredità delle società che l’hanno preceduto, talvolta lasciandone invariati i principi, talvolta, quando l’occasione lo richiedeva, stravolgendoli totalmente (in uno stato razzista come gli Stati Uniti, ad esempio, è possibile, come si è visto, avere un presidente nero o un segretario di Stato donna, a patto che non differiscano in null’altro se non nel colore della pelle e nelle forme da un maschio bianco: devono continuare a fare guerre, a sostenere le lobby di potere, a gestire una società basata sullo sfruttamento e l’esclusione sociale).
Questa crisi mostra dunque con grande chiarezza in quale prospettiva vada letta un’emancipazione che è politica, e non umana, che attiene, nel migliore dei casi, alla forma dei diritti e non alla sostanza, quanto insomma questa linearità sia solo fittizia, come quindi non basti “il progresso” da solo, lo scorrere del tempo a migliorare la condizione delle donne, né quella dei proletari – dei “poveri” – ma che ogni miglioramento reale, lungi dall’essere inserito in una evoluzione spontanea, è sempre frutto di una lotta.
Se in tempi di espansione economica è necessario immettere le donne nel mercato del lavoro (spesso abbassandone così il costo), in tempi di crisi, licenziare una donna è più facile che licenziare un uomo: la donna è sempre in bilico tra il dentro e il fuori, non è, di norma, con il suo stipendio, che la famiglia pensa di dover tirare avanti. Ora, tutti sappiamo che non è affatto così, eppure nel nostro immaginario, costruito ad arte dal capitale, una mamma casalinga è preferibile ad un padre disoccupato, e finché il nostro compagno lavora noi possiamo “accontentarci” di un impiego in uno dei tanti call center (nei quali, non a caso, dopo i giovani, la categoria di lavoratori più diffusa è proprio quella delle donne di mezza età che vi lavorano temporaneamente per “arrotondare”) e di lavoretti saltuari.
Così l’esclusione delle donne dal mondo del lavoro può avvenire in maniere differenti, più o meno soft:
– vengono licenziate più facilmente perché sono in linea di massima tradizionalmente meno organizzate per la lotta, sono culturalmente e socialmente più predisposte ad accettare con rassegnazione il ritorno tra le mura domestiche (benché ci siano, per fortuna, molti esempi che smentiscono questa tendenza);
– vengono assunte con maggiore reticenza (ma questa considerazione è forse, purtroppo retaggio del passato, con il lavoro a tempo determinato vale poco…): assumere una donna comporta degli oneri per l’azienda (permessi, maternità);
– di fronte ad una disoccupazione dilagante molte donne semplicemente rinunciano a cercare e trovare lavoro.
Similmente agli immigrati, le donne giocano un ruolo di primo piano nel cosiddetto esercito industriale di riserva, vengono assorbite ed espulse dal mercato senza soluzione di continuità, spesso vivendo questa estrema precarizzazione della loro esistenza come un destino, addirittura come provvidenziale, essendo gravate anche dal lavoro domestico. Le vite delle donne italiane sono così vite a basso costo: non solo vengono licenziate con maggior frequenza, ma vengono assunte – rispetto ai colleghi maschi – più frequentemente con contratti di lavoro atipici e percepiscono un salario inferiore anche del 20/30% e, nonostante il livello di istruzione femminile sia in media più alto, sono occupate in prevalenza in settori spesso non coperti da ammortizzatori. Essere relegate a lavori temporanei, discontinui, sottopagati, iper-precari rende le donne più ricattabili non solo sul posto di lavoro, ma anche tra le mura domestiche, le costringe in una condizione di marginalità sociale, le rende materialmente dipendenti – e dunque subordinate – al maschio di casa.
Angeli del focolare: il mito della “differenza naturale” e della vocazione al lavoro di cura
C’è ancora qualcuno disposto a sostenere, in pubblico, che “per natura” certi individui sono costituzionalmente e irrimediabilmente “differenti” da altri (e per questo nati e naturalmente predisposti per essere sfruttati, sottomessi, etc.)? Forse ne sono rimasti pochi. Eppure il mito della differenza naturale tra l’uomo e la donna, della predisposizione di quest’ultima alla casa, all’accoglienza, allo stare in coppia, alla maternità, è, nei fatti, duro a morire. Le ragioni di questa persistenza non affondano le loro radici, come potrebbe sembrare di primo acchito, semplicemente nel terreno della cultura, ma sono ben innervate nella struttura (economica, sociale) della nostra società.
La domanda alla quale è necessario rispondere per smascherare questo mito è, come sempre, cui prodest? A chi giova replicare l’immagine della donna come mamma, moglie (o, e lo vedremo più avanti, al rovescio, come semplice oggetto sessuale), come infermiera che ama assistere gli ammalati, come cuoca e serva che adora provvedere alla faccende domestiche, che si identifica nella pulizia dei suoi pavimenti, nell’ordine impeccabile delle sue stoviglie?
Sotto le vesti dell’amore, della propensione, della naturale inclinazione alla cura della casa, degli ammalati, dei vecchi, dei figli, degli “uomini” si nascondono ore e ore di lavoro gratuito (“il tempo di vita viene usato nel tempo di lavoro con cui va ad identificarsi”, C. Filosa, Necessità della differenza), grazie a questo travestimento si tappano le falle di un welfare sempre più sgangherato e ridotto all’osso, finendo per pretendere da se stesse e da chi ci sta accanto di rimediare alle mancanze di uno Stato assente.
È grazie a questo mito, a questo gioco di prestigio, che la donna può essere concepita come naturalmente dentro e fuori dal mercato del lavoro, perché si dà per scontato che ad essa spetti “di diritto” il lavoro dell’amore che “ampiamente glorificato dalle mille voci dell’apparato ideologizzante, altro non è, quindi, che il meccanismo divenuto autoselettivo (cioè culturalmente interiorizzato) di espulsione dalla salarizzazione di un lavoro utile”, (Carla Filosa, La questione femminile).
Questo lavoro volontario e non retribuito si fa tanto più intenso in tempo di crisi:
– La trasformazione del mondo del lavoro e la precarizzazione dilagante hanno abolito de facto – se non de iure – alcuni diritti (permessi straordinari per l’assistenza a parenti malati, disabili, anziani, congedo per maternità etc.) che consentivano di conciliare, seppure sempre a fatica, il lavoro dentro e fuori casa. Anche il part time, un tempo risorsa per i lavoratori – in particolare per le lavoratrici gravate dal lavoro domestico oltre che da quello fuori casa – che avevano specifiche esigenze personali e familiari, mostra, ormai da molti anni, il suo “lato cattivo”: la riduzione dell’orario di lavoro – e conseguentemente della retribuzione – è nella maggior parte dei casi in tempi di crisi (come mostra un recente rapporto dell’OCSE) scelta imposta dal datore di lavoro per abbattere i costi, i dati parlano chiaro: in Italia nel 2011 i part time “involontari” erano 1 milione 557 mila, di cui 1 milione 157 mila firmati da donne.
– Di pari passo la compressione della spesa sociale ha reso sempre più gravosi questi compiti (in assenza di asili nido pubblici – situazione particolarmente pesante al Sud dove le liste d’attesa sono davvero infinite – bisogna accudire i bambini fino all’età scolare; in molte scuole l’assenza di “tempo pieno” rende indispensabile la presenza di un genitore nelle ore pomeridiane, la totale assenza di strutture ospedaliere idonee scarica sulla famiglia la gestione, gravosa anche psicologicamente, di malattie invalidanti dei propri familiari o delle esigenze – mediche e non solo – degli anziani). Il pubblico scarica sui privati cittadini – sulle donne – i suoi oneri e costi.
Un inciso necessario: molto ci sarebbe anche da dire sull’affido (sempre crescente) dei lavori di cura ai lavoratori (in genere lavoratrici) immigrati e sui danni incalcolabili – in termini di disgregazione familiare – che questo affido sta avendo sulle società d’origine delle badanti, infermiere, cameriere che, abbandonando il loro Paese d’origine, vengono a lavorare nel nostro. Non si scappa: se non sono “le nostre” donne ad essere costrette tra le mura domestiche, ad essere imprigionate in casa per mancanza di strutture pubbliche adeguate (come asili, ospedali, scuole), allora saranno le donne di altri Paesi; comprando così – se possiamo permettercelo – la loro fame e riservando per noi la loro “cura”.
Spesso viene ricordata la celebre frase di Simone de Beauvoir “donna non si nasce, ma si diventa”, che altro non significa che ciò che a noi sembra molto immediato concreto e naturale – l’essere donna – è semplicemente un’astrazione, una costruzione artificiale, culturale, ideologica… è per questo che parlare dei rapporti di genere oggi altro non significa che parlare dei rapporti di capitale. Essere donna così non è una condizione fuori dal tempo e dallo spazio, ma una condizione storica, cioè modificabile, transitoria, legata alla società nella quale essa sorge e si consolida e alle sue trasformazioni. La domanda che è necessario porsi a questo punto è dunque cosa diventa la donna in tempi di crisi? Una serva, una lavoratrice che è più facile sfruttare, ricattare, licenziare e, infine, l’oggetto sul quale sfogare, spesso impunemente, ogni frustrazione.
Se non ora, quando? La fiction della violenza sconfitta in tv
Lo accennavamo prima: chi non lavora difficilmente può prendere parola nella trasformazione della società, le donne, sempre più relegate al lavoro di cura o costrette a conciliare il lavoro dentro e fuori casa – senza più spazio per sé – finiscono per ammutolirsi e annullarsi, per divenire prigioniere della loro stessa famiglia.
Della violenza sulle donne – nel caso degli stupri di guerra come dei maltrattamenti inflitti da amici e parenti – bisogna parlare come fenomeno che è assieme economico e sociale. Una donna dipendente economicamente non può ribellarsi, non sa dove andare, non può scappare da chi la perseguita, è in balìa di chi le dà da vivere. Questo, purtroppo, è un fatto. Ci sono delle eccezioni, ma non è sulle eccezioni che si possono basare i nostri ragionamenti. Sessualizzato all’estremo, proposto come strumento di piacere, di cura, come appartenente alla sfera del privato, il corpo della donna si è sempre di più eclissato sulla scena pubblica, della decisione. Entrambi i movimenti – di espulsione dal mondo del lavoro e di mercificazione del corpo e reificazione della donna – contribuiscono a questa esclusione, a questa messa a tacere (di cui le donne, socialmente programmate in tal senso, finiscono spesso per farsi complici).
I meccanismi che innescano e disinnescano il processo di mercificazione e quello di sottomissione delle donne sono stati, mai come in questi ultimi anni, raccontati e mostrati quotidianamente sui giornali e in tv.
I dati che ci vengono offerti fanno paura e ribrezzo: ogni tre giorni in Italia una donna viene ammazzata per mano del marito, del convivente, di un ex. Cento donne ogni anno perdono la vita, spesso tra le mura domestiche, davanti agli occhi dei figli. Le statistiche ISTAT – necessariamente al ribasso visto che quasi mai si denunciano i maltrattamenti subiti per mano di un congiunto – ci dicono che una donna su tre nella sua vita è stata vittima di violenza: guardatevi, guardiamoci attorno, perché una su tre è un numero enorme, è qualcosa con cui bisogna necessariamente fare i conti. Quasi il 10% delle donne è stata stuprata.
È possibile spiegare tutto questo riducendolo ad un problema culturale? È possibile “convincere” gli uomini a non fare violenza alle donne e le donne a denunciare le violenze subite con uno spot in tv? Con una campagna di sensibilizzazione? È possibile aspettare, ancora una volta, che la Storia “faccia il suo corso” e che questi orrori svaniscano come neve al sole solo col passare del tempo?
Facciamo un passo indietro. Alcuni giorni fa ci siamo ritrovati all’università a parlare della funzione della violenza sessuale e del suo utilizzo politico per tentare di dissuadere le donne – in particolare si parlava delle donne egiziane protagoniste delle proteste che hanno scosso quel Paese negli ultimi anni – a partecipare alla vita politica. Ci si dirà che si tratta di un caso estremo, eppure questo caso – tutt’altro che isolato nella storia – qualcosa ci mostra e ci insegna: la violenza sessuale, quale che sia la forma nella quale si esprime, non è mai semplicemente frutto di un raptus, di uno stimolo incontrollabile, ma ha origine e funzione sociale. La subalternità della donna è, per il mercato, un tesoro che va preservato. Alcune, poche, possono sfuggire a questa regola: possono essere delle Merkel, delle Fornero, delle Marcegaglia. Ma nonostante questi modelli ci vengano sempre più insistentemente presentati dalla retorica dominante come gli unici praticabili, essi, oltre a offrirci strade di falsa emancipazione basata sull’assoggettamento degli altri e delle altre, sono percorsi selettivi ed elitari esclusivamente riservati a un ristretto gruppo di donne. Ma la maggior parte no, devono rimanere confinate, proprio come nello stereotipo che spesso ed ingiustamente affibbiamo alle donne mediorientali, all’harem o al focolare, devono essere denudate o velate.
Così, per tornare a casa nostra, pensare di poter trovare la soluzione al fenomeno della violenza sulle donne ignorando o mistificando volutamente la sua origine è una favola pericolosa. Un approccio esclusivamente culturalista deforma la questione privandola di capo e coda, precludendo ogni possibile via d’uscita. Quest’idea, legata strettamente a ciò che si scriveva riguardo all’idea illuminista di progresso, invece di indagare il perché di tali meccanismi e i reali strumenti per contrastarli, dipinge la violenza sulle donne e la loro generale sottomissione come derivante da retaggi o cristallizzazioni esclusivamente provenienti dal passato che investono le donne come soggetto “culturalmente” sottomesso astraendolo dal contesto storico, economico e sociale nella quale sono costrette a vivere. Dire alle donne: ribellatevi, liberatevi, significa impegnarsi nel fornire loro gli strumenti di questa liberazione e ribellione, strumenti che sono materiali, non semplicemente culturali. Alla donna violentata, maltrattata, reclusa vanno offerti gli strumenti per una indipendenza stabile e completa, la sicurezza di una società che la accolga interamente come individuo, e non, parzialmente, come strumento di lavoro (domestico e/o extradomestico). Va offerta una società radicalmente differente nella quale la violenza non solo non sia più lecita, ma soprattutto non sia più funzionale, “necessaria”.
La violenza dell’uomo sulla donna, è stato detto tante volte nel dibattito tra compagni, è speculare a quella dell’uomo sull’uomo, dello sfruttatore sullo sfruttato, ne è la conseguenza e il riflesso, perché ogni forma di subordinazione in questo sistema nasce e foraggia la subordinazione di classe, è già intrinsecamente connessa ad essa. Detto questo, ci sembra che oggi sia fondamentale avere la capacità di accorgersi e tenere all’interno del nostro dibattito la specificità, la “differenza” della quale noi donne siamo portatrici – per storia, non biologicamente – non è un segno di galanteria far finta di niente, come quando si distoglie lo sguardo da una deformità per non imbarazzarne il portatore: abbiamo, come microinsieme nel macroinsieme degli sfruttati, le nostre storie di violenza e di esclusione, fanno parte del nostro corredo e sono una ricchezza, bisogna approfittarne, non ignorarle.
Discutere e combattere la subordinazione della donna all’uomo “semplicemente” come uno degli aspetti della frammentazione di classe voluta dal capitale per intensificare lo sfruttamento e gestire più agevolmente il malcontento sociale non esaurisce il “nostro compito”. Bisognerebbe, senza scadere nell’autoreferenzialità, interrogarsi di più e più a fondo, sforzandosi di non scadere in schematizzazioni semplicistiche. Se riusciremo a portare avanti questa sfida potremmo così equipaggiarci per essere in grado di combattere questa battaglia a 360 gradi, prendendo esempio dal protagonismo costantemente espresso nelle lotte di tutto il mondo nelle quali le donne sono sempre più in prima fila. Affrontare questa sfida, ancora, significa affilare una ulteriore e imprescindibile “arma” nella generale guerra di classe portata avanti per cambiare il mondo e per essere in grado di liberarsi di tutte quelle catene che assoggettano la maggior parte degli uomini e delle donne.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.