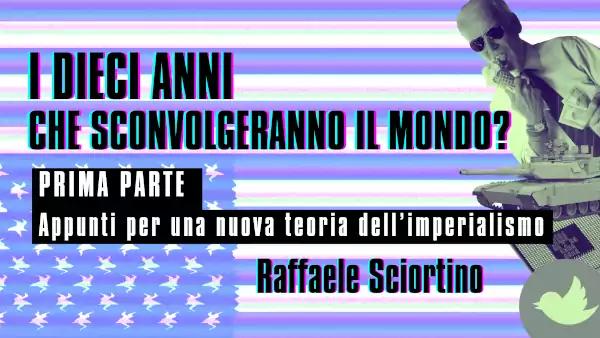Società Nuovi antagonismi e l’asse Tremonti-Lega.
Le prime uscite pubbliche del rinnovato asse Tremonti-Lega, nucleo duro del prossimo governo Berlusconi, rischiano di rimanere un mistero per una sinistra già frastornata dal risultato elettorale. Il duro monito dell’economista antimercatista a Bankitalia “reticente sugli aiuti di Stato” e sulle “nazionalizzazioni” necessarie preannunciano il tentativo di convincere l’Europa dell’utilità di una politica “colbertista” di salvataggi statali delle imprese dalla crisi economica che avanza. Lo stop di Calderoli all’uscita di Montezemolo contro i sindacati -“le condizioni del paese non consentono regolamenti di conti”- dice sì del tradizionale obiettivo leghista di rappresentare la piccola-media impresa contro la tutela ingombrante della grande, ma soprattutto della volontà di evitare gli errori del ’94 che radicalizzando il clima sociale alienarono alla Lega il mondo del lavoro anche “padano”. Una strategia di contrapposizione, sul tipo di quella portata avanti da Berlusconi sull’articolo 18, oggi non solo non pagherebbe in una situazione in cui è difficile raschiare ulteriormente il fondo del barile dei salari, ma neppure sembra rendersi necessaria vista la disponibilità e la “responsabilità” dei sindacati confederali nel consentire al sostanziale smantellamento della contrattazione nazionale e del Pd veltrusconiano a federalismo e politiche securitarie.
Un quadro mutato
La nuova Lega
Giocano qui le profonde differenze della “nuova” Lega con quella degli anni Novanta. Allora l’accento cadeva soprattutto sulle caratteristiche produttive in contrapposizione al parassitismo e allo statalismo, non a caso il Berluska risultava tutt’altro che simpatico alla base. Oggi questo tema rimane solo per essere coniugato contro rom e clandestini, per il resto il leghista del nuovo millennio è anche lui in corsa per speculare sugli investimenti finanziari e, soprattutto, per mungere risorse allo stato, ben oltre il collaudato meccanismo dell’evasione fiscale. Allora la sua esistenza come partito dipendeva soprattutto dalla militanza operaia e popolare “artigiana” (in questo effettivamente simile a forme e temi del Pci ancorché “padanizzati”), una base che non temeva di correre da sola. In questi anni la Lega ha invece progressivamente cambiato il suo target verso gli imprenditori, e in modo molto visibile nei cinque anni di governo con Berlusconi, acquisendo un pragmatismo e un opportunismo da sperimentato carrozzone “romano”. Non per caso nel 2006 buona parte del suo voto operaio l’aveva abbandonata, riconquistato verso sinistra dalla attivizzazione della Cgil per l’articolo 18 e da alcuni conflitti territoriali topici. La delusione per il governo Prodi e, in particolare, per la sinistra negli ultimi due anni ha invece riorientato un flusso elettorale ancora più corposo verso le liste leghiste.
Se dunque in superficie gli aggregati sociali del blocco “nordista” di centro-destra sono fondamentalmente gli stessi degli anni Novanta, sono però cambiati il peso specifico dei singoli pezzi oltreché molti dei contenuti e la prospettiva complessiva. Nella base elettorale profonda vi prevale ora, in ultima istanza, la componente della paura di essere retrocessi dalla condizione sociale di relativo benessere. Non sono i media ad inventare l’insicurezza, essi “si limitano” a dirottarla contro rom, immigrati e micro-criminalità, ma l’ansia per il futuro è alimentata dall’ultimo decennio di globalizzazione e neo-liberismo. Più paura che speranza…
Ma la trasformazione è altrettanto profonda nell’organizzazione del partito e della sua rappresentanza istituzionale. Qui la “nuova” Lega è divenuta essa stessa parte integrante della politica spettacolare postmoderna. Combina alcuni vecchi elementi e forme di aggregazione -buone per creare una mitologia e un folklore di movimento- con i temi fortemente mediatizzati della “sicurezza” e con modalità da tipica “imprenditoria politica” (da quando non scende in piazza con una classica manifestazione come fece ripetutamente negli anni Novanta fin dentro Roma? Come si presenta invece nelle mille piazze locali?). La copertura mediatica, diretta e indiretta, statale e locale, è stata ed è fortissima. La nuova leva di apparato (dopo le purghe anti-movimentiste bossiane) è fatta per lo più da una classe di amministratori ben sperimentata a livello locale che, avendo anche assorbito parte degli ex democristiani e popolari, usa spregiudicatamente le leve del potere locale e gli strumenti amministrativi a disposizione -che di sicuro ora aumenteranno- le ordinanze, i bandi per le case popolari, nonché la rete di legami personali creata dal capitalismo molecolare. Mentre le nuove forme di governance territoriale le permettono di entrare dentro gangli importanti del potere anche economico come le aziende sanitarie, le fondazioni, i consorzi di imprese e servizi, arrivando fino alle associazioni di categoria dei padroncini dei diversi settori. Di “Roma ladrona”, insomma, si sono appresi tutti i segreti del potere, applicati a territori densamente attraversati da flussi globali di ricchezza e dalla messa al lavoro di ogni possibile spazio e tempo di vita. Così, la secessione è più utile farla in maniera soft, anche per non suscitare eccessive aspettative dal basso, e con una buona dose di statalismo in salsa postmoderna.
Fine della vecchia sinistra
Ci sono condizioni esterne e interne che purtroppo aprono concreti spazi all’ipotesi di tenuta del blocco Tremonti-Lega. Il quadro internazionale di crisi dell’unilateralismo Usa, col tentativo statunitense di una exit strategy dal bushismo, e di crisi finanziaria globale che inizia a mostrare i suoi deflagranti effetti sul “mondo produttivo” e sul Sud (food crisis) se non sembra possa a breve realizzare un generale ritorno al protezionismo nazionalistico o anche per grandi aggregati continentali, certo inasprisce la concorrenza tra insiemi territoriali. In un certo senso il vecchio leit-motiv leghista “da soli, senza la zavorra del sud, possiamo farcela” ritorna attuale purché ancorato alla Tremonti alla sponda europea. All’interno, c’è l’enuclearsi al Sud, vedi Sicilia, di forze politiche e sociali che puntano alla ricetta “irlandese” (tassazione zero per investimenti esteri) in luogo del vecchio “assistenzialismo”, e anche il voto in Campania non è stato un buon segnale: ci si poteva aspettare un più alto astensionismo consapevole e di protesta per l’affare monnezza. Ma pesa soprattutto la débacle totale e senza appello della sinistra istituzionale, sommersa da macerie litigiose, e quella prossima dei sindacati confederali per adeguamento al nuovo corso. Se i prossimi cinque anni non saranno facili per lavoratori, immigrati, donne, rispetto alla fase precedente le organizzazioni sindacali e politiche che avevano dato fiato a una resistenza che al di là dei risultati immediati aveva rialimentato una speranza (finita, poi, nelle urne) oggi non sono in grado di ripetere nemmeno in sedicesimo quello che hanno fatto nel 2001-2004. Sono deboli, sconfitti, e soprattutto inaffidabili. Inutili per combattere la “nuova” destra, ingombranti per dare una risposta da sinistra di movimento all’altezza della nuova situazione. E’ bene prendere atto che la sinistra del Novecento è davvero finita, anche in Italia. Quanto prima tanto meglio.
Territori globalizzati e nuovi antagonismi
La Val di Susa e il NoDal Molin, e molte altre iniziative contro la distruzione dei commons territoriali, stanno mostrando che “un altro territorialismo è possibile” a patto di pensarlo e praticarlo come lotta su un territorio compiutamente globalizzato che vuole porsi in cooperazione e non in concorrenza con altre comunità e affrontare temi “comuni” come lo sviluppo e la guerra. Non a caso, dove questo si è dato, la Lega viene messa in difficoltà e costretta a mostrare il suo volto di potere piuttosto che quello di “movimento” a tutela del territorio, di rete leggera di amministratori statali-locali al servizio delle imprese piuttosto che di “partito operaio” radicato. Viene fuori, su tutto, il fatto che il suo radicamento fondato sulla paura e sull’esclusione contribuisce a corrodere piuttosto che a creare legami sociali. Non è affatto il caso di sottovalutare la difficile situazione del momento e le carte in mano alla coppia Tremonti-Lega nel breve-medio periodo né di caricare sulle spalle dei movimenti quello che da soli non possono dare. Ma non dimentichiamo che nella crisi della rappresentanza politica i cambiamenti si fanno verticali e repentini e che il lavoro e il territorio, anche quelli del Nord, non hanno affatto trovato una nuova mediazione stabile in un presunto partito-movimento rinnovato. La Lega non è la risposta finalmente rinvenuta alla crisi della rappresentanza politica e sindacale, anzi il suo successo è segno paradossale che questa crisi va avanti. Credere di rinvenire nel leghismo forme organizzative e radicamento sociale da partito di massa novecentesco revisited e per questo pensare di rispondere rieditando da sinistra, estrema o meno estrema, le vecchie forme e/o simbologie del “partito operaio” è una pia illusione.
Ma, su un altro versante, va anche qualificato e approfondito il senso in cui è possibile mettere in campo “un altro territorialismo possibile”. Territorio infatti è anche lavoro nella sua nuova composizione che vede saltare i confini un tempo netti tra impresa e società, lavoro e vita. Prima e più ancora della nuova qualità “immateriale” del lavoro, è questo il vero salto di qualità nell’attuale rapporto di capitale. Oggi i rapporti di forza e il conflitto passano dalla società al luogo di lavoro e non viceversa. Allora è ineludibile riflettere su come possa riconfigurarsi nella condizione attuale il “fare sindacato” e costruire conflitto, come tentare un piano di elaborazione e azione anfibi, a cavallo tra il politico e il sindacale tradizionali. All’altezza di una condizione proletaria -trasversale alla composizione “vecchia” e nuova- che si gioca non solo in termini di salario diretto ma sempre più sul terreno del debito privato e “pubblico”, della rendita finanziaria e immobiliare, della precarietà esistenziale, del welfare in via di completa mercificazione: in una parola, di quei meccanismi di sussunzione capitalistica del lavoro e dell’esistenza che rendono la riproduzione sociale della forza-lavoro inestricabilmente intrecciati e subordinati alla riproduzione (oramai spesso: distruzione) capitalistica. Il debito per il lavoratore/consumatore diverrà probabilmente quello che è stato il salario per l’operaio massa.
Infine, crisi della rappresentanza politica. La risposta leghista-tremontiana è di concentrazione del potere nei nuovi gangli, di statalismo e istituzionalismo sui generis, che non può alla fine che espropriare i concreti individui sociali. Quella dei movimenti antagonisti è di “disperdere” il potere che hanno contro, come condizione/risultato della riappropriazione della vita sociale. Non l’ultima tra le cause che hanno portato al disastro la sinistra novecentesca sta proprio nel progressivo inserimento nello stato sub forma amministrazione, centrale e locale, al punto da far coincidere la fuoriuscita dalla rappresentanza istituzionale con la presunta fine “extraparlamentare” della sinistra stessa. Ma a differenza del passato, c’è sempre meno possibilità di incontro fra codici opposti, fra lotta e amministrazione statale, fra riproduzione sociale e sviluppo capitalistico. Sta in questa separazione la difficoltà, enorme, del momento, e la speranza, vera, per il futuro.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.