
Urania: 60 anni di intelligenza
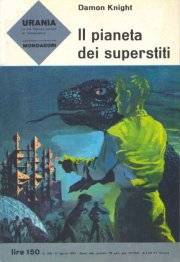
Il secondo romanzo, Il lastrico dell’inferno (fatto, secondo il proverbio, di buone intenzioni), era ambientato in un’epoca futura meno remota. Vi veniva inventata una forma di condizionamento psichico capace di provocare allucinazioni a chiunque fosse sul punto di commettere un crimine. Solo che della tecnica si impadronivano alcune multinazionali, e la applicavano a chi stesse per comperare le merci di un concorrente. In tal modo il mondo si suddivideva in spicchi, dominati ognuno da una corporation e chiusi alle merci rivali. Il romanzo narra la storia di un giovane che non è stato condizionato, e vaga tra le diverse aree mercantili alla ricerca di ribelli come lui.
Leggevo tutto ciò nel 1963, e chi ricordi com’era l’Italia allora capirà la mia felice sorpresa. Nella narrativa corrente, benché stilisticamente più rifinita, c’era poco che somigliasse a tematiche così vaste (pur essendo ancora bambino, rifiutavo i testi concepiti per la mia età). Diventai un lettore affezionato di Urania, mi procurai i numeri arretrati e, col poco che avevo in tasca, quelli in uscita. Fu una lotta durissima e clandestina. Gli insegnanti – ricordo in particolare una professoressa di italiano, al ginnasio – le ritenevano letture scadenti e diseducative. La suddetta docente arrivò a telefonare ai miei genitori per metterli in guardia. Leggevo Urania, ero sulla via della perdizione (in realtà leggevo molto altro, ma non contava).
Quali le colpe della fantascienza? 1) trattava di cose non vere; 2) faceva paura.
In effetti ambedue i capi di imputazione erano fondati. Per fare un esempio, i due romanzi di Damon Knight che ho citato (scritti negli anni Cinquanta) non narravano fatti reali. Lo sarebbero diventati, quale problematica, un ventennio dopo. E la paura c’era, di fronte all’ignoto totale che incombeva su un undicenne italiano riguardo al futuro. Rimasi a lungo paralizzato davanti a un titolo: L’incubo sul fondo, di Murray Leinster. Mi spaventava, non osavo sfogliarlo (quando lo lessi, finalmente, risultò una boiata). Teniamo presente che, in quell’epoca, la gente sveniva di paura alla visione del film La mummia, con Peter Cushing e Christopher Lee.
Un brivido, non tanto di terrore quanto di vertigine, percorse tutta la mia adolescenza e incise senza dubbio sulla mia formazione. Anche le storie più povere e banali contenevano a volte uno spunto geniale, un’idea inquietante, un risvolto sorprendente che induceva a riflettere. Con autori come Philip K. Dick, il mio favorito, si toccava il terreno filosofico; con James Ballard la pura letteratura; con lo scrittore trotzkista Mack Reynolds la critica sociale più aspra e pungente. Né posso dimenticare che fu su Urania che conobbi per la prima volta Mikhail Bulgakov, grazie al racconto Terrore sul kolkhoz (in seguito noto come Le uova fatali).
Ma non voglio soffermarmi su autori noti e meno noti, a me graditi oppure sgraditi. La collana, in confezione non sempre degna (era pessima abitudine di Fruttero e Lucentini accorciare i romanzi per adattarli al numero di pagine ridotto), sprigionava nel suo assieme un senso di libertà dovuto alla moltiplicazione dei futuri possibili, alla nozione di alternativa.
Poi arrivò il giorno del 1994 in cui io stesso fui pubblicato da Urania, evento che cambiò la mia vita. Ma già i mitici fascicoli bordati di bianco, da decenni, avevano modificato il mio modo di pensare, di interpretare il reale, di sognare – in una parola, il mio modo di esistere.
Valerio Evangelisti
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.


















