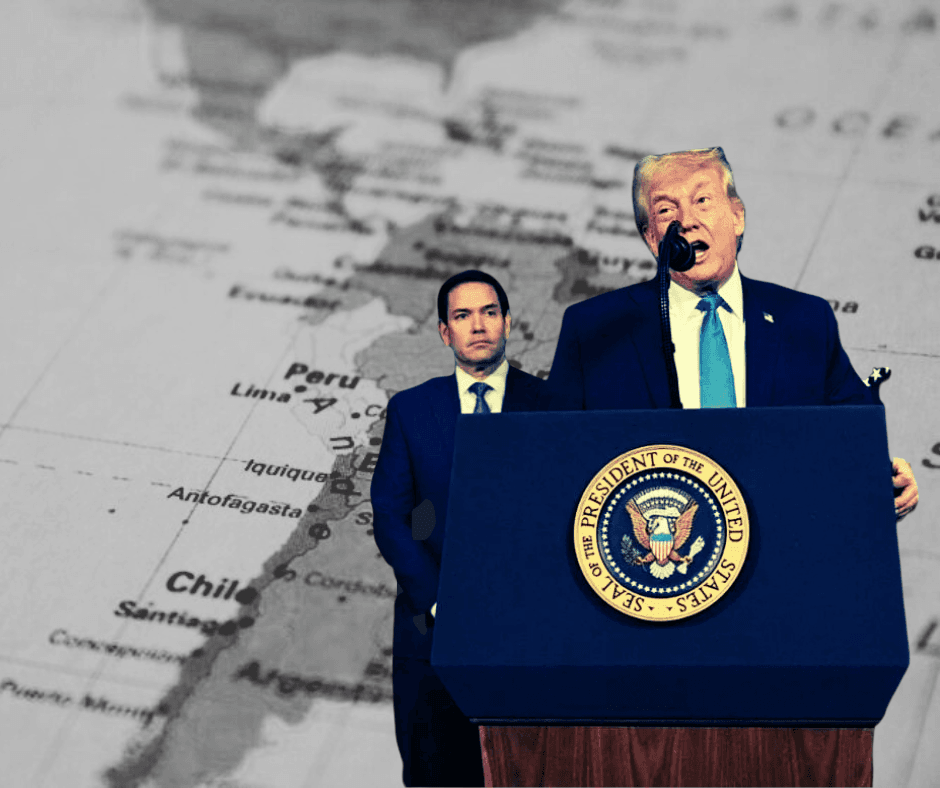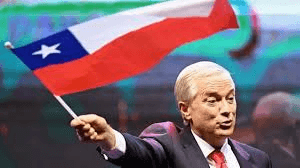Le due sinistre latinoamericane

Sviluppismo contro “vivere bene”? La sinistra latinoamericana deve dare una risposta all’emergenza climatica così come alla necessità di strutturare un progetto di sviluppo distributivo e di integrazione.
Di Alexis Cortés
In un articolo pubblicato nel 2006 che giunse ad essere abbastanza influente, Jorge Castañeda cercò di tracciare una linea divisoria tra i diversi governi di stampo progressista della regione che a quel tempo erano protagonisti del “ciclo progressista” o “onda rosa”. Castañeda distingueva tra due sinistre: una corretta, di carattere moderno, riformista, globale e di mente aperta, e un’altra scorretta, di tradizione populista, radicale, nazionalista, di mente chiusa e con azioni chiassose.
Da quel momento ad oggi, questa distinzione sembra essere mediamente superata, non solo per la capacità che hanno avuto le candidature di destra di togliere le prime magistrature ad ambedue le tipologie di sinistra -colpendo una delle principali caratteristiche del ciclo: la capacità di rieleggersi e mantenersi al potere- ma, soprattutto, per il fallimento di uno dei principali riferimenti dell’ideale “sinistra corretta” nell’analisi di Castañeda. La Concertazione dei Partiti per la Democrazia del Cile è entrata in una crisi terminale che ha finito per consegnare due volte il governo a Sebastián Piñera, di destra, nonostante i suoi tentativi di incorporare elementi più propri di quello che -per Castañeda- sarebbe “scorrettezza politica”, in uno sforzo di rispondere al crescente malessere della popolazione per le conseguenze sociali ed economiche di un neoliberalismo avanzato ed estremo.
Oggi risulterebbe difficile sostenere che un progetto politico che non assuma un chiaro orizzonte di superamento del neoliberalismo possa essere considerato di sinistra. La Rivolta Popolare del 18 ottobre 2019 in Cile è sembrata mettere una palata di sale sul modello che è stato considerato esemplare per la regione: la via cilena al neoliberalismo. Nonostante la promessa dei mobilitati, che il Cile sarebbe “la culla del neoliberalismo, ma anche la sua tomba”, il superamento di questo paradigma, anche se unifica differenti versanti della sinistra latinoamericana, presenta ancora dei nodi critici che rendono difficile la sua traduzione in un modello alternativo. La sinistra nella regione affronta una nuova tensione che la divide.
Vivere bene?
Nel 2011, una serie di articoli pubblicati da Pablo Stefanoni che tratteggiavano quello che ironicamente chiamò come l’esplosione tra “pachamamici” contro quello che i loro detrattori tacciavano come “modernici”, misero in evidenza una delle principali contraddizioni del processo boliviano. Cioè, la lotta nel campo della sinistra locale (ma estensibile alla regione) di due tendenze: un versante neosviluppista ed estrattivista, associato al governo di Evo Morales, e un altro identitario-ambientalista, associato al movimento indigeno e a buona parte dell’intellettualità che ha finito con il rompere con il MAS.
Per Stefanoni, il “pachamamismo”, munito di un atteggiamento di autenticità ancestrale, sembrerebbe più una filosofia prossima ad un “indigenismo new age” che, tra le altre cose, elude i problemi politici dell’esercizio del potere e dello stato, così come le discussioni intorno ad un nuovo modello di sviluppo che riesca a superare l’estrattivismo e la riprimarizzazione. Con le sue parole,
invece di discutere come combinare le aspettative di sviluppo con un eco-ambientalismo intelligente, il discorso pachamamico ci offre una cascata di parole in aymara, pronunciate con un tono enigmatico, e una candida lettura della crisi del capitalismo e della civiltà occidentale.
I momenti costituenti che hanno accompagnato l’insediamento dei governi della Bolivia e dell’Ecuador si identificano con un processo di coincidenza strategica tra queste posizioni che oggi sono diventate sempre più antagoniste. Le magne carte sono estremamente innovative includendo, tra le altre cose, la prospettiva andina del “vivere bene” (suma qamaña in aymara e allin kawsay o sumak kawsay in quechua), ossia, la promozione di un benessere olistico la cui base è l’armonia con la natura e con la comunità.
Nonostante ciò, così come lo riassume Andreu Viola, per quanto positivo sia il cambiamento di comportamento verso valori e stili di vita non occidentali che la rivendicazione di questo termine implica, lo stesso non smette di essere una tradizione che non è riuscita a precisarsi in modo più concreto, rimanendo ambiguamente plasmata nelle Costituzioni. Ancor di più: il “vivere bene” non è riuscito a riflettersi nei piani economici di questi governi progressisti, che hanno mantenuto le visioni economiciste e tecnocratiche dello sviluppo.
Così le cose, il problema sta, da un lato, nell’idealizzazione del mondo rurale andino e, dall’altro, nella discrepanza di questi ideali con le politiche macroeconomiche promosse da questi governi.
La sinistra del “vivere bene” ha contribuito a mettere in risalto nelle agende della regione l’urgente necessità della protezione dell’ambiente, rivendicando le pratiche ancestrali dei popoli indigeni come un modello alternativo alle logiche predatrici del capitalismo neoliberale. Secondo l’antropologo colombiano Arturo Escobar, è un tipo di pensiero post-sviluppista che si costruisce “dal basso, da sinistra e con la terra”. Senza dubbio, questo movimento intellettuale ha consegnato potenti strumenti concettuali per il riemergere di gruppi indigeni e di comunità ambientaliste che resistono all’espansione estrattivista latinoamericana. Ma ha trascurato i dibattiti su un modo di produzione alternativo che generi condizioni di benessere materiale per la popolazione.
Sebbene, come ha cercato di mostrare Álvaro García Linera, nel comunitarismo andino non ci siano solo espressioni precapitaliste ma anche anticapitaliste -che possono essere la base di una riorganizzazione economica-, queste esperienze non sono sufficienti a rispondere alla domanda di come rimpiazzare l’attuale modello di (sotto)sviluppo nella regione.
Sviluppismo senza sviluppo
Il fatto paradossale è che la prospettiva sviluppista, che mette al centro delle proprie preoccupazioni e pratiche la questione economica, non sembra nemmeno avere una risposta consistente a questa sfida. Così come lo ha ritratto Maristella Svampa nei suoi studi critici sul recente periodo politico in America Latina, l’onda rosa, associata anche ad un’espansione della frontiera dei diritti sociali, è stata legata anche ad un ampliamento delle frontiere del capitale, particolarmente nei territori indigeni.
Il ciclo post-neoliberale si è retto grazie al boom delle commodities, rimpiazzando l’accordo di Whashington con uno che mantiene una crescita basata sull’esportazione di materie prime, processo che l’autrice chiama “Accordo delle Commodities”, come dire
l’ingresso in un nuovo ordine, simultaneamente economico e politico-ideologico, sostenuto dal boom dei prezzi internazionali delle materie prime e dei beni di consumo sempre più richiesti dai paesi centrali e dalle potenze emergenti, fatto che genera evidenti vantaggi comparativi visibili nella crescita economica e nell’aumento delle riserve monetarie, nello stesso momento in cui produce nuove asimmetrie e profonde disuguaglianze nelle società latinoamericane.
Questo modello estrattivo-esportatore, rafforzato principalmente nei megaprogetti invasivi, ha avuto come risultato una forte ambientalizzazione delle lotte sociali e ha consolidato una nuova razionalità ambientale post-sviluppista, aumentando la frattura tra queste due sinistre. D’altra parte anche se il ciclo progressista avrebbe stimolato un “regionalismo latinoamericano di sfida”, secondo la Svampa, ha anche inaugurato nuove forme di dipendenza, a partire dello scambio asimmetrico con la Cina, il nostro principale socio commerciale nella regione, come compratore di materie prime.
Anche se l’onda rosa si è affermata a partire da un’orizzonte post-neoliberale, sembra non aver alterato uno dei pilastri delle logiche neoliberali: l’utilizzo dei vantaggi comparativi dei paesi emergenti, che non è altra cosa se non la rinuncia ad un’opzione industriale a favore dello sfruttamento delle materie prime.
In effetti, tutto il modello di sviluppo presuppone un modo di accumulazione, regolazione e distribuzione. Nel caso del neoliberalismo, l’accumulazione si basa sui vantaggi comparativi e su una forte finanziarizzazione economica; e allo stesso tempo promuove una forte (de)regolazione economica, basata su un arretramento statale; e alla fine, distribuisce mediante la convinzione nel emorragia economica e nell’intervento focalizzato sulla povertà estrema. In America Latina, l’estrattivismo e la riprimarizzazione sembrano essere una costante tanto nei governi neoliberali come in quelli che si suppone aspirino a superarlo; anche se hanno promosso una rinascita delle capacità statali per intervenire e regolare l’economia, soprattutto attraverso la nazionalizzazione delle risorse strategiche. Alla fine, i governi progressisti sono stati lontani dall’implementare politiche sociali universali che consolidino i diritti; hanno optato per logiche focalizzate di trasferimento di rendita, nella misura in cui gli alti prezzi delle commodities lo hanno permesso. Con tutti i progressi e le contraddizioni politico-sociali dei governi progressisti, questi non hanno innovato su come abbandonare il neoliberalismo.
Anche se si accusano questi governi di essere neosviluppisti -in allusione, soprattutto, al pensiero della CEPAL del XX secolo-, dal bilancio di questo ciclo non possiamo ricavare nulla di equivalente ad un progetto come il modello di Industrializzazione per Sostituzione delle Importazioni, così come ha mostrato, tra gli altri, il sociologo José Maurício Domingues. Senza dubbio, l’industrializzazione continua ad essere un termine chiave per il futuro. La questione è come affrontiamo il fatto che si può aumentare la presenza industriale nel continente senza modificare la posizione subordinata delle nostre economie nella divisione internazionale del lavoro. L’attraversamento delle frontiere delle maquiladoras statunitensi in Messico, alla ricerca di migliori condizioni di estrazione di plusvalore, industrializza, ma allo stesso tempo subordina.
Così come segnalava la economista Alice Amsden, la sfida dei paesi periferici è passare da una strategia “compratrice” di tecnologia, come nel caso delle maquiladoras, ad una che si sostiene sulla “produzione” di tecnologia. Per questo è indispensabile che lo stato assuma un ruolo di essere “guidato e conduttore” di questo sviluppo, dato che gli altri attori economici difficilmente romperanno con le comodità di una rendita poco propensa all’investimento strategico e abituata ad ampi margini di profitto, basati sulla rendita della terra e sul super-sfruttamento del lavoro -precario- latinoamericano. Allo stesso tempo, questo sviluppo deve considerare i limiti delle piante e la necessità di un nuovo patto socioeconomico che contribuisca a invertire la critica situazione climatica e ambientale che hanno reso più evidente l’avvertimento di Jameson che “è più facile pensare alla fine del mondo che alla fine del capitalismo”.
Costruire futuro
La sinistra latinoamericana difficilmente sarà alternativa di futuro se non è capace di rispondere tanto all’emergenza climatica come alla necessità di strutturare un progetto di sviluppo che permetta di distribuire ricchezza e integrare i cittadini della regione esclusi dal consumo e dagli standard materialmente più elevati di vita. Ma, è possibile? Forse il superamento della povertà e l’aumento della capacità di consumo non va di pari passo con un incremento dei fattori che peggiorano la crisi climatica?
La risposta non è facile. Ma l’attuale stato delle cose ci obbliga a pensare ordinamenti economici più razionali per ridurre il nostro impatto sull’ambiente e per ridurre la disuguaglianza economica che spicca nella regione. Il capitalismo neoliberale si caratterizza per la distruzione delle principali fonti di produzione della ricchezza: la natura e il lavoro. La sinistra latinoamericana ha la missione di superare la propria attuale contraddizione e contribuire a rendere più facile pensare alla fine di questo capitalismo che ci tiene sull’orlo della fine del mondo.
[*] L’autore ringrazia il Progetto FONDECYT 1200841, nell’ambito del quale si è sviluppata questa riflessione.
Foto da CELAG
28-10-2021
Jacobin America Latina
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.