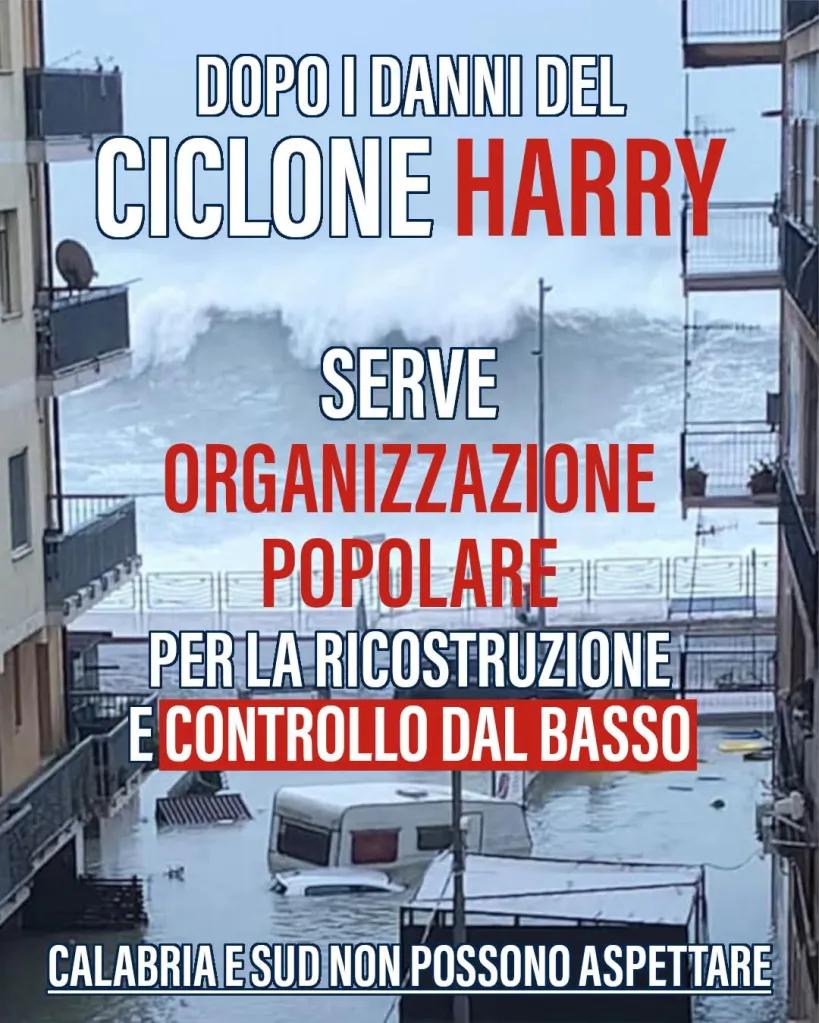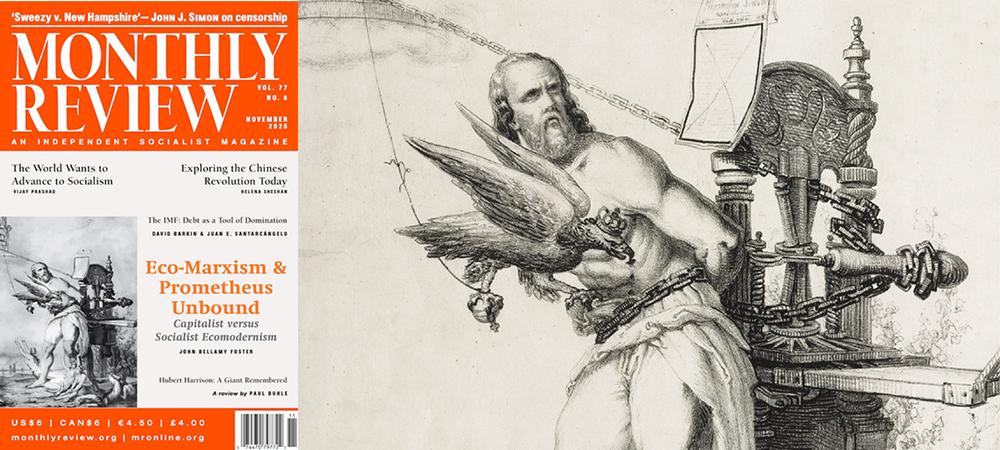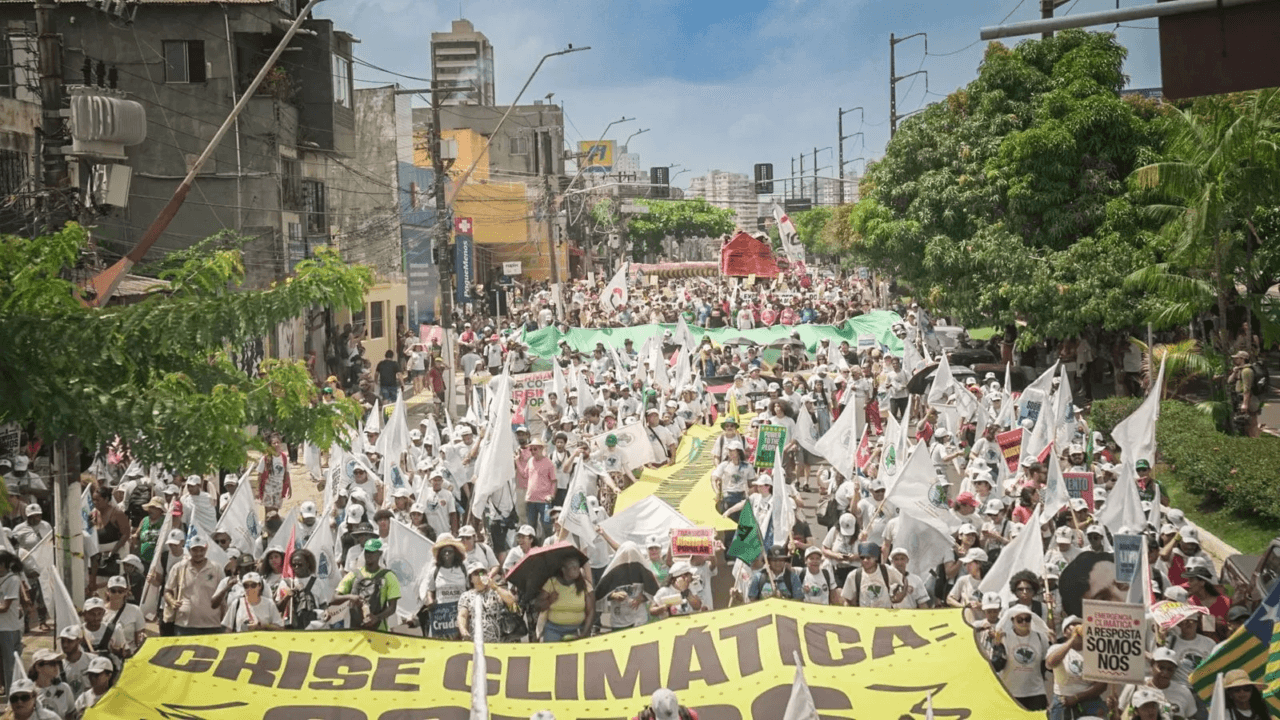Spagna: un’agricoltura che consideri l’acqua come un bene comune
L’inquinamento e la scarsità dell’acqua derivanti dal cambiamento climatico ostacolano le prospettive delle generazioni attuali e future. Se consideriamo l’acqua come un bene comune e un bene ecosociale, e i fiumi come le vene che irrigano e sostengono la vita ovunque passino, la prospettiva dell’agricoltura spagnola cambia notevolmente. E ci porta alla necessità di riconsiderarne la progettazione per adattarla ad una nuova realtà climatica e idrica con criteri ambientali e sociali: in una prospettiva di sovranità alimentare.
di Omar Bonger, da ECOR Network
Idrocalipse

Sappiamo che l’agricoltura richiede tra il 70 e il 99% dell’acqua dolce disponibile, a seconda della regione. Il consumo umano di acqua è compreso tra il 7 e il 12% dell’acqua che utilizziamo, includendo gli oltre 47 milioni di abitanti residenti, i 71,6 milioni di turisti (dati INE del 2022), nonché la stragrande maggioranza dell’acqua delle piscine pubbliche e private.
Questa enorme percentuale di acqua destinata all’agricoltura ha una spiegazione. In soli 9 anni siamo passati dall’export di cibo per un valore di 35 miliardi di euro nel 2012 a più di 60 miliardi di euro nel 2021 (dati Ministero dell’Agricoltura), per lo più materie prime non trasformate e con scarso valore aggiunto. Siamo una grande potenza agricola, “il frutteto d’Europa” ma, pensando all’acqua, non sembriamo più una “zona di sacrificio”?
Se affrontiamo la dimensione sociale, economica e ambientale della gestione dell’acqua nello Stato spagnolo, troviamo vari esempi che chiariscono di cosa stiamo parlando. Esauriamo e facciamo seccare il nostro territorio per produrre olio in coltivazione superintensiva (che richiede molta acqua), olio che viene esportato in Italia sfuso per poi essere imbottigliato lì e ricavare notevoli profitti vendendolo in tutto il mondo come olio di oliva: l’Almería diventa sempre più desertificata mentre le sue falde acquifere vengono salinizzate a causa dello sfruttamento eccessivo derivante dall’instaurazione di una dieta mediterranea nel Nord Europa che non corrisponde alla sua realtà geofisica e alla sua cultura gastronomica. A Huelva vediamo come viene utilizzata l’estrazione illegale dell’acqua per irrigare i frutti di bosco (fragola, lampone, mirtillo e ribes) che tingeranno di rosso i portafrutta dei paesi europei. In Aragona, migliaia di ettari di mais transgenico vengono irrigati per nutrire i maiali che viaggeranno a pezzi verso la Cina per essere consumati. Coltiviamo l’erba medica per disidratarla e la vendiamo pressata agli Emirati Arabi Uniti e all’Arabia Saudita, che con essa ingrassano gli animali che verranno mangiati nelle sagre dell’agnello. Migliaia di litri di vino proveniente dai vigneti irrigui della Castiglia-La Mancha vengono convertiti in alcol etilico per uso industriale affinché il prezzo del vino non scenda troppo, mentre Las Tablas de Daimiel, un Parco Nazionale, è diventato una terra bruna e desolata che suggerisce solo la fuga, e la ricchezza del Tajo, condivisa con il Portogallo, viene deviata, attraverso un trasferimento, per confluire nell’agroindustria murciana, altra attività esportatrice, mentre le foto dei pesci morti del Mar Menor mostrano i limiti di questo modello.

Agire di fronte alla tempesta perfetta
Secondo il DRAE, un/a agricoltore/trice è una persona che si dedica alla coltivazione o alla lavorazione della terra. Non dice che il suo reddito dipende interamente da questa attività agricola o che è un hobby, non fa differenza tra chi ha tre ettari irrigati da chi ha 150 ettari di avocado distribuiti tra l’Axarquía di Malaga, la Costa Tropical di Granada e Huelva o chi coltiva ortaggi che verranno venduti a meno di 30 km da dove sono stati coltivati, nei mercati biologici e a prezzi che non hanno nulla da invidiare a quelli dei grandi magazzini.
[Senza terre fertili, senza contadini,
senza acqua… come ne usciremo?]
Quando si parla di irrigatori succede qualcosa di simile, tutto quadra. I proprietari terrieri sono stati rispetto alla terra, ciò che i proprietari dell’acqua sono rispetto al diritto all’acqua e allo sfruttamento dell’acqua pubblica, sia sotterranea, proveniente da un bacino idrico o da un fiume. Acqua che non viene impiegata per produrre da mangiare, ma per produrre beni che verranno venduti sui mercati esteri. Abbiamo un esempio a Doñana dove, come ha recentemente dichiarato alla stampa Leandro del Moral, professore di Geografia Umana all’Università di Siviglia, “l’87% dell’acqua è utilizzata dal 10% dei proprietari”.

Da almeno tre decenni, l’Europa è andata sovvenzionando gli agricoltori, almeno per il 75%, delle spese sostenute per attuare la “modernizzazione” dell’irrigazione a gravità, chiamata anche inondazione o irrigazione “a piena”. La tesi avanzata è che questi sistemi tradizionali sono meno efficienti, poiché hanno perdite (o ritorni ai fiumi e alle falde acquifere, a seconda della prospettiva) del 50% dovute alle infiltrazioni nel suolo. Nel frattempo, l’irrigazione pressurizzata, come l’irrigazione a pioggia o a goccia localizzata, prevede un uso più rigoroso dell’acqua. Ma, come spiegano centinaia di studi, si verifica il paradosso di Jevons: più siamo efficienti nell’uso di una risorsa, maggiore è il consumo di questa risorsa. Stiamo irrigando oltre le nostre possibilità e, cosa ancora più importante, a costo dell’acqua destinata alle generazioni future. Visto lo spreco d’acqua e l’erroneo “investimento” che ne facciamo, ora che piove meno e l’acqua evapora più facilmente a causa dell’aumento delle temperature, abbiamo la tempesta perfetta. Ci troviamo di fronte a un bivio. Da un lato, lo scenario dell’agro-export e dell’agricoltura estrattiva guidata dai fondi di investimento in un turbocapitalismo che avvantaggia sempre meno persone e, dall’altro, la possibilità di iniziare a pianificare con criteri eco-sociali l’uso della scarsa terra fertile e dell’acqua, in un contesto in cui la sua disponibilità andrà diminuendo. Ecco il dilemma. Senza terre fertili, senza contadini, senza acqua… come ne usciremo?
[“È un imperativo fare della crisi idrica l’opportunità
per ridisegnare le politiche alimentari”]
Le amministrazioni non mettono in discussione la strategia dell’agroexport, anzi: il loro atteggiamento è quello di fare tutto il possibile per salvarla. È imperativo fare della crisi idrica l’opportunità per ridisegnare le politiche alimentari, per adattarsi a una nuova realtà, convertendo gradualmente il modello di agro-esportazione in un’agricoltura che, in primo luogo, nutra la popolazione locale e vicina e che ci permetta di moltiplicare il numero di persone che vivono degnamente di agricoltura, mantenendo vivo il mondo rurale.
Una strategia per la sovranità alimentare
Di fronte alla cultura della “proprietà” dell’acqua, tipica del capitalismo neoliberista, possiamo elaborare proposte sotto il paradigma dell’acqua come bene comune, necessario per garantire sia il diritto all’acqua sia il diritto al cibo. Cioè, le politiche idriche, come quelle relative alla terra o alle sementi, devono essere guidate da principi di sovranità alimentare.

Da dove cominciamo? In realtà alcune misure avrebbero già dovuto essere prese, come l’eliminazione dell’irrigazione illegale. Nella situazione attuale, di estrema gravità climatica, di estrema disuguaglianza tra modelli produttivi e di abbandono delle aree rurali, una delle politiche da applicare è la distribuzione ecosociale dell’acqua, dando priorità a quella utilizzata per l’agricoltura e l’allevamento in quei progetti e fattorie che producono i nostri alimenti e vivono nel territorio prendendosi cura della terra.
A quanto so, oggi non esistono proposte concrete su come procedere con questa ridistribuzione dell’acqua per l’agricoltura. Ma sembra logico e urgente che, in una forma partecipativa, cominciassimo a stabilire indicatori per realizzare questa distribuzione ecosociale. Uno di questi, ad esempio, potrebbe essere la dimensione delle aziende agricole e il numero di nuclei familiari che beneficiano dell’acqua, in modo da garantire che l’utilizzo di ogni goccia permetta al massimo numero di persone di vivere con dignità nelle zone rurali. Si tratterebbe di sviluppare un rapporto tra acqua e popolazione residente nel territorio, che possa essere anche relazionata con i ritorni economici: insomma, un rapporto volto a favorire quegli usi dell’acqua che trasferiscano i benefici alle economie familiari e locali.
[“Si tratta di intervenire e decidere come società cosa fare con l’acqua,
e non lasciarla nelle mani di manager corrotti o nell’attuale predisposizione
neoliberista in cui diventa un altro valore sui mercati azionari internazionali”]
Un altro criterio potrebbe essere il tipo di coltivazioni che si irrigano, dando priorità a quelle destinate all’alimentazione umana locale (qualcosa di relativo che andrebbe stabilito a seconda del tipo di coltura), rispetto a quelle destinate all’ingrasso animale industriale o all’esportazione. Dovrebbe essere preso in considerazione anche il modello agronomico attuato da ciascuna azienda agricola, poiché sappiamo che i modelli agroecologici garantiscono sia la giustizia sociale che quella ambientale. Si tratta di intervenire e decidere come società cosa fare con l’acqua, e non lasciarla nelle mani di gestori corrotti o nell’attuale predisposizione neoliberista in cui diventa un altro valore sulle borse internazionali.
Una volta definiti questi criteri, occorre metterli in pratica. Questi cambiamenti devono essere realizzati poco a poco e offrire l’aiuto e il sostegno necessari per delle buone riconversioni o adattamenti a nuove pratiche agricole e commerciali coerenti con la disponibilità di acqua. Esistono già molti strumenti disponibili, come gli aiuti al reddito minimo vitale, di nuovi insediamenti per giovani agricoltori o per facilitare vendite in filiere corte. E se ne possono progettare altri. La dinamizzazione locale agroecologica può svolgere un ruolo chiave in questo contesto e generare posti di lavoro.

Stiamo parlando, insomma, di transizioni per adattare la produzione alimentare alla realtà della natura e non viceversa. Faccio alcuni esempi. Sostituire le colture erbacee che nell’attualità si mantengono sotto irrigazione, soprattutto quelle destinate all’ingrasso degli animali da stalla, con colture erbacee che si adattino alla pluviometrìa della regione e siano destinate alla popolazione locale (max. 100 km) e agli allevamenti estensivi più vicini. Nel caso delle colture orticole irrigue, si darà priorità a quella da vendita locale. Per la frutticoltura sarà necessario, ancora una volta, spostarsi (o ritornare) a quella adattata alle condizioni pedoclimatiche e pluviometriche di ciascuna località, recuperando varietà locali che sono adattate a ciascuna condizione: il carrubo, l’olivo, la vite, il pesco o l’albicocca secca sono esempi di tradizione e ci suggeriscono varie linee di lavoro. Nel caso dei cereali, dobbiamo adattarci rapidamente ad altre varietà di grano, orzo, avena e segale con maggiore resistenza alla siccità (come alcune varietà antiche), prendendo l’esempio di paesi che hanno già iniziato in questa linea di lavoro, come come la Siria o l’Australia.
Stiamo affrontando, che ci piaccia o no, la necessità di rivedere il disegno e la dimensione della nostra agricoltura e del nostro allevamento iberico per adattarci a una nuova realtà climatica e idrica con criteri ambientali e sociali. La siccità è un avvertimento, ci sentiamo pronte/i?
* Omar Bonger è agroecologo e specialista in colture tropicali. Membro di Ecologistas en Acción e della FNCA
** Tratto da Revista Soberania Alimentaria. Biodiversidad y Culturas. Originale in spagnolo qui
*** Traduzione Giorgio Tinelli per Ecor.Network
Consiglio di lettura: J. Martínez Fernández, M.A. Esteve Selma, P.A. Zuluaga Guerra, “Agua y sostenibilidad. Hacia una transición hídrica en el Sureste Ibérico”, in Ecosistemas Vol.30 N°3, 2021 – 9 pp. – Download
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.