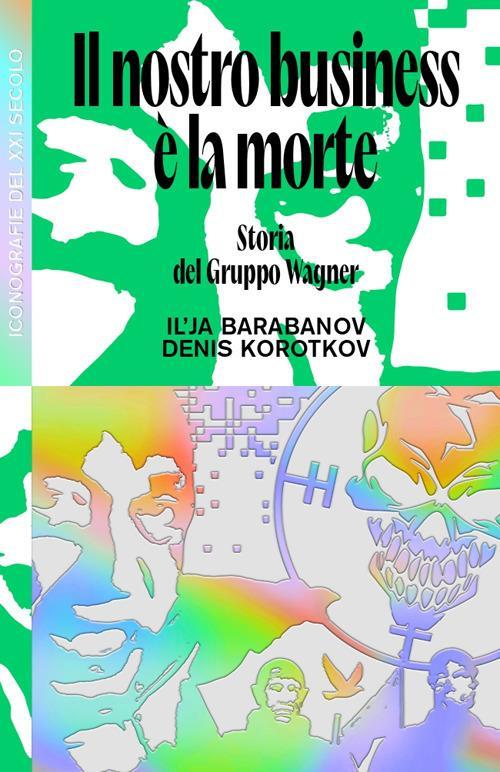Di cosa parliamo quando parliamo di calcio popolare?

Di Alessandro Bezzi – tratto da: zonacesarini.net
Sempre più spesso sentiamo parlare di “calcio popolare”: un termine tanto discusso quanto vago, che prova a mettere insieme decine di realtà nate negli ultimi anni in tutta Italia. Mentre le contraddizioni del sistema calcio si fanno sempre più evidenti sembra essere nata una risposta dal basso, spesso portata avanti proprio da tifosi stanchi di presidenti macchietta, campionati falsati e divieti di ogni tipo.ù
Ma, parafrasando Carver, di cosa parliamo quando parliamo di calcio popolare?
La definizione di “calcio popolare” già solleva molti dubbi. Il calcio è popolare per sua natura, nonostante la Serie A sia percepita come un mondo sempre più distante per costi e fruibilità. La definizione di “calcio minore” è altrettanto discutibile, almeno per quanto riguarda la passione e l’impegno: mi sembra comunque più pertinente. Ad ogni modo, questa discussa definizione racchiude squadre che sono nate negli ultimi 10 anni seguendo alcuni criteri (autofinanziamento, volontariato, etc.) che le hanno rese realtà affascinanti, innovative e sempre più partecipate.
Va detto che spesso questi principi sono portati avanti anche da società “classiche”, che non andrebbero avanti senza gli sforzi di magazzinieri, dirigenti e allenatori che fanno quotidianamente i salti mortali. Ci tengo a precisarlo per spiegare come il calcio “popolare” presenti anche molti elementi di continuità con il calcio “minore” classico.
Quali sono i tratti caratteristici?
In primis, spesso siamo davanti a un nuovo modello societario: non solo autorganizzazione su base volontaria, ma azionariato popolare e forme di compartecipazione alle spese. Ci sono statuti sempre più precisi che definiscono i referenti, i meccanismi decisionali e i principi che caratterizzano la vita delle società. Il tutto improntato secondo una logica democratica che oramai anche le istituzioni sembrano aver dimenticato.
Anche la divisione dei compiti (amministrazione, comunicazione, magazzino, merchandising, ecc.) comporta una responsabilizzazione collettiva nient’affatto scontata: innumerevoli esperienze politiche sono crollate proprio per l’impossibilità di conciliare responsabilità, decisionalità e orizzontalità. Le società di calcio popolare sembrano aver trovato un equilibrio, puntando su una gerarchia funzionale, alla fiducia reciproca e a una chiara divisione dei compiti. Tra le squadre che meglio hanno sviluppato nuovi modelli societari possiamo ricordare l’Ardita San Paolo di Roma e l’ASD Quartograd di Napoli.
Un altro tratto distintivo è la presenza di una tifoseria organizzata degna dei campionati professionistici: cori, tamburi, fumogeni riproducono un’ambientazione sempre meno tollerata nei grandi stadi. In questo modo ci si riappropria della curva come momento di aggregazione genuina e (perché no?) anche goliardica: in un mondo sempre più controllato e in una società sempre più ipocrita non è difficile spiegare il fascino di queste curve colorate e rumorose. Sembrano – e in alcuni casi sono – quei tifosi mandati via dalla Serie A, per fare spazio a una middle class meno fedele ma più propensa a spendere.
Un terzo tratto può essere il rapporto con il territorio. Le società classiche si limitano a ospitare le sagre estive o a lasciare i propri spazi ad iniziative del comune e/o di qualche associazione. Alcune di queste “nuove” società fanno molto di più, instaurando un rapporto quotidiano con i cittadini: penso soprattutto all’Atletico San Lorenzo a Roma: la società tiene feste nel quartiere, aiuta i piccoli commercianti locali e organizza attività di ogni tipo. Abitare gli spazi è il modo migliore per renderli sicuri: “Da quando stiamo in piazza, gli spacciatori se ne sono andati”, mi raccontava uno di loro.
Quanto alla politicizzazione, chi partecipa a progetti di questo tipo non ha paura di schierarsi. E se solo poche squadre scelgono di autodefinirsi “comuniste”, tutte praticano politica. Voglio essere chiaro su questo punto. Adottare un modello societario non verticista è una scelta politica; lasciare ai giocatori la libertà di prendersi il cartellino e andare in un’altra squadra è una scelta politica; fare uno striscione contro il massacro della Diaz è una scelta politica.
Una nota a margine: non è un caso che molte di queste società siano sorte proprio dove il tessuto sociale è più lacerato, come periferie industriali o quartieri popolari sottratti alla gentrificazione. E da San Donnino a Quarto, da Cava de’ Tirreni a Teramo, si potrebbe immaginare un Viaggio in Italia talmente romantico da far impallidire Goethe.
L’importante è partecipare? Esempi italiani e modello inglese
Oramai si contano a decine le società di questo tipo sparse in tutta Italia: il modello è indiscutibilmente affascinante, perché presenta un’idea di calcio più genuina, orizzontale e partecipata. Ma per affermarsi veramente, il calcio “minore” deve anche essere vincente. L’ASD Quartograd è in Promozione, il Centro Storico Lebowski di Firenze è in Prima Categoria: i successi sul campo hanno contribuito a dare entusiasmo ai tifosi e legittimazione ai progetti. Insomma, l’importante è partecipare, ma il successo sportivo è necessario perché un modello virtuoso possa convincere, espandersi e contagiare anche le società “classiche”. Si tratta di professionalizzarsi senza sporcarsi le mani, in un mondo che rappresenta perfettamente tutte le contraddizioni e i problemi del Paese.
Ma società autogestite, democratiche e impegnate non sono, ovviamente, una peculiarità del calcio italiano: in tutto il mondo stanno fiorendo progetti simili. E se molte squadre sono spesso cresciute assieme ai propri giovani tifosi, altre sono esplose grazie a un approccio fin da subito ultra-professionale. È il caso del FC United of Manchester, fondato da tifosi dei reds contrari all’arrivo del magnate statunitense Glazer: fin dal primo incontro, centinaia di persone hanno messo a disposizione esperienze professionali, risorse e tempo per un progetto che ha fatto scuola. In 10 anni il FCUM è arrivato a costruirsi uno stadio di proprietà, salendo lentamente la china delle serie minori inglesi, fino ad arrivare in Sesta divisione. Lo seguono migliaia di tifosi, che al pub continuano a guardarsi i gol di Rooney; perché un pezzo di cuore è rimasto all’Old Trafford. “Two United, but the soul is one”.
Un altro calcio è possibile? Sfide e opportunità
Uno dei rischi maggiori per queste nuove società potrebbe essere l’auoreferenzialità di credersi l’unica isola felice di un mondo allo sbando: esistono centinaia di squadre che stanno portando avanti gli stessi ideali da decenni, con lo stesso entusiasmo e gli stessi sacrifici. Prima o poi, sarà necessario aprirsi anche a loro, che spesso soffrono degli stessi problemi organizzativi ed economici. La sfida principale, insomma, sarà fare rete senza omologarsi. Non esiste un modello ideale. Ogni società dovrà essere brava a capire le problematiche del proprio territorio e a stringere un rapporto sinergico con il quartiere, il paese o la città dove opera; sottolineando i problemi che riguardano la squadra, ma anche quelli che riguardano tutto il movimento calcistico, o addirittura il Paese.
Inoltre esistono altri problemi che riguardano moltissime squadre. La possibilità di accesso ai bandi pubblici in primis: per molti è ancora difficile fruire dei campi sportivi, a causa di incuria, scarsa sensibilità politica o scarsa trasparenza nell’assegnazione. Per le società che hanno più a cuore la situazione di rifugiati e extracomunitari ci sono barriere burocratiche incredibili: lo sport potrebbe essere un potente veicolo di inclusione sociale, ma è la stessa FIGC a porre barriere che ostacolano l’integrazione invece di accelerarla. La storia dell’AfroNapoli, raccontata nel documentario Loro di Napoli, lo spiega perfettamente: una società amatoriale composta principalmente da extracomunitari fatica a iscriversi in Terza Categoria a causa di regolamenti kafkiani, superati solo grazie all’ostinazione della società e al buonsenso di qualche responsabile della FIGC.
Una storia che conoscono bene anche i dirigenti della Liberi Nantes, la prima squadra di calcio in Italia interamente composta da rifugiati e richiedenti asilo: superate le difficoltà iniziali, la società oggi è diventata una polisportiva solidamente radicata nel territorio. La Liberi Nantes mette gratuitamente a disposizione di tutti gli ospiti dei diversi centri d’accoglienza un campo e il materiale sportivo necessario ad allenarsi.È evidente come queste realtà si pongano dichiaratamente in antitesi al modello dominante: forse dovremmo parlare di “altro calcio” o di “calcio originale” perché di fatto sono queste realtà minori a diffondere i veri valori dello sport. Assieme, ovviamente, a migliaia di società dilettantische che costituiscono il 99% del sistema calcio.
Mentre queste lottano per sopravvivere, la forbice con il restante 1% aumenta: vi ricorda qualcosa? Il calcio, insomma, ripropone tutte le contraddizioni che vediamo anche fuori dal campo: e la crisi dell’Italia pallonara è per certi versi la metafora di un Paese economicamente e culturalmente allo sbando. Il calcio “minore” può essere una risposta dal basso, una soluzione ideale a cui guardare per risolvere contraddizioni sempre più evidenti. Se riusciranno a farsi movimento e a interagire con quel tessuto già radicato in tutto il territorio, queste nuove società hanno un potenziale rivoluzionario: potrebbero ricordarci i veri valori dello sport; potrebbero proporci un modello più sostenibile e partecipato; potrebbero insegnarci una socialità più spontanea e responsabile.
E se è possibile dentro a uno stadio, forse lo è anche fuori.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.