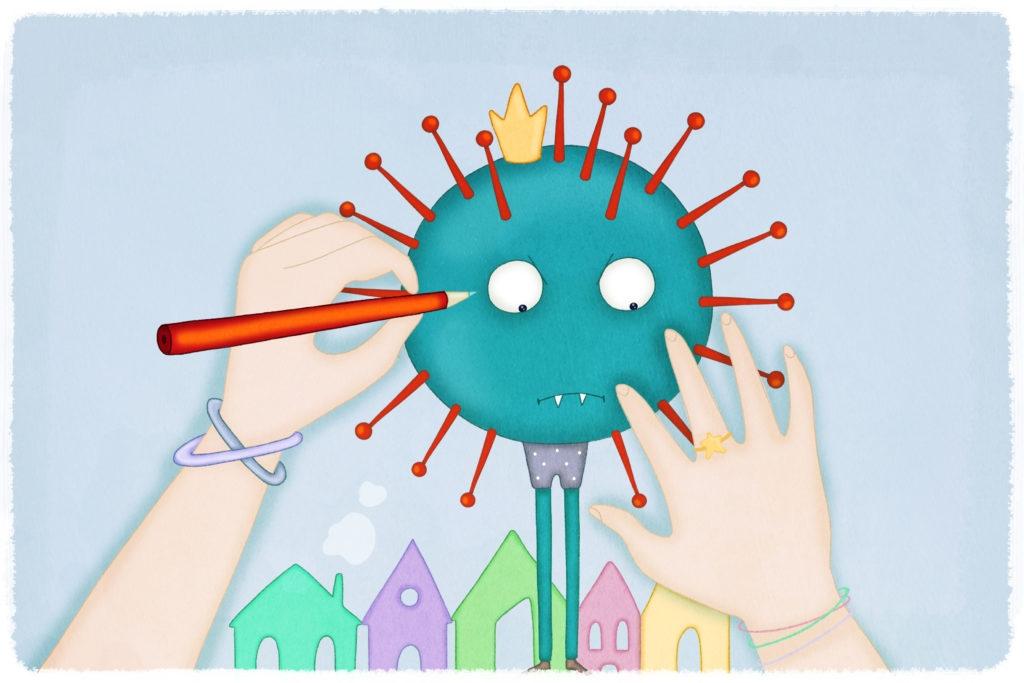Chi non lavora non fa l’untore

Il virus del lavorismo è tra noi.
Di Corisco
Riaprire a tutti i costi, ripartire, rimettere in moto la macchina della produzione, garantire la competitività. Qualcuno, tra i soliti noti, ha persino fatto parlare i morti per assicurarsi che la retorica della ripartenza diventi un imperativo morale, più che una decisione politica.
L’orizzonte catastrofico che solo un mese fa guardavamo con inquietudine nella speranza di continuare a osservarlo da lontano, reinventando le nostre vite e convivendo con l’epidemia, rappresenta ormai il nostro presente e il nostro futuro a tempo indeterminato.
L’indefinitezza di questa situazione, inevitabilmente, spinge molti a considerare la necessità di un’occupazione come la priorità assoluta, anche a scapito della propria salute. In questa pulsione, che ci induce a voler aggirare le restrizioni per superare l’immobilismo in cui siamo costretti, convergono tanti fattori, tante necessità, ma soprattutto tante storie di vita.
La poca chiarezza delle informazioni che ci vengono somministrate a ritmo incessante ogni giorno ha ormai polarizzato il dibattito pubblico, tra gli irriducibili della clausura e i partigiani della libera uscita. Responsabilità collettive contro libertà individuali, apologia del controllo contro autodeterminazione.
Un dibattito che, su entrambe le sponde, conosce i suoi pro e i suoi contro, almeno credo. Ma è un dibattito a cui si aggrappano, come api sul polline (anche se sarebbe più corretto chiamare in causa le meno eleganti mosche), gli specialisti della politica. Così va avanti il circo di cui si nutre la spettacolarizzazione mediatica della crisi: il partito del restoacasismo trasforma i suoi adepti in sceriffi fanatici del controllo sociale e gli esponenti del riapritismo trovano spazi inediti per insinuare il dubbio sulla legittimità scientifica del distanziamento.
Che si tratti di barricarci in casa pattugliati giorno e notte da un drone o che ci venga lasciata la libertà di ricongiungerci con il rischio di contagiarci vicendevolmente – e quindi di morire, la decisione sul rientro a lavoro sembra unanime. La supposizione, all’apparenza, è logica: senza lavoro niente reddito, quel poco che lo Stato poteva dare è stato dato e le cosiddette mansioni “indispensabili” da sole non sono sufficienti a garantire la crescita.
Nel frattempo il leviatano dell’economia globale ha conosciuto un blocco parziale, o quantomeno un rallentamento, che fino a oggi non sarebbe stato immaginabile nemmeno con lo scoppio di una guerra planetaria. Un’interruzione dei flussi, del movimento e delle frenesia che caratterizzano le nostre vite da così tanto tempo che non riusciamo quasi a immaginare come possa essere altrimenti.
A molti, magari inconsciamente, sarà forse balenata l’idea che quello che facevamo prima non sia, alla fine dei conti, così indispensabile?
Non è certo il tempo di recitare l’elogio funebre del capitalismo, e forse nemmeno di quel realismo capitalista descritto da Mark Fisher come il dispositivo che ci permette di immaginare la fine del mondo ma non la fine dell’accumulazione e dello sfruttamento. Magari, però, proprio ora che la prove generali per l’apocalisse sembrano entrare nel vivo della rappresentazione, possiamo soffermarci sulla nostra immaginazione e domandarci se sia possibile, timidamente, tratteggiare un’idea di futuro che non sia solo la cannibalizzazione reciproca sulle ceneri dell’antropocene.
Certo, in queste condizioni fare un’apologia del tempo ritrovato o della riconquista degli spazi privati suona come un elogio del privilegio. In questo momento chi può permettersi anche solo il lusso di pensarsi oltre il sistema di produzione di cui tutti siamo, consapevolmente o meno, degli ingranaggi?
Io stesso ritengo che in questo momento la priorità sia quella di rivendicare a gran voce le condizioni più idonee per affrontare la tempesta mentre il deserto della pandemia avanza inesorabilmente davanti a noi. Tra queste ci sono senz’altro le tutele per chi è costretto a lavorare nei luoghi del contagio, e per chi è costretto a lavorare in generale a stretto contatto con altre persone. Ma anche la richiesta di un reddito di base universale e garantito, ora che gli strumenti per la sua estensione esistono e devono essere rafforzati.
Ma il punto non è questo.
Il punto è che dopo avere trovato un breve, fugace, momento per ripensare a noi, ai nostri corpi e alla nostra salute durante il lockdown, abbiamo forse anche la possibilità di ritagliarci uno spazio per ripensare al mondo in cui ci viene imposto di tornare a vivere (e, purtroppo, a morire). In questo spazio credo sia necessario ricominciare a ipotizzare un rifiuto del lavoro che non sia solo una strategia di contrattazione, ma una rivendicazione complessiva.
Se guardiamo al capitalismo come ideologia – o come spirito, secondo la definizione di Weber – prima che come a un sistema economico, ci rendiamo conto di come rappresenti un apparato indubbiamente efficace nel farci trovare delle forti motivazioni di carattere morale che ci spingono ad aderire ad esso. Non solo, ma il terzo spirito del capitalismo – quello in cui viviamo, secondo i sociologi Boltanski e Chiapello – ci avrebbe finalmente indotto a interiorizzare le giustificazioni sulla presunta necessità del suo ordine. Ciascuno di noi, in pratica, concretizza su di sé e sugli altri quei dispositivi coercitivi che sembrano rendere lo sviluppo capitalistico razionale e, soprattutto, ineluttabile.
Di ciò è esempio tutta la fatica quotidiana che, in quarantena, spendiamo nella manutenzione dei nostri corpi-macchina. Se dimostrare la necessità di andare a fare una corsa al parco è diventata una blasfemia, sembra invece un obbligo tenersi in allenamento quotidiano tra le mura di casa seguendo corsi on-line di ogni genere di disciplina. A ciò si uniscono – con intensità e violenza differente in base al genere – i peggiori meccanismi di auto-colpevolizzazione e stigma-social, se anche solo per un attimo pensiamo che non sia necessario depilarsi o ci dimentichiamo di prepararci alla prova costume nonostante la basse probabilità di vedere il mare quest’estate.
La retorica lavorista è, a mio avviso, uno degli strumenti indispensabili in questo processo. Rappresenta, infatti, un assunto talmente incontestabile da non sembrare più quello che invece è realmente: un ricatto. Il fatto che la pandemia abbia disvelato, in buona sostanza, l’assoluta inconsistenza di gran parte dei nostri lavori, non ha messo però in crisi la “costrizione silenziosa” del ricatto lavorativo (vale a dire “o lavori o non mangi”), così come descritta dal Gruppo Krisis nel Manifesto contro il lavoro del 2003.
Moltissime persone, anche al di fuori delle cerchie di Confindustria o dei partiti politici a favore del “ritorno alla normalità” (tutti), vedono ancora il lavoro come l’unica possibilità di riscatto – o in questo caso, di sopravvivenza – a cui aggrapparsi. Anche il tam-tam sui social network che, nelle scorse settimane, invitava la popolazione a scendere in strada per “riprendersi la libertà”, aveva come sottofondo la partitura stonata del lavorismo.
“Io oggi non festeggio la Costituzione perché il primo articolo dice che l’Italia è un paese fondato sul lavoro, ma oggi a lavoro non ci posso andare”. È l’incipit di uno dei tanti video di protesta che, il 25 aprile, hanno invaso i gruppi e le chat di quelle persone che, sentendosi abbandonate dallo Stato, invocano una protesta di massa che porti all’allentamento del lockdown. Anche in questo caso è evidente come una pulsione più libertaria – e in un certo senso comprensibile – legata alla volontà di riprendere le relazioni sociali e lasciarsi alle spalle la fase più acuta dalla pandemia, si sia saldata al discorso della ripartenza economica, finendo per catalizzare buona parte della narrazione padronale sul “ritorno alla normalità”.
Sempre il Gruppo Krisis, nel suo Manifesto, faceva notare come l’Italia, nonostante vanti una certa tradizione di resistenza al lavoro, rappresenti nella realtà un vero e proprio laboratorio di tecniche di dominazione sociale legate all’imposizione del lavoro. La grande diffusione di forme di occupazione “atipiche”, come il lavoro autonomo, unite a una disoccupazione molto elevata e alla diffusione endemica del lavoro nero, rendono infatti il nostro paese un’avanguardia nello smantellamento del tradizionale rapporto tra produzione e salario. La maggiore autonomia dei lavoratori e delle lavoratrici rappresenta, in buona sostanza, una maggiore propensione all’autosfruttamento dovuta all’interiorizzazione dell’obbligo lavorativo. In un contesto come quello attuale, dove l’impoverimento generale aumenta di pari passo con il prolungamento dell’epidemia, sembra quasi inevitabile un rafforzamento di questa logica di auto-valorizzazione immediata.
È sufficiente, allo stesso tempo, derubricare le legittime preoccupazioni di milioni di persone a un semplice prurito lavorista? Certo che no. All’interno di queste pulsioni, di questi conflitti – per ora – a bassa intensità, si racchiude in potenza la spinta a rifiutare un modello di sviluppo che non prevede altro orizzonte al di fuori dello sfruttamento più bieco. La nostra subalternità allo sviluppo del capitale è ormai pressoché totale, interiorizzata in ogni nostro gesto, in ogni nostra azione, anche quando vorremmo che queste servissero a liberarci dal suo giogo.
Antonio Gramsci sosteneva che i subalterni subiscono sempre l’iniziativa dei dominanti, anche quando si ribellano, a meno che non riescano a sviluppare un’iniziativa autonoma che permetta loro di combattere per contendere l’egemonia ai propri oppressori. Trascurare i movimenti spontanei dei gruppi subalterni aprirebbe invece alla reazione, a meno che non si trovi il modo di fornire una “direzione consapevole” a queste mobilitazioni. In buona sostanza, se ci sembra facile derubricare i conflitti che animano sempre più persone nel nostro paese a un’inveterata logica “da bottegai”, o alla recrudescenza di pruriti conservatori (entrambe cose presenti, non c’è dubbio), si rischia forse di perdere la possibilità di intavolare un processo di riscatto sociale che vada oltre la logica del lavoro e delle sue dinamiche di costrizione.
Parliamoci chiaro: la questione cruciale dei prossimi mesi, a livello economico e sociale, si gioca sulla materialità dei bisogni e sulla necessità di tirare avanti, in un modo o nell’altro. Lo spazio per le utopie e per i discorsi di ampio respiro sembrerebbe, allora, molto ristretto per non dire inesistente. Ma è proprio qui che, a mio modo di vedere, si può provare a combattere una battaglia più articolata e complessiva. Quando ci si troverà a lottare per rivendicare più welfare e maggiori diritti sui luoghi di lavoro, si dovrebbe provare ad affiancare un refrain che sottintenda la sottrazione totale e irreversibile al ricatto del lavoro. In un certo senso, a una logica rivendicativa più classica, e sostanziata dalla necessità di vivere dignitosamente senza pagare i costi della crisi, va intervallato un ritornello che ribalti la logica del ricatto lavorista e lo scagli nella direzione opposta: “ora che abbiamo i mezzi per campare, possiamo iniziare a pensare a come vivere senza lavorare”.
La forza di questa assunzione di prospettiva non potrà che risiedere nella riscoperta di una nuova forma di convivenza, collettiva e mutualistica, che sottragga forza all’ideologia dell’individuo contrapposto agli altri individui. Il dibattito transfemminista ha evidenziato come la logica dei “lavori indispensabili” non serva ad altro se non a rafforzare la declinazione sessista e razzista di alcune mansioni, in primo luogo del lavoro di cura. Nell’ambito della riproduzione sociale, infatti, è molto chiaro che non è continuando a lottare per un miglioramento delle condizioni di lavoro che si sconfiggerà il dominio patriarcale sul quale si regge il presupposto dell’esistenza di “attività femminili”, senza le quali la società del lavoro non potrebbe esistere. La soluzione, allora, non può che essere la sottrazione, un rifiuto totale e inderogabile del lavoro tout court.
L’autorganizzazione che si sta strutturando nei quartieri delle nostre città e nei nostri paesi, con la nascita di gruppi per la spesa solidare e l’assistenza alle persone più deboli, è un altro tassello di questa possibilità alla quale dobbiamo aprirci. Riscoprire i legami di solidarietà, lo spirito di comunità e la possibilità di instaurare nuove relazioni al di fuori dello sfruttamento e della messa a valore. Il primo passo fare ciò, però, è prendere coraggio per dire quello che ci sembra il concetto più lontano dalla materialità delle nostre vite.
Non torneremo a lavorare, perché il lavoro è il problema.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.