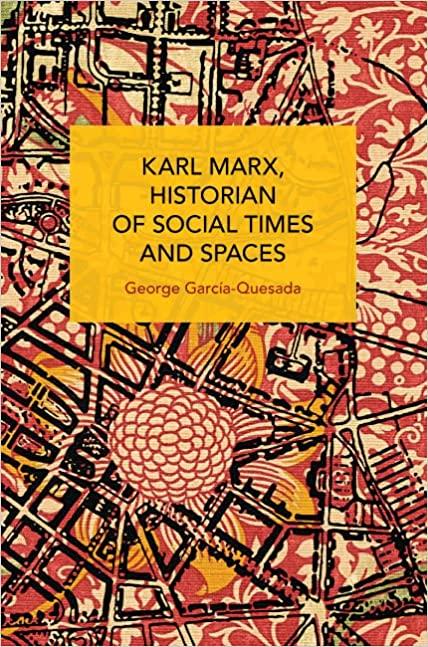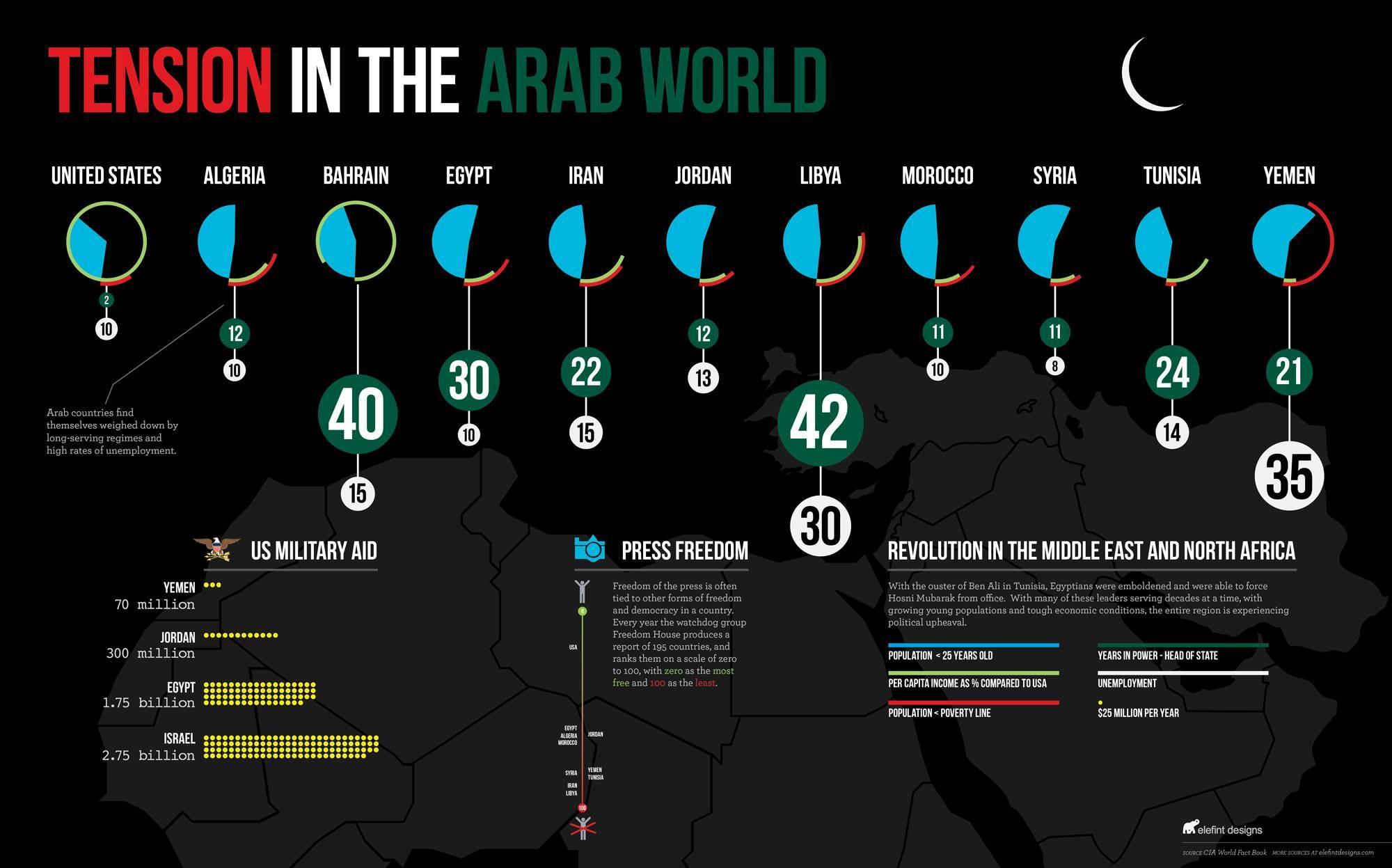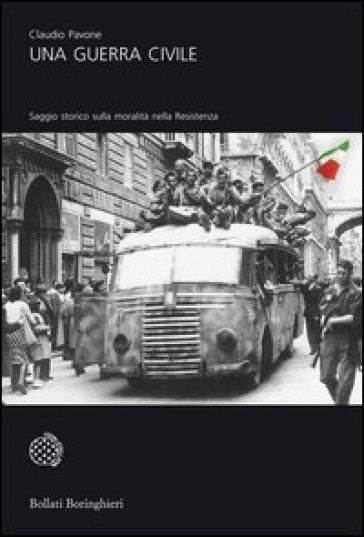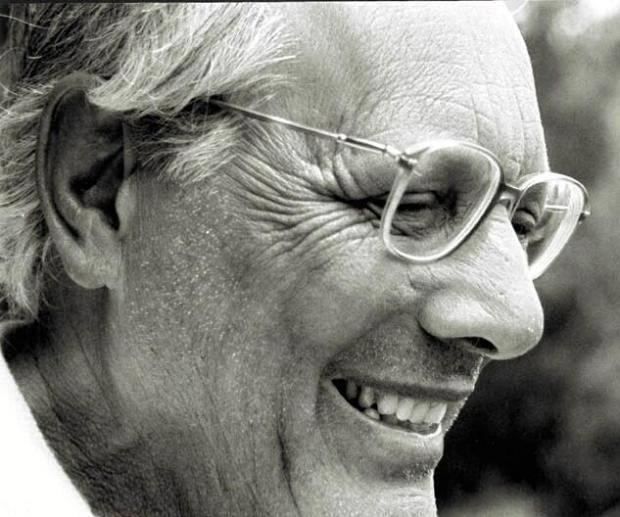Ipotesi per una public history dal basso

Premesse
Se per public history si intende una pratica neutra sempre buona volta a divulgare la storia ad un pubblico più ampio di quello specialistico, e se per uso “pubblico della storia” intendiamo l’utilizzo da parte di istituzioni e governanti della storia per legittimare il loro potere, allora il confine tra le due definizioni sfuma e rientra nel problema del rapporto tra memoria storica e presente, tra identità e modelli sociali.
“D’altronde, al di là della questione nominalistica e indipendentemente dai contesti, la storia pubblica, nel momento in cui coinvolge un pubblico ampio e attiva meccanismi di costruzione della memoria, è soggetta a scivolare in una istituzionalizzazione funzionale tanto al mercato editoriale, quanto alla dimensione politica o accademica.” In questo passaggio, tratto dall’editoriale del numero 36 di Zapruder, si pone con chiarezza, infatti, il nodo del potere, ossia “di chi è la storia?”. Interrogativo quanto mai azzeccato, che dà il titolo del numero stesso.
Di più. Forse l’esigenza di definire un campo di indagine storiografica come quello della public history è proprio il prodotto di dinamiche storiche incrociate. Una è lo svuotamento delle memorie collettive dei gruppi all’interno della società, operato dalla diffusione dei consumi di massa e dal nuovo ruolo dei mass media nella costruzione delle identità. Memorie che in qualche modo contendevano all’accademia il ruolo di custode della memoria storica.
L’altra è la crisi del rapporto tra l’accademia stessa e il tessuto sociale abitato dalla cultura di massa. Rapporto un tempo mediato da personalità e corpi intermedi della politica che funzionalizzavano, sincronizzavano e, in qualche modo, mettevano al centro le istituzioni del sapere rispetto allo sviluppo sociale. La public history sul modello statunitense può essere considerata la risposta di alcuni intellettuali a questa disconnessione. Il legame con la società si ritrova tramite il mercato e il professionista della divulgazione storica diventa il nuovo intellettuale organico al mutato paradigma.
In questo senso definire una nicchia privilegiata per la public history isolando un problema, quello del rapporto con la società, che è sotteso ad ogni indagine storica e storiografica, rischia di essere la pietra tombale per la costituzione di identità, pratiche di sociabilità e orizzonti valoriali slegati del mercato. D’altro canto però questa perimetrazione mette a nudo un problema che emerge “dallo svuotamento del ruolo della disciplina storica nei luoghi ad essa istituzionalmente deputati” come conseguenza delle politiche neoliberiste di riduzione della spesa pubblica e di trasformazione delle strutture sociali. Processo nel quale tutti gli elementi costitutivi della società si sono ricombinati lasciando la disciplina e la ricerca storica a trovare solo in sé stesse la ragione e il fine della loro pratica.
Proprio per queste ragioni strutturali risulta difficile o altamente compromissorio situarsi in canali comunicativi di massa all’interno dei quali promuovere una rielaborazione della memoria storica slegata dal mercato. Certo in alcuni casi è ancora possibile e può dare i suoi frutti, ma si tratta di dinamiche residuali, spesso legate alle singole personalità, destinate ad esaurirsi. Come detto, la nuova società produce i suoi nuovi intellettuali organici, fino all’esaurimento dei posti disponibili.
Forse nell’accademia in qualche misura uno spazio per il libero dibattito su un certo livello sarà sempre possibile, ma gli effetti che produce sul reale sono destinati ad essere sempre minori. Bisogna trovare delle modalità che eccedano l’accademia e gli ambiti del sapere istituzionalizzato per recuperare la connessione con la società. Se questa è la sfida che in controluce ci pone la public history dobbiamo in qualche modo accettarla.
Possibilità
Qui si pone però un altro nodo. Il problema dell’interazione col pubblico, come viene sollevato, sempre nel numero 36 di Zapruder, dalle riflessioni del Centro Studi Movimenti di Parma. C’è uno scollamento di un certo modo di fare storia da questo tipo di società. Essa tuttalpiù riproduce il ruolo del divulgatore professionista di prodotti storici e pacchetti turistici, Questo ci impone – come giustamente viene sollecitato – una riflessione sul come costruire senso collettivo a partire dai percorsi di ricerca intrapresi. La costruzione di una nicchia di pochi intimi in cui sentirci rassicurati dalla comprensione dei nostri codici è un rischio da tenere sempre presente.
Per questo è necessario scandagliare dove, nel tessuto sociale, si determinano fusioni e rielaborazioni della memoria storica. Anche solo un loro timido campo di possibilità. Questi spazi, questi strappi possiamo individuarli e ipotizzarli nei movimenti. Processi che attivano gruppi, soggettività subalterne, sottoculture, aggregati e composizioni sociali. Dinamiche che rimettono sul piatto permanenze e discontinuità di memorie, pratiche di sociabilità e identità. Ricombinazioni di immagini del passato in rapporto alle cause delle ingiustizie che nel presente si vogliono abbattere e dei bisogni che nel futuro si vogliono soddisfare.
È nella relazione con i movimenti e le soggettività da essi attivate che può prendere corpo un’ipotesi dipublic history dal basso che recuperi un rapporto col sociale in una dimensione potenzialmente di massa. D’altronde è proprio in questo spazio di relazione che esperienze come quella di Parma hanno preso vita e continuano a muoversi e a ridefinirsi nei propri percorsi pubblici. Nella relazione con l’esistente, in questo caso “altro” nelle sue forme espressive, riproduttive, organizzative, forse si possono tentare percorsi di ricerca storica che non rinuncino ad un rapporto col cambiamento sociale.
Seguendo alcune piste in parte già tracciate, possiamo ipotizzare che anche alcuni contesti istituzionali o paraistituzionali possano funzionare in questa direzione. Ma l’altrove determinato dai contesti sociali sovversivi deve sempre costituirsi come loro referente culturale per rendere possibile la genesi di nuovo sapere sociale antagonista all’esistente. In qualche modo si recupera al cambiamento quel che rimane del sapere sociale di classe incorporato negli istituti che ne hanno contenuto – in parte – capacità propulsive e rapporti di forza all’interno del modello sociale precedente. Nel caso contrario, assisteremo ad una sempre più rapida dispersione di questo patrimonio.
Il problema ora è rovesciato. Le condizioni di esistenza di una public history così intesa sono proporzionali alla forza, all’estensione e alla capacità di rottura dei movimenti. I problemi rilevati negli ultimi anni, dalla scarsità dei tentativi sperimentali fino ad arrivare al nodo del referente sociale possono essere ascritti allo scarso peso e presenza dei movimenti nella nostra società. Di cui la pervasività dell’egemonia culturale neoliberista è la diretta conseguenza. C’è la necessità, dunque, di stare attenti a non cadere in una dinamica attendista che, lungi dal colmarlo, divaricherebbe ancora di più lo scollamento tra ipotesi di public history e referenti sociali. Per finire costretti nella dinamica minoritaria della competizione nel mercato alla ricerca della nostra nicchia specialistica.
Si tratta invece di fare una sorta di archeologia del presente nelle pieghe del tessuto sociale. Ricercare permanenze di comportamenti, istanze, regimi di territorialità e pratiche di sociabilità sviluppate dai movimenti. Ma anche inchiestare i punti di scaturigine di nuova movimentazione e di nuova ridefinizione delle identità collettive. Cogliere gli elementi della memoria ridefiniti da queste esperienze. Allargare tramite un lavoro sulle identità l’intensità e la durata di tali emergenze e resistenze sociali. Questi possono essere i campi di possibilità di una public history dal basso, per una nuova storia.
Limiti
Da un punto di vista metodologico queste ipotesi sembrerebbero richiamare un approccio che potremmo definire “microstorico”. Sempre che si intenda “microstoria” come indagine avulsa dai processi generali, dove il risultato si concentra sui singoli casi. Dinamica che talvolta si riscontra anche negli studi dei subalterni e della marginalità. Ritrovare il legame sociale della ricerca storica solo nei campi di indagine aperti dai movimenti comporta il rischio che i grandi processi siano indagabili solo a partire dai contesti accademici e istituzionali. Almeno fino a che i movimenti non impatteranno su queste dinamiche generali.
Limiti e problemi vanno infatti individuati negli spazi circoscritti e nel campo di manovra limitato che può avere oggi un ipotesi di public history del genere. Il lavoro di allargamento e consolidamento dello spazio di azione della ricerca deve provare a colmare questa mancanza. In questo senso, dentro al processo sociale di genesi della memoria storica entra in gioco anche la “memoria dello storico”. Capacità di inquadrare in un quadro complessivo i fenomeni osservati e i risultati ottenuti. Restituzione al senso collettivo di una nuova narrazione pubblica dentro ad un contesto sociale di riferimento.
Il limite più grosso è forse quello che, individuando il legame tra lavoro dello storico e cambiamento sociale quasi unicamente nel solco dei movimenti, viene a mancare la capacità di cogliere la storia in senso generale. Piuttosto si scrive la nostra storia. Non che sia una novità. La non neutralità delle dinamiche sociali e della storia è cosa ben nota. La cosa dura da accettare è il situarsi della nostra storia ben al di sotto delle forze direzionali delle società globali. La difficoltà del situare una ricerca autonoma sul livello dei grandi processi potrebbe stare nel fatto che tali processi faticano ad essere colti da quella prassi.
Potenzialità
Proprio per il suo legame costitutivo con le lotte, il reale e il quotidiano, seppur frammentata e discontinua, un’ipotesi di public history dal basso può fare delle sua contingenza un metodo sperimentale. Un punto di partenza può essere la tessitura della memoria intorno alle lotte. Qui certamente sta il rigore della ricerca e del saggio storico. C’è però anche dell’altro. Se la costruzione di senso lascia il suo segno nel reale, sta nella materialità del cambiamento. Apre gli spazi per una rielaborazione davvero pubblica della memoria. Anche al di là delle soggettività che animano la lotta stessa.
Il rapporto con spazi urbani e territori diventa immediatamente una questione di pratica della public history. Pratica fondata in terreni da strappare al nemico. Non nella separatezza di luoghi deputati al consumo del prodotto storico. Spazi aperti, pubblici e gratuiti contro spazi chiusi, privati e a pagamento. Quando tracciamo i nostri percorsi, dobbiamo scegliere se essere guide o esploratori. Come in un videogame dove si scelgono scenari e personaggi. Con la differenza che di virtuale rimane solo il risultato. Il gioco è profondamente reale, come i suoi rischi.
La diversità di terreni e superfici in cui collocare la pratica apre subito ad un ventaglio di vettori differenti per la trasmissione dei suoi codici. Arte, pittura, musica, scultura, architettura, cinema, teatro. Materie differenti che danno forma ai loro segni. E la memoria si tesse da una baita di montagna al parchetto di quartiere, fino al murale lungo le vie della città. Lo spazio attraversato dialoga, risignifica, prende vita. La prospettiva è immediatamente multidisciplinare anche nei campi della ricerca. Trabocca verso un sapere pubblico. Verso la pratica di un public knowledge tutta da costruire.
Esempi
Oltre al caso già citato dei percorsi del Centro Studi Movimenti di Parma, particolarmente significativa è l’esperienza romana di “San Basilio, storie de Roma”, dove la memoria di un quartiere di proletari e baraccati – che nel 1974 durante una maxi-operazione di sgombero fu teatro di una vera e propria battaglia con le forze dell’ordine – si ricollega con il Movimento per il diritto all’abitare odierno tramite la figura di Fabrizio Ceruso, studente medio solidale assassinato dalla polizia nel corso degli scontri. Ma di esempi e tentativi pionieristici se ne potrebbero fare molti altri.
A Bologna, il percorso di “Resistenze in Cirenaica” – costruito da una serie di soggetti tra cui Wu Ming, il centro sociale Vag 61 e un comitato di quartiere – sta sperimentando con successo queste possibilità aprendo spazi inediti di intervento politico dal basso in una porzione del tessuto metropolitano, muovendosi tra l’identità prima coloniale e poi resistenziale delle vie rionali. In questo solco di ragionamento si colloca anche il recupero della figura di Francesco Lorusso in rapporto all’identità e alla sociabilità studentesca e precaria, operato a partire dai processi reali di territorializzazione antagonista in Zona Universitaria intensificatisi dopo la cacciata della polizia da piazza Verdi del maggio 2013.
In questi casi dietro alle persone o ai luoghi della memoria riplasmata si schiude la possibilità di ragionare sui contesti che hanno prodotto quelle figure, quei segni e quei simboli provando a proiettare una volontà di cambiamento e di azione collettiva sul presente. Date, riferimenti topografici, strade, piazze, quartieri, edifici, lapidi e monumenti si prestano ad essere traslati, tradotti e traditi dal rapporto con le lotte di oggi. Sprigionando nell’atmosfera sociale molecole di sovversione conservatesi e rimaste intrappolate sotto la coltre del dominio. Molecole – finalmente – di nuovo agitate.
Conclusione
Tuttavia i limiti alle sperimentazione di queste pratiche non risiedono solo nella debolezza delle lotte e dei movimenti. Forse in misura ben maggiore stanno nei nostri limiti soggettivi. Nei nostri metodi di lavoro. Non è soltanto questione di una filiera della ricerca che si è spezzata, anche se certamente scontiamo limiti organizzativi enormi. Questo sicuramente ci rallenta. Ma prima che nei mezzi a nostra disposizione sta nelle nostre in/capacità. Forse dovremo cominciare a chiederci per chi facciamo le domande cui cerchiamo affannosamente risposta. E organizzarci di conseguenza.
In ultima battuta, torniamo alla domanda “di chi è la storia?” Possiamo dire che se intendiamo la storia come un processo generale che coinvolge tutta l’umanità direzionandone la riproduzione sociale, ecco possiamo dire che oggi questa storia non è nostra. Forse quando diciamo che la nostra storia è ancora da scrivere intendiamo questo. Forse un passato rapporto di forza ci ha fatto accarezzare le leve di questa storia. Una cosa però è certa. Allo stato di cose presente, non siamo certo noi a scriverla. Abitiamo in una storia che ci è nemica. Questo è il nodo che un’ipotesi di public history dal basso deve provare ad aggredire.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.