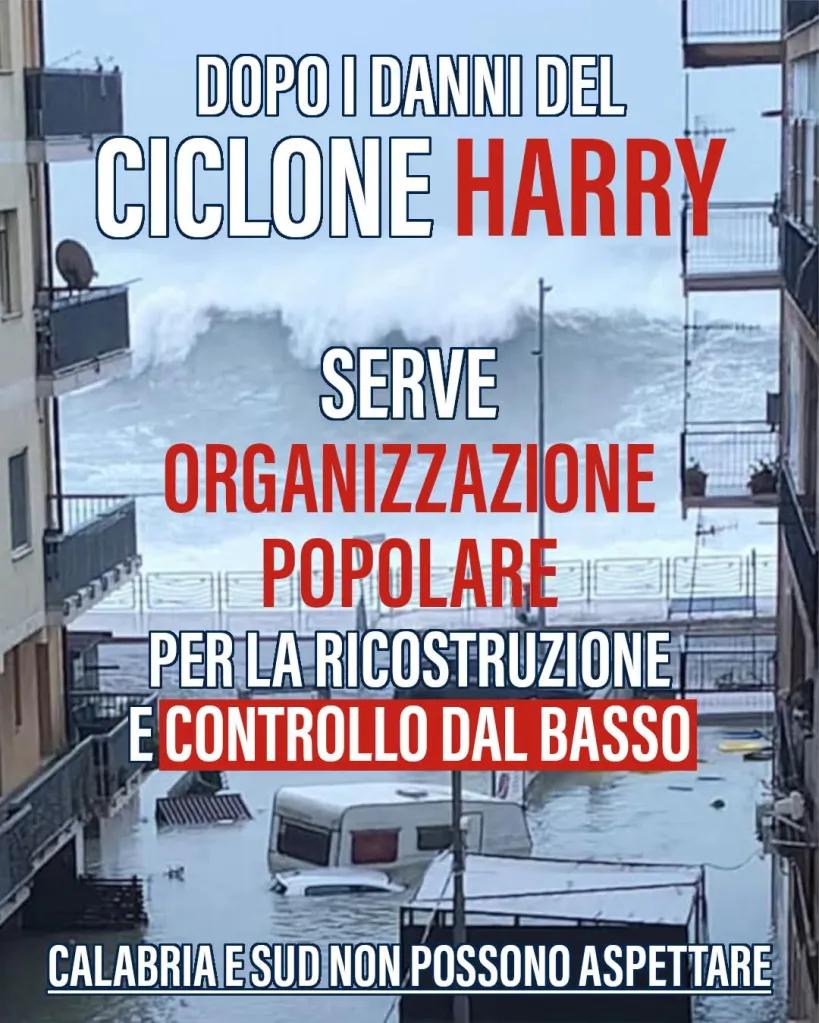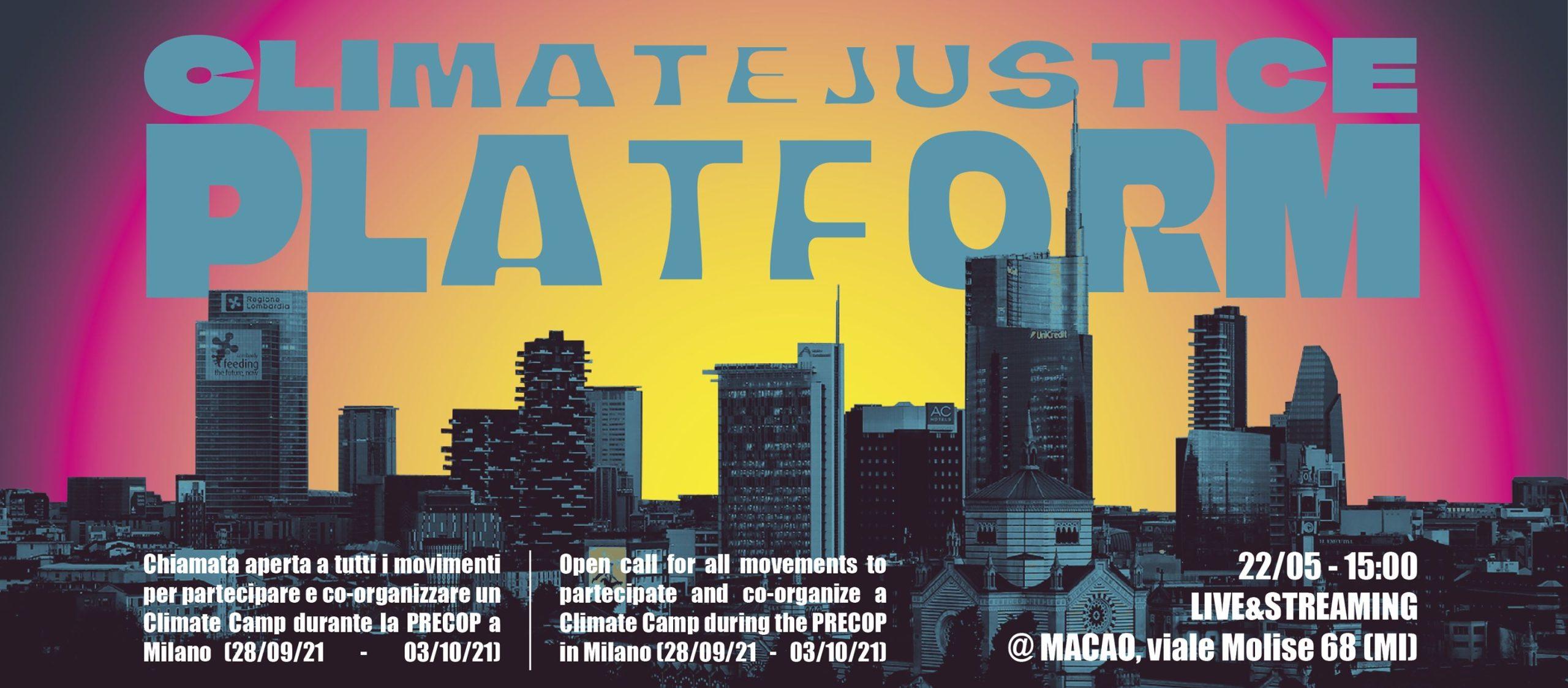La “transizione ecologica”: appunti per la mobilitazione

Riprendiamo da Rise Up 4 Climate Justice questi appunti sulla transizione ecologica in vista delle mobilitazioni del 12 maggio contro Eni e di quelle che seguiranno…
Il tema della transizione ecologica sta acquisendo un nuovo spazio non solo nel dibattito pubblico, ma – e questa è la più grande novità – anche nell’ambito della politica e delle politiche istituzionali italiane.
I temi della sostenibilità ambientale e di una riconversione a modi più ecocompatibili di produrre, consumare e in generale organizzare l’esistenza nelle società tardo-capitaliste erano già, ovviamente, presenti a largo spettro. Durante il 2018 e 2019, le mobilitazioni sociali in particolare di Fridays For Future, Extinction Rebellion e dei comitati territoriali avevano portato questi elementi all’attenzione dell’opinione pubblica e della governance. Tuttavia, la situazione di crisi generata dal Covid-19 sta gettando le basi per una nuova forma di protagonismo del green che è necessario interrogare criticamente.
Lo Stato e il grande capitale si stanno appropriando discorsivamente dell’agenda ecologista, col rischio che la radicalità delle sue rivendicazioni possa vedersi diluita e in parte riassorbita in un sistema che continuerà a essere iniquo, escludente e violento pur mostrando un “volto verde”. Per questo motivo, sarà necessario per tutti i soggetti e le realtà di movimento affinare le proprie lenti di lettura di questo processo, svelarne le contraddizioni, smontarne il progetto falsamente riformatore, costruire immaginari per forme di socialità e co-abitazione radicalmente differenti, liberate dalle logiche mortifere del capitale, capaci di cura per la vita e il vivente nel suo complesso.
La pandemia di Covid-19 segna un punto ambiguo, di rottura e continuità al contempo, rispetto al passato e in particolare alle forme di govenance nell’ambiente neoliberale. Ne eredita una certa modalità di costruzione della “natura”, politica, ontologica, epistemologica ma anche materiale: uno spazio fluido da navigare e manipolare a piacere, mettere a valore in quanto materia che lavora per il capitale – non solo l’ovvio caso dell’estrazione di risorse e sfruttamento dei territori, ma anche le forme più sottili in cui habitat selvaggi si tramutano in “servizi ecosistemici” da vendere sul mercato.
Come già nei decenni passati, la crisi ecologica smette di diventare ostacolo all’accumulazione, ma diventa strumento stesso del suo rilancio, occasione di profitto. Tuttavia, se fino a oggi la green economy era stato solo uno degli ambiti in cui la “crescita” capitalista andava delineandosi, nel presente assistiamo alla centralità della conversione verde quale strumento di uscita da una crisi inaudita e profondissima. Crisi che, peraltro, è da attribuire precisamente alle conseguenze devastanti di un sistema che sacrifica costantemente la vita al profitto: distruggendo gli habitat selvaggi, smantellando servizi di cura, proteggendo gli ambiti del lavoro produttivo e nocivo, questo sistema ha di fatto prodotto la pandemia.
Ripartenza e resilienza?
Sembra tuttavia impossibile che un sistema le cui logiche sono così in contraddizione con quelle della riproduzione della vita – e che nel corso della sua storia si è dimostrato incapace di riconoscere qualsiasi limite (materiale, etico, discorsivo) alla propria espansione – possa farsi promotore di una transizione realmente volta alla sostenibilità ambientale e alla giustizia sociale. E infatti, mentre leggiamo le bozze del PNRR e ascoltiamo le dichiarazioni dei ministri e dei tecnici maggiormente coinvolti nel rilancio dell’economia post-pandemica, due sembrano le logiche di fondo che guidano la “transizione” e che sarà importante per i movimenti considerare e interrogare criticamente in futuro:
1) Il greenwashing. Si tratta di una dinamica già largamente denunciata. Di fronte a una crescente ingiustificabilità delle forme estrattive, distruttive e nocive della produzione capitalista, il capitale si “veste di verde”, dichiara attenzione all’ambiente e si mostra promotore di economie circolari, efficientamento energetico, economie verdi. Tuttavia, si tratta per lo più di una facciata che nasconde il cosiddetto business as usual: la continuazione di pratiche ecologicamente devastanti, che generalmente hanno luogo in territori considerati “secondari”, coloniali, sacrificabili. Territori in cui si suppone che i soggetti siano disposti ad accettare il ricatto capitalista ma in cui, se non lo fanno, è possibile procedere con pratiche oppressive e repressive senza che la cosa susciti scalpore. ENI rappresenta bene questi processi: si mostra verde, eco-compatibile, anzi paladina di una riconversione ecologica delle forme di produzione e distribuzione dell’energia. Cosa che le dà peraltro potere nel dibattito pubblico, nell’educazione e nella creazione di un immaginario green attraverso i famosi e scandalosi programmi per le scuole e il finanziamento di progetti di ricerca per l’università. Al contempo – mentre gli investimenti in energia rinnovabile e verde ammontano più o meno al 2% del suo intero fatturato – ENI prosegue imperterrita progetti di estrazione di combustibili fossili in territori “marginali”. Alla facciata verde e umana che presenta nel “centro” geografico del capitalismo italiano, contrappone pratiche di sfruttamento, espropriazione e nocività nei territori della “periferia” – siano essi interni all’Italia stessa (Basilicata) o esterni (Nigeria).
2) Un ulteriore sviluppo del capitalismo “verde” e l’intensificazione delle dinamiche di messa-a-valore della “natura”. Mentre il greenwashing è principalmente spettacolo, facciata ideologica che permette la continuazione dello status quo e legittima, nascondendoli, processi anti-ecologici, in questo caso si dà di fatto una trasformazione materiale dell’assetto produttivo (e riproduttivo) del regime capitalista. Ci si muove cioè nell’ambito dell’innovazione in campo ecologico, nonché secondo la retorica dell’internalizzazione dei costi ecologici all’interno dell’economia. Pensiamo ad esempio ai grandi progetti di investimento nelle fonti di energia rinnovabile e nell’“economia circolare”, ma anche all’istituzione di strumenti finanziari che dovrebbero regolare e rendere poco vantaggiose le attività inquinanti e climalteranti (per esempio i mercati del carbonio). Nell’idea che la crisi ecologica possa essere risolta attraverso strumenti di mercato e l’internalizzazione della “natura” nell’economia, si delinea sempre più un “mondo-fabbrica” in cui non esiste più vita fuori dal capitale o limite che non possa divenire fonte di valore. Questo modello avrà sicuramente crescente importanza nel futuro e si tratta del campo più spinoso su cui agire, poiché di volta in volta richiederà di contestare sulla base di rivendicazioni ecologiche opere, strumenti e progetti che si presentano come ecologici essi stessi.Rispetto a questo secondo punto, ciò che fin da subito si può dire è che l’incapacità del capitale di portare avanti una conversione realmente sostenibile delle attività produttive, del consumo, della riproduzione sociale è evidente da molti decenni. Qualsiasi sforzo “verde” ha dimostrato contraddizioni, conflitti e violenza su tutti i piani. Dai mega-parchi eolici che hanno distrutto territori e comunità, alle promesse di digitalizzazione e di sharing economy – che non solo si basano su estrazione e ulteriore danno ecologico e umano, ma hanno anche dimostrato di innescare processi di monopolio e degrado della vita sociale e del lavoro (basti pensare alla gentrification e all’esclusione dai centri storici di migliaia di località turistiche per effetto di AirBnB) è già possibile notare alcune linee di esclusione, danno e sfruttamento su cui agisce il capitalismo verde:
Questi punti possono essere ricondotti più o meno direttamente ad alcune dinamiche tipiche dei processi di valorizzazione e accumulazione del capitale. Nel dettaglio, il capitalismo green mantiene la stessa necessità di espansione in principio senza limiti (che richiede una costante immissione entropica di materia ed energia nel sistema); lo stesso sfruttamento e l’appropriazione di lavoro e risorse non pagati ai fini dell’accumulazione; la medesima conversione del mondo intero in quantità senza qualità, in cosa da scambiare sul mercato. In aggiunta a ciò, proprio per la sua tendenza a internalizzare i limiti, il green capitalism si pone come l’unica possibilità di superamento della crisi che il suo “predecessore” ha scatenato: non prevede un’alternativa, né la lascia prevedere fornendo apparentemente soluzioni a ogni problema.
Il tentativo di scongiurare e negare le contraddizioni si scontra tuttavia con la consapevolezza di un’alternativa possibile, in cui le forme di vita costruiscono reti e alleanze oltre i termini del valore e del profitto.
Lavoro e natura
Nel capitalismo, la nostra sussistenza dipende dal posto di lavoro e quest’ultimo dipende dalla crescita infinita del Pil, che però è proprio il motore della crisi ecologica che stiamo vivendo. La transizione “verde” che si prepara con il Recovery Plan è tutta interna al paradigma che separa la riproduzione della vita dalla produzione di merci e subordina la prima alla seconda. Un’opposizione alla logica insostenibile del profitto che non si ponga il problema dell’accesso universale alle risorse necessarie a una vita degna, indipendentemente dalla produttività di ciascunə, sarà sempre e solo una campagna d’opinione elitaria e quindi perdente.
In questo senso, una piattaforma di lotta complessiva e antagonista contro il cambiamento climatico deve articolare su scala globale sostenibilità e redistribuzione, qualità e quantità. Le rivendicazioni qualitative sono quelle che tendono alla trasformazione del continuum produzione-consumo in direzioni di reale sostenibilità ambientale. Parliamo in pratica di produzione diffusa di energia da fonti rinnovabili, agroecologia, filiere corte, stop agli allevamenti intensivi, prevenzione della proliferazione di rifiuti tramite riuso e durabilità, ecc. Le rivendicazioni quantitative sono quelle che rendono tale trasformazione socialmente possibile e desiderabile attraverso la redistribuzione della ricchezza, garantendo anche la piena continuità di reddito ai lavoratori e alle lavoratrici dei settori in transizione. Parliamo dunque di riforme del sistema fiscale in senso radicalmente progressivo, riduzione dell’orario di lavoro senza perdita di salario, reddito medio universale, espansione dei beni e servizi di welfare non mercificati, ecc.
Senza trasformazione qualitativa, la redistribuzione si riduce a un “consumismo operaio” tutto interno alla crisi ecologica. Senza redistribuzione quantitativa, la trasformazione ecologica si riduce a co-gestione del degrado ambientale ai margini e mera colpevolizzazione dei consumi individuali. La linea che separa conquiste che vanno verso un’autentica sostenibilità ambientale e manovre di greenwashing e appropriazione capitalista dell’ecosistema è spesso sottile. Ma la differenza è data dalla misura in cui questi cambiamenti si iscrivono in percorsi di lotta e in una prospettiva di alternativa sistemica, incompatibile con la riproduzione di lungo termine del capitalismo.
Una mobilitazione transnazionale
La strategia e gli obiettivi di Rise Up 4 Climate Justice hanno fin dall’inizio avuto un approccio anticapitalista che fosse in grado di intersecare gli innumerevoli frammenti di sfruttamento del vivente. Allo stesso tempo, si è dato nemici chiari, coloro che maggiormente sono responsabili delle devastazioni, del degrado ambientale, del cambiamento climatico inteso come processo storico-culturale e non solo scientifico.
Le multinazionali del fossile da tempo sono state indicate come “responsabili”, ma l’evidenza dei danni da loro causati non è sufficiente a bloccare le sue attività: sono troppi gli interessi politici e strategici per fermare l’azione devastatrice di questa azienda. Assistiamo inoltre alla continua esclusione delle comunità dalle decisioni che riguardano i loro territori. L’esempio più recente è rappresentato proprio dal PNRR e dalle scelte sulla cosiddetta transizione ecologica: i processi decisionali sugli investimenti economici fondamentali di questo periodo non hanno coinvolto gli enti locali e territoriali, le cittadine e i cittadini. Le istanze sociali e ambientali che animano i territori sono rimaste inascoltate se non direttamente represse. L’indicazione istituzionale, dunque, indica nelle pratiche individuali l’unica risposta alla crisi climatica, mentre lo Stato, assieme alle lobby energetiche e alle multinazionali del fossile, dovrebbe occuparsi della transizione ecologica e della ricerca di un modello sostenibile. Abbiamo già spiegato le ragioni per cui non possiamo accettare una tale divisione dei compiti: per poter creare una vera transizione ecologica è fondamentale dare voce ai territori, a chi li conosce e a chi li abita; è necessario far sentire tutte e tutti insieme la nostra voce, pretendere l’estromissione di Eni e di tutte le compagnie del fossile da quello spazio che dovrebbe invece essere riservato a chi i territori li conosce e li vive.
Eni è solo l’esempio italiano delle tante compagnie che provocano distruzione e devastazione ovunque nel nostro pianeta. Lo sfruttamento dei territori è globale, e tale sarà la nostra risposta. La campagna #ManyAgainstEni si inserisce all’interno di una cornice ben più ampia che vedrà, durante il mese di maggio, il proliferare di azioni contro i veri attori del cambiamento climatico. Uniremo le nostre lotte e le nostre voci, per chiedere tuttə insieme la fine dello sfruttamento dei nostri territori. Migliaia di persone manifesteranno insieme a noi in tutto il mondo, tantissimi movimenti per la giustizia climatica protesteranno, bloccando a loro volta le assemblee degli azionisti si altre compagnie. Così faranno #ShellMustFall, Shale Must Fall, Polluters Out, Ende Gelände, BP or not BP, XR International e tanti altri movimenti.
Perché ENI?
È risaputo che il colosso energetico italiano sia uno dei principali artefici dell’estrattivismo, quella strategia che continua a estrarre valore dal lavoro umano e non umano, dalle risorse naturali e dalla biosfera nel suo complesso. Lo fa in modo violento e climalterante, spesso avvalendosi della complicità dei governi nazionali dove opera, ma soprattutto del governo italiano. Una recente inchiesta di Re:Common dimostra quanto sia rilevante il peso di Eni sulla politica estera italiana, tanto che la protezione dei suoi asset petroliferi ha motivato persino alcune delle missioni militari tuttora in corso.
Negli ultimi anni, Eni è rimasta stabilmente in testa alla lista delle società italiane per quantità di fatturato annuale ed è tra le prime 10 compagnie energetiche al mondo. Un giro d’affari che si trascina dietro una scia di devastazioni ambientali, violazioni di diritti umani, processi per corruzione internazionale e la fa risultare tra le prime 30 compagnie che hanno emesso più anidride carbonica nel settore industriale dal 1985 al 2015, stando ai dati del Carbon Major Report.
Con il Recovery Plan alle porte, Eni, come altre multinazionali del fossile, si sta garantendo una fetta importante di finanziamenti pubblici, grazie ai quali darà avvio a strategie di riconversione che agiranno solo marginalmente su un core business ancora fortemente radicato all’economia fossile più tradizionale. Parte di questi finanziamenti verranno investiti tecnologie come il CCS (carbon capture and storage), lo stoccaggio di carbonio emesso da varie attività produttive, la cui sostenibilità ambientale ed economica è stata messa in discussione di recente dalla stessa Corte dei Conti.
Quello che più preoccupa, è che molte di queste risorse pubbliche verranno utilizzate da Eni per proseguire la campagna comunicativa che ha come unico obiettivo quello di ristrutturare la propria immagine pubblica, messa fortemente in discussione dai processi di corruzione internazionale degli ultimi anni, ma anche dalle campagne politiche dei movimenti ecologici, che hanno da tempo indicato “il cane a 6 zampe” come uno dei principali responsabili del climate change e dell’impoverimento del pianeta e della maggior parte di persone che lo abitano.
L’attività estrattiva di Eni è intrinsecamente legata al saccheggio di aree geografiche più o meno grandi e, talvolta, di interi continenti. Da più di mezzo secolo, Eni e gli altri giganti del petrolio assediano e devastano l’Africa, e in particolare le terre del delta del Niger.
Uno scandalo di proporzioni internazionali, certificato da un rapporto (del 2011) dello United Nation Environmental Programme (Unep), ha rivelato che alcuni pozzi, utilizzati dai villaggi per bere, lavarsi e cucinare, contenevano livelli di benzene (un idrocarburo aromatico cancerogeno) mille volte oltre le soglie ammesse in Nigeria (3 µg/L).
Gli abitanti del delta del Niger da decenni lamentano che le perdite di tubi-colabrodo, con scarsa manutenzione e poca sicurezza, causano inquinamento (e in alcuni casi incendi) mettendo in pericolo la loro sussistenza. Istanze che sono state finalmente accolte da un tribunale lo scorso febbraio, quando la Corte Suprema del Regno Unito condannava la multinazionale olandese Shell per i danni ambientali causati da questi sversamenti, che la stessa Shell ha avuto il coraggio di definire “sabotaggi”,
Ma la Corte, oltre a ritenere evidentemente non provata questa eventualità, ha chiesto a Shell di installare sistemi di rilevamento delle perdite negli oleodotti in questione. Un banale sistema di sicurezza che Shell non aveva ritenuto necessario utilizzare.
Sono oltre 500 i riversamenti all’anno da parte di Eni e Shell nel delta del Niger, più di una perdita al giorno da anni.
Lə nigerianə solo figliə di un dio minore?
Eni e Shell possono devastare e uccidere indisturbate?
Più attivistə nigerianə sono stranamente scomparsə dopo essersi ribellatə alle politiche di Eni, la soluzione è far sparire chi cerca di far uscire la verità ?
Anche in aree molto più vicine a casa nostra, l’attività di Eni produce devastazione. In Basilicata, dove la multinazionale opera dagli anni ‘80, la stessa logica estrattivista sta facendo emergere i suoi frutti nocivi ai danni del territorio e di coloro che lo abitano.
Nel 2002 è avvenuto un grave incidente all’impianto di desolforazione del centro Oil di Viggiano, con conseguente immissione nell’atmosfera di grandi quantità di gas inquinanti. L’azienda ha provato a oscurare le conseguenze dell’incidente senza fermare la produzione e facendo così respirare ai cittadini della Val d’Agri gas tossici e nocivi. Dati alla mano, nonostante questi siano ancora nascosti, una delle conseguenze più evidenti sulla salute pubblica è il drammatico aumento dell’incidenza di patologie tumorali e malattie al sistema cardiocircolatorio e respiratorio, in particolare per bambini e adolescenti.
Caso più recente, nel 2016, è lo sversamento di 400 tonnellate di petrolio che ha causato la contaminazione delle falde acquifere. L’incidente ha anche portato al presunto suicidio dell’ex responsabile della produzione del centro, a seguito dei molteplici tentativi di denuncia del rischio ambientale e sanitario del disastro causato e messo a tacere in ogni modo dall’azienda.
Solo negli ultimi 16 anni risultano contaminati 26mila metri quadri, pari al 15% dell’area del centro Oil Val D’Agri. Secondo la magistratura sono state smaltite irregolarmente più di 854mila tonnellate di sostanze pericolose che hanno prodotto eccessi di mortalità e enormi conseguenze sul piano sanitario.
Le nostre rivendicazioni nei confronti di ENI sono chiare:
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.