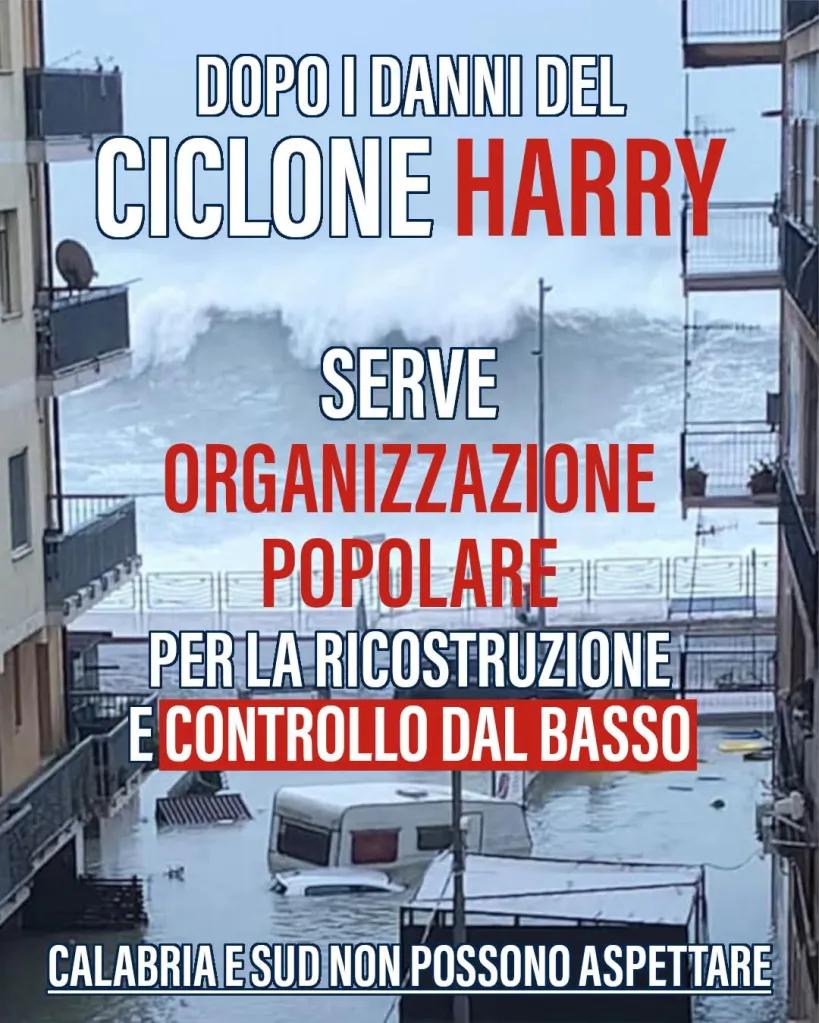Riprendere la terra dalle macchine. Manifesto della cooperativa L’Atelier paysan
Questo testo è tratto dall’introduzione del libro de l’Atelier Paysan, Reprendre la terre aux machines. Manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire. pubblichiamo questo articolo in vista della terza edizione del Festival Altri Mondi / Altri Modi che si terrà dal 10 al 13 aprile a Torino. L’Atelier Paysan sarà presente al dibattito “Ipotesi di riproduzione nella crisi della riproduzione sociale: contro l’estrattivismo, per un’altra agricoltura” del 13 aprile alle ore 18.
Buona lettura!
Da dieci anni la cooperativa l’Atelier Paysan, con sede nell’Isère, lavora per l’adozione diffusa di un’agroecologia contadina, con l’obiettivo di cambiare il modello agricolo e alimentare. A tal fine, supporta gli agricoltori nella progettazione e nella produzione di macchinari e di edifici su misura per le loro esigenze. In un momento in cui la meccanizzazione su larga scala si diffonde, aumentando la concentrazione delle terre e la distruzione dell’ambiente, i progetti e le realizzazioni dell’Atelier Paysan coniugano la logica dell’aiuto reciproco, la riflessione approfondita sulle tecniche e il lavoro, e un ambizioso progetto politico. In questo libro, un vero e proprio manifesto politico, gli autori – contadini, sindacalisti, attivisti e membri della cooperativa – fanno notare che le alternative contadine, per quanto incredibilmente ricche, si stanno rivelando innocue di fronte al complesso agroindustriale, più predatorio che mai. Affermano l’urgente necessità di uscire dal confinamento in nicchie di un mercato alimentare riservato alle classi più ricche e di riprendersi interamente la terra dalle macchine. Questo manifesto propone modi di rompere con il passato per andare in questa direzione.
Una pesante nebbia invernale, aggrappata al terreno già piuttosto unto per la stagione, sembra avvolgere il capannone in parte aperto sull’aia. Favorito dalla stanchezza, il freddo umido trafigge i corpi. Nel piccolo ufficio adibito a sala relax, la superficie del tavolo è costellata di tondi di caffè: è stata una settimana intensa. Gli agricoltori e il loro entourage stanno sgranocchiando baguette e tirando gli ultimi fili dei telai. Alcuni ridono, altri brontolano, ma tra due colpi di macinino sono tutti impegnati a dare gli ultimi ritocchi alle macchine, questa volta seminatrici da sovescio. Erano in undici con l’istruttore e sono al lavoro da lunedì mattina, la maggior parte di loro non aveva mai lavorato con il metallo. Questo venerdì sera, ognuno se ne andrà con la propria creazione: otto seminatrici in tutto, in tre varianti. C’è odore di limatura, c’è odore di aiuto reciproco, è un cambiamento rispetto agli odori di tutti i giorni. Eppure conoscono bene l’odore del cuoio, del fieno, degli animali, della pioggia e, naturalmente, della terra. Si parla anche di riprendersi la terra dalle macchine.
Macchine come macchine agricole da guerra, ma anche come macchine economiche, industriali, burocratiche, macchine per nutrire o piuttosto per riempire. La terra da riprendersi è una metafora, perché c’è molto di più da riprendersi… Tutti sanno che quando questa sera torneranno nelle loro fattorie, l’industria sarà ancora lì, approfittando di ogni shock per diffondersi ancora di più, eliminando il know-how, la comunità agricola, ma anche la biodiversità e, in definitiva, la conoscenza e la capacità di nutrirsi. Il danno sanitario e sociale è colossale, non meno di quello ambientale. Non tutti hanno accesso al cibo e sono i più poveri a soffrire di malattie croniche come il diabete, l’ipertensione, l’obesità e il cancro. Eppure, queste patologie sono, in tutto o in parte, legate al cibo industriale, all’eccesso di grassi, zuccheri e sale che contiene, ai residui di pesticidi e altri interferenti endocrini e all’ultra-lavorazione dei prodotti agricoli.
Allo stesso tempo, in televisione, un presidente francese ci dice: “È una follia delegare ad altri il nostro cibo, la nostra protezione, la nostra capacità di curare noi stessi e il nostro ambiente di vita”. Allo stesso tempo, la FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles, un sindacato agricolo di estrema destra francese), che da sessant’anni collabora con il governo per l’industrializzazione dell’agricoltura francese, si appropria silenziosamente dello slogan della “sovranità alimentare”, da tempo appannaggio dei movimenti di difesa dell’agricoltura contadina in Europa e soprattutto nei Paesi del Sud del mondo, raggruppati in Via Campesina. A ogni nuova catastrofe, la stampa si riempie per qualche giorno di domande a volte radicali sul libero scambio generalizzato, sulla divisione internazionale del lavoro, sulla perdita totale della sovranità e dell’autonomia alimentare in un Paese come la Francia. Nessuna di queste dichiarazioni si è tradotta in azione. Siamo tutti d’accordo che i risultati di un secolo di industrializzazione dell’agricoltura e del cibo che produce sono catastrofici. Eppure mancano ancora le forze politiche per rovesciare questo modello e sostituirlo con un altro.
Questo libro vuole mettere in discussione questa situazione di stallo.
Per molti dei nostri colleghi e complici del movimento contadino, il tempo lavora a nostro favore e il passaggio a un’agricoltura diversa è già ben avviato: aumenta la quota di mercato dei prodotti etichettati come “biologici”, si sviluppano i canali di distribuzione corti, si moltiplicano le AMAP e i negozi dei produttori, ecc. Ma il modello agricolo dominante è minato da questi sviluppi, da questi cambiamenti nelle pratiche individuali di produttori e consumatori? No. Al contrario.
Al contrario, sono aumentate negli ultimi anni, con un incremento delle vendite del 22% tra il 2009 e il 2018!
I terreni coltivabili continuano a ridursi a favore del cemento, a un ritmo di 26 m² al secondo – ovvero un campo da calcio ogni cinque minuti, o un dipartimento francese medio ogni dieci anni. Il numero di persone che lavorano in agricoltura continua a diminuire al ritmo del 2% all’anno, per cui ogni settimana scompaiono decine di aziende agricole. E chi resta lavora in aziende che diventano sempre più ad alta intensità di capitale: macchine più grandi, superfici più ampie, edifici più costosi e debiti più pesanti.
La comunità contadina continua a sperare che le sue alternative si diffondano e cambino la società. Noi veniamo da questo ambiente, abbiamo condiviso questa convinzione. Continuiamo a praticare, ma non ci crediamo più: per quanto valide, queste alternative (sulle sementi, sulla terra, sulle pratiche colturali, sui metodi di commercializzazione, sulle tecnologie a basso impatto e appropriabili messe insieme nel nostro Atelier Paysan) non costituiscono un progetto politico in sé, né mettono in pericolo l’agricoltura industriale. Piuttosto, la completano, soprattutto per quanto riguarda l’alimentazione delle fasce ricche della popolazione. Per quanto ci riguarda, sono le pratiche agroindustriali che tendono ad assorbire o a neutralizzare le nostre alternative, a radicarsi profondamente nei nostri paesaggi e nelle nostre abitudini. In particolare, vediamo che la costante escalation della tecnologia, raramente vista come un fattore decisivo, sta assicurando la continuazione del movimento di espropriazione ed eliminazione dei contadini contro cui stiamo lottando.
Allora perché non lanciare un appello solenne ai leader del governo francese (o alla Commissione europea) per convincerli dell’urgenza di politiche pubbliche dedicate a una rapida transizione verso l’agroecologia, come hanno fatto i membri della Convenzione dei cittadini sul clima nell’estate del 2020? Chi di noi è impegnato nei sindacati, ad esempio, cerca regolarmente di influenzare la direzione presa dal Ministero dell’Agricoltura, senza ottenere risultati significativi. Uno sconvolgimento così importante come il passaggio dall’agricoltura industriale come la conosciamo all’agricoltura contadina – non più praticata da pochi “indiani” nelle “riserve” del territorio devastato, ma dalla maggioranza su scala di una nazione come la nostra – non sarà concesso dalle élite politiche ed economiche senza l’emergere di un movimento sociale. Non avverrà mai senza un equilibrio di potere accettato, un conflitto complicato di cui cercheremo di definire le aree prioritarie in questo libro. O sarà conquistata con la lotta o non avverrà.
Questo manifesto vuole essere un modesto contributo alla nascita di un ampio movimento popolare per l’autonomia contadina e alimentare, una richiesta che richiede alcune precisazioni. Innanzitutto, un aspetto importante di ciò che diciamo è il rifiuto definitivo di dissociare la questione agricola da quella alimentare: non pensarle insieme significa avvalorare la separazione tra produzione e consumo, che il capitalismo industriale non ha inventato ma che ha spinto all’estremo. Criticare l’agricoltura industriale e lottare contro di essa significa denunciare l’espropriazione delle popolazioni contemporanee, in particolare di quelle urbane, dal loro cibo e la disuguaglianza economica strutturale che ne caratterizza l’accesso. Non si potrà cambiare il modello agricolo senza fermare l’impoverimento di decine di milioni di cittadini; né si potrà garantire il rispetto del diritto all’alimentazione senza lottare per la generalizzazione dell’agricoltura contadina. Si tratta di un diritto universale all’alimentazione scelto con cognizione di causa.
In altre parole, stiamo mettendo in discussione una scelta fondamentale – una scelta politica, una scelta culturale, una scelta di civiltà – fatta dalle società industrializzate alla fine della Seconda guerra mondiale: quella di produrre cibo al minor costo possibile, nella speranza che tutti possano mangiare a basso costo, soffocando così le richieste salariali e popolari. Come vedremo nel primo capitolo, la modernizzazione dell’agricoltura fu effettivamente il risultato di politiche deliberate basate su ideologie affermate. La logica industriale fu introdotta deliberatamente, con la “generosa” motivazione che era necessario nutrire la nazione e poi il mondo. La riduzione della quota del bilancio familiare destinata all’alimentazione era vista come un progresso in sé.
Ed è così che è effettivamente scesa dal 35% nel 1960 al 20% nel 2014: il consumo di cibo è aumentato in volume in questi decenni, ma alla metà del tasso di consumo complessivo.
Il paradosso è che, al giorno d’oggi, una parte significativa della popolazione di un paese ricco come la Francia non può permettersi il cibo che vorrebbe scegliere, e a volte non può nemmeno permettersi il cibo più economico disponibile nei supermercati. L’altra faccia di questa triste realtà è che circa il 70% del reddito degli agricoltori proviene da sussidi nazionali ed europei; la metà di loro ha un reddito negativo, al lordo di tasse e sussidi, e questa percentuale sale all’80% tra gli allevatori; e anche dopo i sussidi, il 14% non ha alcun reddito! È un quadro sconcertante. È l’immagine di un sistema che non funziona affatto, che – senza parlare dei danni ecologici, dei rendimenti energetici negativi o della perdita di qualità nutrizionale – non raggiunge nessuno dei suoi obiettivi iniziali: pagare adeguatamente gli agricoltori, in modo che forniscano cibo abbondante e soddisfacente alla portata di tutti. Per essere più precisi, c’è sì abbondanza, ma di prodotti malsani e di insicurezza economica.
Proponiamo quindi un completo riorientamento, una profonda rottura con il passato: la fine della corsa ai costi di produzione più bassi in agricoltura; la sottrazione di importanti aree della produzione agricola, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti alla pressione del mercato globale e il passaggio alla socializzazione del cibo; la fine della subordinazione dell’agricoltura ad altri settori economici.
Dal 1945, in Francia come in tutti i Paesi “avanzati”, l’agricoltura è stata la “funzione di supporto” dello sviluppo industriale. La sua modernizzazione è servita a sviluppare i mercati per una serie di industrie, sia a monte che a valle della sua produzione, e su questo torneremo in più di un’occasione. Inoltre, ha liberato potere d’acquisto per altri consumi essenziali per la crescita: abitazioni, trasporti, “nuove tecnologie” e così via.
Sono necessarie alcune precisazioni semantiche: quando definiamo il nostro orizzonte politico in termini di autonomia contadina e alimentare, perché parliamo di autonomia e non di sovranità? Come tutto il movimento per la difesa dell’agricoltura contadina, siamo legati allo slogan storico della sovranità alimentare. Se preferiamo il termine “autonomia”, non è per il piacere di prendere le distanze dalle frottole dell’apparato sindacale maggioritario che si prende il merito dei nostri obiettivi quando ha fatto di tutto per distruggere le condizioni per raggiungerli. Soprattutto, la vediamo come un’opportunità per staccarci un po’ di più dalla fantasia di potere e competizione che il termine sovranità ancora trasmette. Etimologicamente, “sovrano” deriva dall’aggettivo latino superus: ‘superiore’, “che supera tutti”. Il sovrano è colui che è al di sopra di tutti; l’espressione stessa di sovranità popolare è quindi una sorta di ossimoro, un gioco di prestigio semantico volto a rendere compatibili le aspirazioni di libertà e autogoverno dei cittadini con l’esistenza di uno Stato che, in realtà, decide il destino dei suoi sudditi. Evoca l’idea di un popolo particolare che ha trovato i mezzi per dominare gli altri, per mantenersi al di sopra di loro nella corsa al potere. Quando Macron o la FNSEA invocano la sovranità economica o alimentare della Francia (o dell’Europa), parlano solo di riprendere il controllo di alcune leve che avevano finito per sfuggire loro nella competizione internazionale, e che sembrano essenziali per ottenere i migliori risultati possibili in quella competizione. Il concetto di autonomia, che etimologicamente significa darsi una propria legge, si basa su un immaginario più sovversivo: la democrazia effettiva, la partecipazione attiva ed egualitaria all’elaborazione delle regole della vita comunitaria, anche in campo economico, e l’autolimitazione degli individui e della comunità. Parlare di autonomia contadina e alimentare significa affermare la necessità di una deliberazione politica e popolare nella produzione del cibo, nelle scelte tecnologiche in agricoltura, nella distribuzione della terra a chi la lavora, nella distribuzione del cibo a tutti. Significa introdurre la necessità di una riflessione collettiva sui nostri bisogni e sui mezzi che usiamo per soddisfarli, di un’autolimitazione: devo comprare più terra dal mio vicino che sta andando in pensione o è appena fallito? Abbiamo bisogno di trattori sempre più potenti, di robot che svolgano questo o quel compito al posto degli uomini, delle loro mani e delle loro menti? È accettabile che alcune persone mangino frutta dall’altra parte del mondo in inverno mentre altre non possono permettersela in estate?
La pratica quotidiana dell’Atelier Paysan, nei suoi corsi di formazione e nel lavoro collettivo, riflette questo interrogativo e questo lavoro di chiarificazione delle nostre dipendenze. Siamo in grado di affermare che l’autonomia non consiste certo nel liberarsi da tutte le dipendenze, ma nel fare un inventario delle dipendenze che ci rendono schiavi e di quelle che ci rendono più liberi. Lo strumento che non possiamo mantenere e riparare da soli, per il quale dipendiamo da un ente che ha un (quasi) monopolio tecnico e che ci fa pagare molto per i suoi servizi, questo strumento ci rende schiavi. Se sai come mantenerlo, se puoi farlo riparare da un artigiano locale con cui puoi scambiare servizi, se puoi farne a meno – il mio collega ne ha un altro che farà il lavoro – allora questo strumento ti aiuterà a raggiungere l’autonomia tecnica grazie ai legami umani che si sviluppano intorno ad esso.
L’autonomia che vogliamo difendere è quindi una rottura non solo con l’individualismo contemporaneo, ma anche con il desiderio, diffuso nella modernità e coltivato dalla società dei consumi, di scaricare il lavoro materiale, i compiti di sussistenza, su altri – linee di produzione, operai o fattorini.
Lontano dall’illusione di un clic, e contro di esso, manifesta il desiderio di assumere il controllo diretto delle nostre condizioni materiali di esistenza. Non è certo un desiderio di autarchia, ma è certamente una rottura con la divisione industriale e internazionale del lavoro, che implica l’iperspecializzazione, la dipendenza alimentare e morale di ogni individuo da grandi organizzazioni tentacolari, il regno della disuguaglianza economica e dell’irresponsabilità ecologica… È un ponte gettato tra le aspirazioni e le richieste dei contadini del Nord prima del XX secolo e quelle di molti contadini del Sud ancora oggi: contadini che non chiedono di essere sollevati dalle necessità materiali della vita, come la coltivazione di ortaggi, la cura degli animali, la costruzione di strumenti di lavoro e di case in cui ripararsi, ma chiedono “semplicemente” l’accesso ai mezzi (terra, legna, acqua, ecc.) per prendersene cura, di solito collettivamente. Sappiamo bene che la strada per ristabilire un’economia di sussistenza così popolare sarà lunga e molto difficile. Per il momento, quindi, vorremmo porci un obiettivo meno lontano e più concreto: l’insediamento di un milione di contadini in Francia nei prossimi dieci anni.
Un’ultima osservazione lessicale: perché parliamo di contadini quando parliamo delle centinaia di migliaia di lavoratori che speriamo di vedere rapidamente insediati nell’agroecologia? Perché parliamo di autonomia contadina e non di autonomia agricola? Non siamo ingenui, condividiamo la constatazione che in un Paese come il nostro i contadini sono sostanzialmente scomparsi, se ci atteniamo a una definizione rigorosa del termine. In passato, il termine “contadino” non si riferiva a un’occupazione, ma piuttosto a uno status in cui l’appartenenza a una comunità di villaggio (o di “campagna”) e la produzione dei propri mezzi di sussistenza erano caratteristiche essenziali. Dopo la Seconda guerra mondiale, l’emergere dell’agricoltore come imprenditore che cerca di specializzarsi per essere competitivo, anche con i suoi vicini, era in contrasto con la condizione contadina.
Quando la nozione di agricoltura contadina è emersa, prima da parte dei contadini-lavoratori negli anni ’70 e poi da parte della Confédération paysanne a partire dal 1987, era sostenuta dal progetto di ricreare un’agricoltura contadina, non necessariamente identica in tutto e per tutto a quella antica – cosa che non sarebbe né auspicabile né possibile – ma libera dagli aspetti più critici dell’integrazione dell’agricoltura nel capitalismo industriale, quella che è stata chiamata “modernizzazione agricola”. L’Atelier Paysan si inserisce in questo filone, l’agricoltura contadina, pur rimanendo consapevole di ciò che ci separa dai rurali del pre-novecento. Per noi questo termine è un segno sia del passato che del futuro, e speriamo di vedere i contadini insediarsi in gran numero negli anni a venire, non gli imprenditori. Siamo consapevoli del disprezzo di classe che talvolta viene mostrato nei confronti di questi ultimi. Vediamo la tensione identitaria tra una parte e l’altra, troppo spesso mantenuta da entrambe le parti, come un ostacolo a qualsiasi cambiamento di direzione importante. Vedremo più avanti che possiamo essere critici nei confronti di alcuni atteggiamenti diffusi nel movimento contadino, che richiamano l’attenzione su un paradosso: una parte significativa dei nuovi contadini proviene da famiglie estranee alla comunità contadina, mentre la maggior parte dei contadini sopravvissuti proviene da quella stessa comunità – il che ci porterà, a volte, a parlare di “contadini storici”.
Il nostro manifesto è organizzato in cinque capitoli. Il primo fornisce una panoramica storica dell’industrializzazione dell’agricoltura. Sottolinea il ruolo della meccanizzazione in un processo sociale guidato dall’ossessione di ridurre il costo della produzione alimentare e di eliminare sempre più contadini. Il secondo tenta di individuare i fattori che assicurano il mantenimento di un modello agricolo intensivo, criticato da ogni parte, e che bloccano il sistema: gli accordi di libero scambio e la politica europea, il potere delle industrie che prosperano su questo modello di produzione alimentare, il ruolo strategico di un sindacato maggioritario che orchestra sia l’eliminazione degli agricoltori sia la loro rabbia contro il resto della società, la proliferazione degli standard e così via.
Nella terza sezione, esaminiamo il cuore di quella che consideriamo una delle armi di distruzione di massa del mondo agricolo, e di coloro che vi contribuiscono quotidianamente, da parte del complesso agroindustriale: le tecnologie agricole, imposte nella più totale impunità per decenni. Nella quarta, sviluppiamo l’ipotesi che l’esistenza di un mercato di prodotti alternativi, che si suppone sfuggano ai difetti della produzione industriale, contribuisca anche alla stabilità del modello in questione. Spieghiamo anche perché l’esplosione di alternative non riesce a scuotere il complesso agroindustriale e il suo modo di produzione.
Per questo, nell’ultimo capitolo, chiediamo una ripoliticizzazione profonda del movimento contadino di cui facciamo parte. Proponiamo di combinare il perseguimento delle nostre pratiche alternative con un ampio lavoro di educazione popolare e con la creazione di rapporti di forza intorno a tre grandi piste politiche: la fissazione di prezzi minimi d’ingresso per i prodotti importati in Francia, una proposta già avanzata dalla Confédération paysanne poco tempo fa; la socializzazione del cibo, con in particolare il progetto di una Sicurezza Sociale per l’Alimentazione, su cui stanno lavorando insieme diversi collettivi; infine, un movimento di lotta contro la robotica agricola e per una riduzione della tecnologia in agricoltura. Riteniamo che sia essenziale costruire un fronte unito attorno a queste proposte se vogliamo porre fine alla corsa infernale ai costi di produzione più bassi e rendere possibile l’insediamento di un milione di agricoltori nel breve periodo. Si tratta di una questione della massima urgenza per una società minacciata da sfaceli economici, alimentari, ecologici, sanitari e sociali.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.
agricolturaAltri Mondi / Altri ModiCRISI CLIMATICAECOLOGIAFranciaL'atelier Paysan