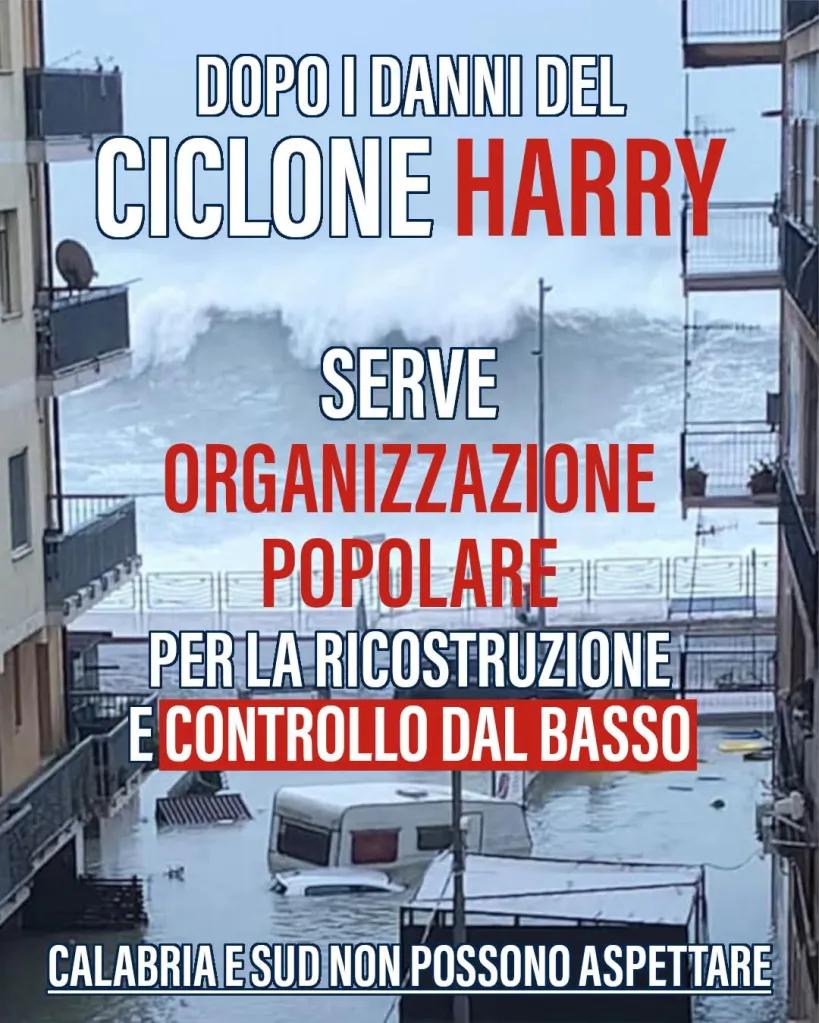Zone di sacrificio e territori in lotta: intervista a Paola Imperatore (II PARTE)
Abbiamo invitato Paola all’assemblea che si è tenuta mercoledì 7 maggio al centro sociale Borgesa di Avigliana, in cui hanno partecipato istituzioni locali, comitati No Tav di bassa Valle, il coordinamento Pendolari Valsusa, docenti del liceo Norberto Rosa, e tant* giovani che animano la vita politica della nostra Valle.
da notav.info
Ci sembrava importante condividere e sostanziare con tutt* una riflessione che da qualche tempo si sta discutendo all’interno del Movimento: i primi due cantieri stanno cominciando a mostrare le loro conseguenze disastrose sul nostro territorio, un terzo sta per essere installato e sarà potenzialmente il più impattante su tutto l’eco-sistema (ambientale, economico e sociale) valsusino. Vediamo sempre meno risorse stanziate per il nostro territorio, servizi basilari dal trasporto pubblico all’istruzione, dalla sanità alle opere per il dissesto idro-geologico, sempre più in difficoltà, il tutto per dirottare denaro su guerra e grandi infrastrutture che hanno funzioni “dual-use” (civile e militare).
La Val di Susa è stata eletta a zona di sacrificio in favore di una opera “strategica” (ma per chi?) e non importa quanta devastazione, impoverimento, disastri ambientali, perdita di biodiversità, salute, abbandono della propria terra dovrà costare al territorio e all* valsusin*, noi siamo solo un “prezzo che loro sono disposti a pagare” per il loro obiettivo.
Ribellarsi a questo destino già segnato è ciò che ci sta muovendo oggi a continuare una lotta trentennale e quella dello scorso sabato è solo la prima tappa di un percorso per continuare a liberarci da un colonizzatore interno e garantirci la possibilità di un futuro.

Qui la prima parte.
************
Passando alla reazione delle comunità a questo tipo di paradigma, tu hai fatto un grande lavoro di ricerca sulle lotte ambientali del nostro territorio. Ti volevamo dunque chiedere se hai notato delle omogeneità, degli elementi che hanno accumunato il ribellarsi a questo tipo di imposizione sul proprio territorio e sulle proprie comunità e quali sono, secondo te, le rivendicazioni ambientali che sono riuscite a emergere maggiormente all’interno della tua ricerca.
Partirei dalle peculiarità, per poi andare invece ai tratti generali, e parto dalle tipicità perché sono state proprio quelle su cui all’inizio mi sono soffermata di più. Incontrando, all’inizio del mio percorso, il territorio di Carrara e andando ad approfondire cosa significasse il settore estrattivo lapideo sul territorio, uscivano tantissimi record nazionali: record di polveri sottili, record di morti, record di indebitamento pubblico. Ampliando un po’ lo sguardo ad altri territori, ti rendevi conto che questa condizione che sembrava eccezionale in realtà purtroppo era una condizione di straordinaria ordinarietà: ognuno aveva un record, ma quei record messi insieme ti davano la cartina tornasole, la fotografia di una realtà in cui la violenza ambientale è profondissima e capillare, ed è insita a questo meccanismo. Penso, quindi, che sia stato importante portare lo sguardo fuori per capire che nessun territorio può dirsi estraneo a questo sfruttamento e che, nella misura in cui il sistema produce costantemente questa violenza ambientale, è necessario riconnettere queste lotte in una prospettiva più ampia.
Sicuramente ogni luogo ha le sue peculiarità, sia come tipo di infrastrutture che come storia ambientale. Attraverso e grazie alle persone che ho incontrato, ho appreso che il processo trasformativo che ogni territorio intraprende è il frutto di storie diverse e di lotte che hanno radici lontane e che hanno lasciato in eredità un bagaglio di saperi e relazioni per l’emergere di nuove battaglie.
Riconoscere la processualità delle lotte è stato molto importante perché aiuta a uscire dalla dicotomia vittoria-sconfitta e permette di leggere i movimenti come un fenomeno carsico che si palesa solo in alcuni momenti, ma che al contempo, nel substrato della comunità, sedimenta nuovi processi giorno per giorno.
Quindi penso che, sicuramente, la differenza sta nelle tante storie ambientali che sono peculiari: c’è chi ha lottato contro il militarismo, chi ha avuto la lotta contro Xylella, chi le lotte in fabbrica come Marghera (che poi sono state fondamentali nel Movimento No Grandi Navi). Ogni territorio è un intreccio di storie che poi riemergono e riaffiorano in queste lotte.
Credo, però, che gli aspetti comuni siano quelli più importanti da evidenziare in prospettiva politica e trasformativa. Mi sembra fondamentale sottolineare questo aspetto perché, sia in Italia che su un piano più generale, è presente una lettura della lotta politica molto concentrata sui contesti urbani, di fabbrica o comunque in situazioni in cui in qualche modo c’è una struttura di capitale politico e sociale, dimenticandoci così di tutti questi territori, zone di sacrificio, zone marginali, che in realtà costituiscono ancora un’ampia fetta di paese.
In Italia, più del 60% della popolazione vive in piccoli e medi centri urbani o in aree rurali, quindi, capite bene, che questo non è un aspetto che possiamo trascurare e dimenticare. Ed è proprio quella parte di comunità che spesso non ha altri strumenti di attivazione politica che trova in queste lotte il modo di rilanciare il proprio protagonismo portando i margini al centro.
Giocando anche un po’ sulla parola “margine”, mi sembra anche importante sottolineare che, sebbene parliamo di aree marginali, abbiamo a che fare con un fenomeno che non è marginale, perché le lotte legate alla difesa del territorio sono uno dei fenomeni più capillari e strutturali in Italia, in cui il livello di mobilitazione che si può raggiungere sprigiona una capacità molto importante.
Uno degli altri elementi che caratterizzano queste lotte è la capacità di essere capillari e di innescare dei processi politici in contesti molto eterogenei. Questa, secondo me, è un’altra condizione fondamentale, perché fa in modo che, proprio nello spazio comunitario, si riesca a costruire un nuovo linguaggio politico che non trova come forma solo l’assemblea o il volantino, ma trova lo stare insieme come rinnovata forma di politica.
Devo dire che, almeno nella mia esperienza, quello che mi ha insegnato di più questa ricerca, (che poi è diventata anche un rapporto ovviamente umano) è stata la capacità di questi territori di ricostruire comunità attraverso due processi paralleli: da un lato quello dipoliticizzare i rapporti umani e quindi intorno a quelle relazioni trovare anche un senso politico e dare delle spiegazioni politiche a quello che succede nelle nostre vite; dall’altro quello di umanizzare i rapporti politici e quindi trovare una forma di rapporto umano che portasse le relazioni, comprese le tensioni politiche, su un piano comunque di mutuo riconoscimento e di collaborazione.

Un esempio che mi viene sempre in mente, anche se non è l’unico, è quello delle Mamme No Tap e delle Mamme No Muos per le quali, il fatto di trovare uno spazio politico per riconoscersi e organizzarsi, ha significato iniziare a dare un nome a problemi comuni. Uno di questi era la presenza di moltissime famiglie con figli e figlie con malattie ambientali, problemi che venivano vissuti come una vergogna e un dolore individuali e affrontanti come una fatica individuale, ma che proprio nello spazio della lotta sono state collettivizzate.
In questa collettivizzazione non solo c’è, ovviamente, un riconoscimento reciproco, ma anche la capacità di iniziare a dare un nome ad un problema e a individuare i responsabili: se non è solo mio figlio o solo tua figlia che ha una malattia ambientale, ma i nostri figli e lenostre figlie vivono tutte strutturalmente questo problema, allora chi è che li e le ha avvelenate e a chi dobbiamo chiedere il conto di quello che è successo? Si tratta, quindi, di una struttura che, come dicevo prima, a partire dai rapporti umani innesca un processo politico.
Questo meccanismo si può vedere anche sotto altri punti di vista: per la prima volta in questi territori si creano sostanzialmente dei movimenti femminili che diventano poi intrinsecamente anche femministi, anche se non parlano questo linguaggio.
Per la prima volta delle casalinghe e delle donne che per lo più avevano una vita confinata alla sfera privata, usano la maternità come questione politica, la portano in piazza, la mobilitano e lo fanno in un modo che fa impazzire le autorità, perché le istituzioni impazziscono ad avere di fronte ai cantieri e ai blocchi stradali queste madri e cercano, di conseguenza, di dipingere su di loro l’immagine di cattive madri che, anziché stare a casa a proteggere i propri figli scendono in strada. Tutto ciò, nel suo insieme, innesca in queste donne un processo di coscientizzazione politica rispetto alle dinamiche di potere patriarcali che attraversano i rapporti dentro lafamiglia, e fuori, rispetto allo Stato. In questo senso, tutto quello che si innesca all’interno di un processo di lotta, non è meno importante del dove stiamo andando. Infatti, mentre si procede in una direzione cambiano le relazioni quotidiane e il modo in cui lo facciamo, cambiamo noi stessi come individui e come collettività.
Questa è proprio la dimensione trasformativa che hanno i territori e che credo vada riconosciuta maggiormente.
Nella maggior parte dei casi, uno degli altri aspetti che hanno in comune questi territori, è stata la mancanza di una prospettiva politica, ovvero la capacità di dare un senso ad un certo percorso anche oltre l’obiettivo immediato. Questo è quello che ci aiuta a capire perché, da 30 anni, assistiamo ciclicamente al nascere ma anche all’esaurirsi di numerosi cicli di lotta. Ne vediamo nascere tantissimi ma sappiamo anche che altrettanto velocemente la maggior parte di queste lotte muore o comunque, in qualche modo, tende un po’ ad esaurire il proprio ciclo espansivo.
Penso che proprio questo sia il punto da cui ripartire, immaginare qual è il nostro traguardo.
Ad esempio, affrontando questo argomento insieme ad altri compagni e altre compagne del Movimento No TAP, loro stessi hanno riflettuto su qual fosse il loro obiettivo: se lo scopo era fermare il TAP allora non ci siamo riusciti se l’obiettivo, invece, era quello di costruire un altro tipo di società allora ci troviamo un passo più avanti perché proprio nel camminare verso l’obiettivo di bloccare il gasdotto si sono innescate così tante cose che nessuna persona è oggi quella che era dieci anni fa, né singolarmente né come collettività, perché quest’ultima non esisteva prima della lotta.
Quindi io credo che la lotta sia lo spazio dove si costruisce la comunità perché poi nominata così la comunità non vuol dire niente, se la mettono in bocca tutti, tanto gli imprenditori quanto le banche quanto le istituzioni: le comunità non esistono di per sé, sono il frutto delle lotte. Quindi penso che i territori siano lo spazio dove materialmente possiamo fare comunità, senza la quale ogni altra forma di lotta – ecologista, di classe e femminista – non può crescere, non può consolidarsi, non può avere futuro.
A partire dai tuoi studi e ricerche, in una valle come la nostra molto antropizzata, quali possono essere le conseguenze principali e più impattanti sul territorio e sulla popolazione se tutto verrà (come già in parte sta accadendo) sacrificato a causa della costruzione della linea ad alta velocità Torino-Lione?
Tornando al tema grande opera come paradigma, uno degli elementi che lo caratterizza è la funzione regolatrice che svolge rispetto a tutti i processi che la circondano: la grande opera, prima o poi, diventa l’epicentro intorno al quale si ridisegna e ripensa tutto il territorio.
La grande ambizione del capitale è quella di fare del territorio un foglio bianco dove si può depositare dall’alto verso il basso qualsiasi opera e progetto secondo una logica meramente economica, rimuovendo così la sua storia, la sua identità, il suo substrato di relazioni. La grande opera, oggi, agisce esattamente in questo modo perché diventa l’elemento che ridisegna e giustifica ulteriori interventi invasivi, da un lato chiamate compensazioni, dall’altro chiamate opere collaterali necessarie.
Riflettendo sul fatto che intorno alla realizzazione del Tav si è innescata un’altra serie di opere collaterali necessarie che probabilmente verranno terminate ancor prima che l’intero progetto venga realizzato, mi viene da pensare a una situazione che viviamo anche nel nostro territorio, tra Pisa e Livorno, in cui, intorno alla base militare statunitense di Camp Derby, si è sviluppata tutta un’economia militare che, sostanzialmente, nel corso degli anni è andata ad allargare e aggiungere basi militari, comparti, pezzi legati alla funzione e alla costruzione di un hub logistico. Quindi da Camp Derby a Cisam, poi all’aeroporto civile, poi la Folgore, poi l’Accademia Navale e gradualmente questa infrastruttura ha iniziato a trasformare tutto il territorio espandendosi oltre le aree maggiormente limitrofe.

Questo è esattamente il frutto di quel meccanismo di scambio ineguale che dicevamo all’inizio, che crea coscientemente un meccanismo di dipendenza: la grande opera dove arriva lascia il deserto, cancella ogni traccia di socialità, società ed economia esistente per rimporre il proprio modello monoculturale, diventando l’unica economia che si assume persino la prerogativa di essere l’unica opzione nel territorio. Il gioco del ricatto arriva così: prima arrivo in un territorio che ha una complessa rete di economie e relazioni sociali e successivamente le asfalto tutte perché nego la possibilità di queste altre forme di riprodursi, a quel punto mi presento come unica opzione arrogarmi il diritto di mettere la comunità di fronte al ricatto “o me o niente”.
Tutto ciò evidenzia la dimensione relazionale dell’infrastruttura che – in quanto paradigma di governo del territorio – arriva e trasforma il sistema di relazioni esistenti, cancellandole.
Quello che sta avvenendo oggi in Valsusa intorno ai temi dei pendolari, delle stazioni, delle linee ferroviarie che vengono chiuse per fare spazio a questi cantieri, fa capire qual è la direzione, l’ambizione del capitale: creare un territorio spopolato in cui non c’è più nessuno a fare resistenza e che quindi si presta bene a un intervento di questa entità.
Questa forma di violenza infrastrutturale che impatta e trasforma il rapporto quotidiano che abbiamo col territorio e tra le persone che lo abitano ci pone anche di fronte alla sfida di capire come agire quando abbiamo a che fare con una violenza che non è spettacolare ma lenta, che scava ogni giorno, che si insinua nel nostro territorio, nelle nostre comunità, andando a frammentarle e impoverirle un poco alla volta.
Paola Imperatore svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Pisa. I suoi interessi di ricerca includono la giustizia ambientale, l’ecologia operaia e le politiche climatiche. Ha pubblicato insieme a Emanuele Leonardi per Orthotes Editrice, L’era della giustizia Climatica. Prospettive politiche per una transizione ecologica dal basso, nel 2023. Nello stesso anno, per Meltemi Editore, pubblica Territori in lotta. Capitalismo globale e giustizia ambientale nell’era della crisi climatica.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.
cantieri tavdevastazione ambientaleno tavPaola Imperatoreval susazone di sacrificio