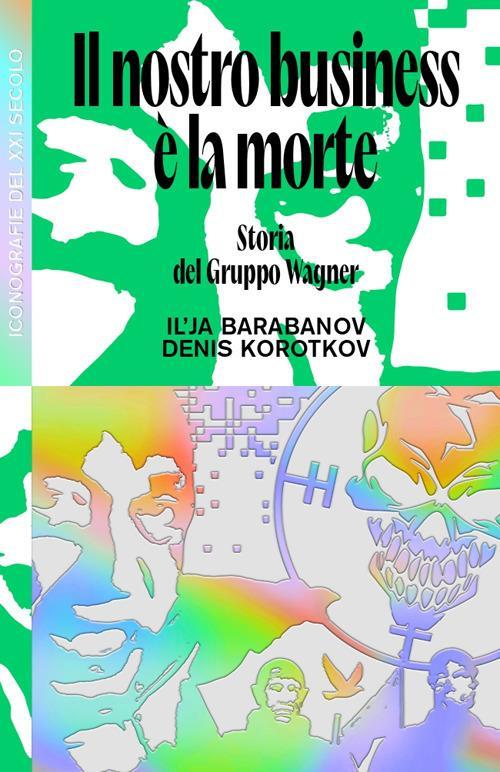La trama alternativa – Sogni e pratiche di giustizia trasformativa contro la violenza di genere
La lettura di questo testo di Giusi Palomba, pubblicato da Minimum Fax nel marzo 2023, apre a moltissime riflessioni, dubbi e prospettive. Partiamo dall’ assenza nel nostro paese di un dibattito costruttivo e condiviso su come affrontare le violenze in maniera trasformativa e non punitiva.
In tantə possiamo riconoscerci nelle storie e nelle pagine di questo libro, rivivere e rianalizzare con strumenti nuovi esperienze dolorose sia personali sia politiche perché il personale è sempre politico.
Abbiamo scelto di riportare tante citazioni per far parlare l’autrice e restituire il più possibile la profondità di questo lavoro: qui affronteremo solo alcuni nodi, senza pretesa di essere esaustivə.
Non è semplice scegliere da che trama partire, con che ordito farla intersecare. Il nodo fondamentale è la prospettiva politica di cambiamento delle relazioni dentro le comunità, chiedendosi cosa queste siano e non siano e di come si possano costruire anche in contesti annichiliti dalle logiche neoliberiste e individualiste. Un cambiamento che si prenda la responsabilità di affrontare anche i lati oscuri delle comunità: violenze, soprusi, molestie di genere e non solo.
“L’approccio alle relazioni che ci propongono viene chiamato trabajo de procesos. «I conflitti sono dei processi naturali, addirittura necessari al cambiamento. E un lavoro profondo su di sé e sulle relazioni interpersonali li tramutano in strumenti potentissimi, capaci di smascherare rapporti di potere e ottenere trasformazione e cambiamento». Queste parole all’inizio mi sembrano quelle di una setta hippie, ma entriamo nel vivo e qualcosa inizia a scricchiolare. Gli esercizi di autocritica proposti scalfiscono i miei giudizi facili di superficie. Non si risolvono i conflitti ricercando soltanto la verità dei fatti, ci dicono, ma anche rendendo palesi gli squilibri di potere. La facilitazione serve a sviluppare la capacità di ascoltare anche le voci più disturbanti, quelle che non vogliamo sentire. Perché nessuno può trasformarsi senza ricevere supporto dal suo ambiente circostante. Quando parliamo di comunità che si dedicano a lavorare per un cambiamento nella società, affrontare i conflitti diventa cruciale per proseguire il lavoro. Come possiamo cambiare il mondo se non sappiamo gestire nemmeno un conflitto interno?
Il lavoro interiore è attivismo. È il senso di inadeguatezza personale il primo conflitto da risolvere per me, ora lo vedo dietro ai commenti sbrigativi.” (p. 81)
Il testo parte da un’esperienza personale in cui l’autrice vive, da non protagonista, una di queste esperienze:
«Nella comunità di quartiere è stato aperto un protocollo per abuso sessuale. Questo significa che Bernat ha abusato di una donna e la donna ha scelto di rivolgersi a noi per pensare insieme a un processo di riparazione e trasformazione. Abbiamo chiesto a Bernat di seguire un percorso collettivo per comprendere l’impatto della sua violenza e per cercare di ripararla. E lui ha accettato». (p. 43)
Nella prima parte del libro “Lo strappo” seguiamo il processo di riparazione e trasformazione attraverso il flusso e le scelte di Mar, la persona che ha scelto di affrontare questa violenza con la sua comunità di riferimento e non attraverso l’intervento della giustizia istituzionale, e lo smarrimento dell’autrice dentro questo processo in cui lei è coinvolta in quanto amica di Bernat.
“Non deve essere rilevante stabilire la verità. Ora la priorità della comunità è occuparsi delle cause e delle conseguenze. Stanno cercando di dirci che anche la via d’uscita dal nostro shock passa per accogliere le richieste della sopravvivente, intraprendere lo stesso percorso. […] Ogni passo è una maniera di affermare un principio: la responsabilità è collettiva.” (p. 47; p. 53)
Il presupposto di tutte le riflessioni sulla giustizia riparativa e trasformativa è vedere, accettare e così trasformare l’interiorizzazione di una mentalità punitivista, elaborare la rabbia e il desiderio di vendetta e renderli motore di azione e trasformazione, distruggere la dicotomia vittima/carnefice e puntare lo sguardo verso il contesto che ha permesso alla violenza di esistere avviando un processo di responsabilizzazione.
“Così come sono possibili la rabbia e il desiderio di punire, lo è anche quello di trasformarsi: esiste, ma è semplicemente più difficile da intercettare, perché dall’esterno l’imperativo è rafforzare soltanto il desiderio di punizione, alimentarlo più che si può. Punitivismo non è soltanto chiamare la polizia davanti a una scena di violenza, ricorrere al sistema penale per risolvere un problema sociale: sono le parole di stizza dette a un’amica in difficoltà, a un parente che non soddisfa le aspettative familiari, a un dipendente sul posto di lavoro che non raggiunge un obiettivo, a una relazione intima da cui pretendiamo qualcosa che non ci può dare. Sono le reazioni saccenti e acide sui social, che scatenano discussioni infinite.” (p.126)
Parlando di punitivismo si esplicita la lontananza con il femminismo carcerario e si abbraccia l’abolizionismo, articolando esempi e riflessioni teoriche (la maggior parte, purtroppo, non disponibile in italiano).
“Se tu sostieni che il carcere non funziona, ci sarà sempre qualcuno che ti citerà un personaggio tipo Ted Bundy. Succede dappertutto. Marguerite [Schinkel] ha ragione, la narrazione fa un’enorme fatica a cambiare. Ogni volta che si parla di abolizione, l’obiezione riguarda sempre le più orrende forme di violenza, e si continua a ignorare che i percorsi abolizionisti riguardano soprattutto la prevenzione di quella violenza, l’intercettazione dei segnali più precoci, l’educazione, la costruzione di fondamenta per pratiche alternative.” (p. 112)
“il processo della giustizia criminale non funziona, perché spezza le comunità. Alla fine, né le vittime, né i cosiddetti criminali si sentono ascoltati. Vogliamo capire come rompere la narrazione dominante che dà la prigione per scontata, perché parlando con chi è stato dentro, ma anche con chi lavora nelle prigioni, ci si accorge che nessuno pensa che il sistema stia funzionando davvero. Quello che facciamo è un lavoro educativo per persone comuni, perché è tra le persone comuni che si fabbrica e si rafforza l’idea che chi sbaglia merita punizioni dure. Parlando vengono fuori dettagli imprevedibili, ad esempio che a volte le persone hanno vite così difficili che è più semplice andare in prigione. A volte sono senza casa o hanno bisogno di una maniera per gestire la dipendenza dalle droghe, e arrivano a commettere quelli che sono considerati crimini minori per poter tornare dentro, perché all’esterno non hanno nessun supporto. Ci sono ragazzi che trascorrono dentro i loro vent’anni, con sentenze brevi, senza mai ricevere stimoli significativi dalla società. Da grandi si guardano indietro, smarriti, e si accorgono che la vita gli è sfuggita di mano».” (Pp. 110-111)
Nell’esperienza narrata nella prima parte del testo viene riportata l’azione di un gruppo femminista che interviene esponendo pubblicamente alla gogna Bernat, senza il consenso della sopravvivente che chiede di fermare la pratica perché non rispetta le sue richieste e sarebbe controproducente rispetto al percorso in corso:
“Quella rabbia non ci è estranea, la riconosciamo. È il senso di impotenza che sceglie l’azione collettiva e si tramuta in potenza. In fondo non ci sorprende che qualcuna abbia pensato di agire in quel modo contro Bernat. È stato così tortuoso arrivare a rendere visibile la violenza di genere nella vita pubblica, che è arduo pensare di dover rinunciare allo strumento che l’ha permesso. E probabilmente abbiamo ancora bisogno di stare nello spazio di quella rabbia, repressa, stigmatizzata, ridicolizzata e sminuita per così tanto tempo.
Ma tenendo presente tutto questo, come si relaziona questa rabbia che vuole rimanere tale, riconoscibile in quella specifica forma, o meglio, che vuole dispiegarsi in azioni diverse da quelle decise nel nostro processo? […]
Tutta una classica e confortevole tradizione politica ci chiede soltanto: schieratevi e basta, e poi escludetelo, allontanatelo, boicottatelo. Sarebbe così semplice, ma semplice non è la parola giusta. Sarebbe popolare e giustificatorio, non desterebbe così tanto scalpore. E dall’altra parte, la comunità in un processo trasformativo ci invita a negare quelle pratiche, e contribuire a crearne un’altra nel nostro orizzonte e vedere che succede, ed è difficile a volte non sentirsi un po’ come se fossimo cavie” (p. 73, p.74)
Nella seconda parte del testo si parla di “Una trasformazione possibile” ossia l’abolizione di carceri, polizia e punizioni come di un processo pensabile e organizzabile perché “il futuro desiderato inizia dai passi fatti nel presente necessari a raggiungerlo”.
È in questa parte del libro che vengono esposte le teorie, gli studi, gli esempi e le pratiche di questa trasformazione possibile. Pagine dense di esempi dalla cronaca attuale e storica in cui si scrive di serie, di libri, di teatro e social network evidenziando sempre come la violenza abbia a che fare col potere (più che col genere!) e di come questo sia gonfiato dai messaggi e dalla mentalità neoliberista che promuove individualismo, competizione e prestigio. Nella pagine sui social viene evidenziato come molto spesso i messaggi neoliberali coincidano con quelli di influencer “femministe” ma la community non è affatto una comunità trasformativa e il l’“oppressione comune” legata al genere possa essere un mito del femminismo riformista.
“«Giustizia e punizione non sono la stessa cosa e dopo un evento drammatico questa differenza a volte non è chiara. Ad esempio, c’è differenza tra un intervento temporaneo per risolvere un problema in uno specifico nucleo familiare e l’estremo di rinchiudere una persona in prigione oppure negarle il cibo e un tetto sopra la testa». E questa confusione tra giustizia e punizione solitamente ha esiti drammatici che vengono ignorati o normalizzati. Jess mi dice che nelle loro attività hanno spesso a che fare con persone giovani, più interessate a portare avanti conversazioni e a porsi domande che ad acquisire i toni assertivi dell’attivismo online, e tra loro il punitivismo sembra non sia ancora totalmente sedimentato.” (p. 81)
I quattro capitoli della seconda parte vanno a fondo e parlano anche del lavoro con gli uomini e degli uomini:
“Quello che hanno in comune un uomo subalterno del Sud Italia a volte difficile da gestire nel circolo intimo della sua famiglia, uno schiavista scozzese del Settecento che invece ha esercitato violenza in ogni ambito della sua vita, e un giovane della Londra di oggi alle prese con pressioni e oppressioni identitarie e sociali, è la difficoltà a sentirsi, vedersi, essere percepiti come vulnerabili. È il fatto che non esista per loro altro modo di essere uomini se non attraverso il distacco dai propri sentimenti e, a tratti, o sempre, anche da quelli delle persone intorno” (p. 173)
Un senso di invulnerabilità che è una richiesta implicita della società patriarcale e uno dei suoi fondamenti. Riprendendo bell hooks si va oltre un femminismo che ha avuto difficoltà a occuparsi dei sentimenti degli uomini perché non riusciva a pensare una società nuova.
Giusi riporta diversi esempi di discussione tra uomini per il cambiamento mostrando la cruciale differenza tra chi dichiara di essere femminista e chi invece prova a stare nel femminismo.
“Per i motivi elencati da Montero, e non solo, l’insistenza di attaccarsi addosso la parola femminista a volte mi preoccupa. Perché l’etichetta in certi casi sembra fungere da meccanismo di difesa – «guarda che io sono femminista!» – e perché quando si inizia ad andare davvero a fondo, ci si rende conto che lavorare su se stessi è un processo lungo, pieno di ricadute, fatto in spazi scomodi, che è un po’ il lavoro che tocca a chiunque voglia capire un’esperienza che non vive sulla propria pelle. Allora, qual è la priorità, potersi dire femministi o il desiderio di raggiungere un risultato utile e condiviso?” (p. 179)
Si parla degli stereotipi legati alla maschilità egemonica e delle possibilità, ma soprattutto i rischi dei gruppi di soli uomini. Qui diventa più difficile riconoscere il machismo di chi, usando strumenti intellettuali per controllare, manipolare a proprio favore gli argomenti punitivi, abusa del proprio potere.
Si parla anche dei processi drammatici nel nostro paese, come quelli legati alla bigenitorialità e alla presunta sindrome di alienazione parentale.
Tutto il libro si basa sulla fiducia che questi non siano solo sogni ma possibilità da sperimentare e approfondire:
“Le situazioni in cui c’è violenza – ecco il cuore dell’approccio trasformativo – sono spesso conseguenza di un’ingiustizia, il frutto di una disuguaglianza, e dunque il perseguimento della giustizia non può che passare attraverso la ricerca di strumenti per trasformare l’esistente, per cambiare quelle condizioni iniziali cosicché il danno non si verifichi più. Non si tratta in questo caso di trovare un finale alternativo, ma di riscrivere l’intera trama.
adrienne maree brown sottolinea che il modo in cui lo facciamo è fondamentale, innanzitutto comprendendo che le istituzioni sono così interconnesse con la giustizia punitiva da non essere d’aiuto nella maggior parte dei casi.
Per mettere in pratica questo ambizioso progetto di decostruzione, abbiamo bisogno di nuove figure comunitarie, nuovi ruoli, infrastrutture votate al benessere collettivo e che nascano a partire dal basso e non calate dall’alto.” (p. 204)
Mia Mingus, autrice citata nel testo, afferma come negli interventi di giustizia riparativa i fattori più importanti siano relazione e fiducia. In contesti in cui queste pratiche vengono portate avanti da decenni si inizia a parlare di qualcosa di più di comunità, si usa il termine pod:
“per indicare quei tipi di relazione significativi che si attivano per la giustizia trasformativa. Sarebbe bello rimanere al significato botanico – pod è letteralmente un «baccello» – perché ne immagino anche il futuro di germoglio e di pianta, ma la traduzione che probabilmente si avvicina di più è quella di «nucleo» o «circolo intimo», di cura e supporto. […] Secondo l’esperienza della maggior parte delle persone che praticano giustizia trasformativa, è più efficace concentrare le energie su ciò che già esiste e far sì che cresca e prosperi, invece di preoccuparsi di organizzare da zero grandi masse di persone tramite analisi politiche indecifrabili o troppo semplicistiche e chiamarle comunità (o community). Le relazioni preesistenti di fiducia e cura sono invece più efficaci davanti alla violenza.” (p. 227)
Chiudiamo ringraziando Giusi Palomba per questo prezioso testo che tiene insieme letture di classe, genere e razza e propone un orizzonte di possibilità, di azione, di critica allo Stato come istituzione e al cupo destino prestabilito di chi subisce violenza. In questi mesi assistiamo attonitə alla normalizzazione della guerra, massima espressione della violenza patriarcale, che determina la forma della società in cui viviamo e agiamo. Il riconoscimento di queste contraddizioni ci permettere un ampio spettro di possibilità. Affrontarle ci consente di esplorare, liberare energie e sviluppare la potenza di un conflitto contro lo status-quo che sia credibile e profondo.
Senza negare le difficoltà, costruendo forza collettiva in una società inibita dalla paura e dall’individualismo, ponendo nuove basi per la speranza.
“Gli anni trascorsi in contesti di attivismo avrebbero dovuto rendermi più facile la prossimità col mondo degli ideali. La realtà è che pure gli ideali si consumano, si svuotano, subiscono gli stessi processi di usura di tutti i meccanismi che mancano di manutenzione, e si lasciano contaminare e corrompere come tutto il resto. Mariame Kaba, educatrice e organizzatrice comunitaria statunitense, scrive: «La speranza è una disciplina». Ed era questo il tassello mancante.”
(p. 198)
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.