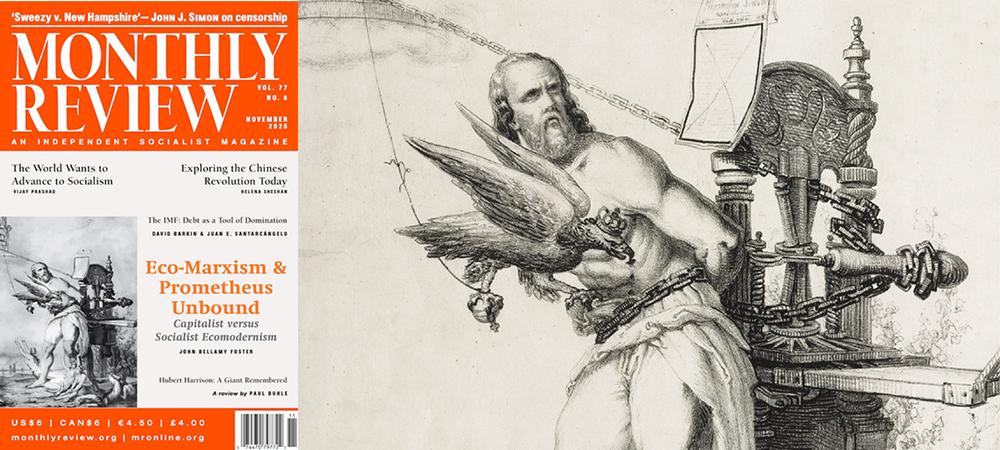Proprietà collettiva contro il Capitalocene
“I rapporti di proprietà capitalistica sono il nucleo del modello sociale ed economico dominante e sono anche la causa fondamentale dei cambiamenti irreversibili prodotti negli ecosistemi di cui facciamo parte. Viviamo nell’era del Capitalocene, non in quella dell’Antropocene.”
Il presente testo è la traduzione di un articolo di Rubén Martínez (La Hidra Cooperativa) pubblicato in castigliano su Público il 27/01/2022.
Chiudendo una centrale a carbone si può frenare il riscaldamento globale per un giorno; chiudendo i rapporti che hanno prodotto la centrale a carbone lo si potrà fermare per sempre.
Nel suo libro Capitalism in the web of life [Il capitalismo nella rete della vita], Jason W. Moore lancia questa suggestiva affermazione che riassume il problema principale della nostra epoca. Un problema che non ha la sua origine nell’impatto sull’ambiente derivato dal bruciare combustibili fossili considerando che, in realtà, ciò è conseguenza di un modo particolare di organizzare la produzione e il consumo. Non c’è niente di male nel considerare la diminuzione delle emissioni di anidride carbonica un obiettivo politico prioritario. La confusione inizia quando, nel perseguire questo obiettivo, non vengono toccate le cause originarie. I malintesi aumentano quando viene segnalato come colpevole un soggetto etereo e omogeneo che esiste come unità soltanto nella nostra immaginazione: l’umanità. A quanto pare, come conseguenza della sua inesauribile voracità e della sua cecità davanti a tutto ciò che le provoca piacere o le dà soldi, l’umanità è la colpevole del collasso del pianeta.
Spesso questo racconto viene chiamato Antropocene. Inaugurando una nuova era geologica, l’Antropocene mette in risalto l’influenza determinante delle attività umane sul pianeta. Da una prospettiva puramente descrittiva, non c’è dubbio riguardo la responsabilità umana nella distruzione accelerata della biosfera e nel cambiamento climatico. L’errore risiede nel non rendersi conto che si tratta di un’azione umana plasmata da rapporti di potere privilegiati politicamente che permettono a certi gruppi sociali con interessi specifici di sottomettere altri essere viventi umani e non umani. Definire la nostra era come Antropocene rischia di inserire qualsiasi persona e territorio dentro quell'”umanità” definita come causa. In questo modo, vengono cancellati i rapporti di potere sociali e spaziali e, in generale, le profonde dinamiche di ingiustizia e di disuguaglianza esistenti fra classi sociali e fra territori.
Nelle visioni più superficiali dell’Antropocene, l’azione e la responsabilità del 10% più ricco della popolazione globale appare esattamente uguale a quella di qualsiasi altro essere umano, malgrado questo gruppo sociale esclusivo sia la fonte del 50% delle emissioni. Queste disuguaglianze non esistono soltanto fra gli Stati, ma anche all’interno dei singoli territori. In Spagna, ad esempio, il 10% più ricco provaca emissioni fino a sette volte maggiori rispetto al 10% più povero. Una delle principali cause della perdita di biodiversità —circa l’87% dal 1970— è lo sviluppo del modello agroindustriale, ma a detta di molti i colpevoli sono “gli umani”. Secondo il concetto “l’umanità è colpevole”, la popolazione del Ghana, Paese dell’ovest africano con la discarica di rifiuti elettronici più grande al mondo, rientra nello stesso gruppo delle persone che vivono nei territori dove il consumo tecnologico pro capite è altissimo. La verità è che la divisione internazionale del lavoro non solo trasforma i Paesi del Sud del mondo in discariche o in fornitori a basso costo di materie prime e di manodopera, ma porta anche i territori che contribuiscono meno al cambio climatico a essere i più vulnerabili rispetto alle sue conseguenze.
Se il nostro impegno è quello di organizzare una politica di trasformazione, affermare che la responsabilità del cambiamento climatico è di origine umana o antropogenica rende la questione più confusa, nella misura in cui malinterpreta i conflitti sottostanti e diluisce i rapporti di potere in gioco. I rapporti di proprietà capitalistica sono il nucleo del modello sociale ed economico dominante e sono anche la causa fondamentale dei cambiamenti irreversibili prodotti negli ecosistemi di cui facciamo parte. Viviamo nell’era del Capitalocene, non in quella dell’Antropocene.
Lontano dal naturalismo descrittivo dell’Antropocene, il Capitalocene contestualizza un’era dominata dal capitale, senza astrarsi dai rapporti storici del capitale, della classe e dell’impero. L’Antropocene guarda in modo sbagliato verso le conseguenze sull’ambiente. Sotto il Capitalocene, viene data priorità ai rapporti produttore/prodotto. Il capitalismo ha organizzato rapporti stabili fra gli essere umani e fra essi e il resto della natura, alla ricerca di un processo di accumulazione inarrestabile. “La natura” che “l’umanità” sta sfruttando ed esaurendo, e che a quanto pare scatena la sua vendetta sotto forma di disastri ecologici, viene in realtà internalizzata nella circolazione e nell’accumulazione di capitale. Il capitale è un insieme di rapporti ecosistemici inserito in modo straordinariamente conflittuale nel continuo ecosistemico che definisce il pianeta Terra. Il capitale non deve soltanto accumulare e rivoluzionare continuamente la produzione di merci. Come spiega Jason W. Moore, il capitale deve anche cercare e trovare senza sosta modi di produrre nature a buon mercato: una corrente crescente di cibo, lavoro, energia e materie prime che, nel loro insieme, configurano l’unità di sfruttamento del capitalismo.
Se l’intenzione è quella di frenare questo torrente di rapporti che privilegiano l’accumulazione senza fine del capitale, quali strategie e quali misure politiche possono essere sviluppate? Quali potrebbero essere i contenuti di un programma di politiche pubbliche per frenare quei processi, o quantomeno per fornirci strumenti per produrre un qualche tipo di cambiamento strutturale? Se analizziamo i programmi delle politiche pubbliche che promettono di conciliare crescita economica, transizione ecologica e giustizia sociale, i cosiddetti Green New Deal, ci renderemo conto che una certa dimensione risulta completamente assente in tutti loro, dal piano federale di energia verde capitanato dalla parlamentare statunitense Alexandria Ocasio-Cortez all’European Green Deal e i suoi programmi integrati nei Next Generation.
Oltre che ignorare i limiti biofisici del pianeta che rendono impossibile andare avanti con l’attuale spirale di crescita, in nessuno di quei piani si propone la possibilità di un minimo cambiamento nei rapporti di proprietà dominanti. Non promuovono nemmeno la nazionalizzazione delle aziende di combustibili fossili o il controllo e il regolamento dei monopoli esistenti. Semmai il contrario: includono la creazione di aziende pubblico-private nel settore ecologico e di sussidi per aziende private del settore dell’energie rinnovabili. In sintesi, questi piani puntano a facilitare l’espansione dell’accumulazione attraverso la via verde, guidata dagli stessi rapporti di sfruttamento e di appropiazione che hanno generato il problema. Facendo qualche giro, finiscono per spianare la strada alle logiche compulsive dell’accumulazione di capitale.
Alcune figure tra quelle che portano avanti una nuova versione socialdemocratica del capitalismo, come Rebeca Henderson o Mariana Mazzucato, prendono per buoni quei patti verdi a condizione che venga aperto un dibattito sulla distribuzione delle ricompense delle nuove alleanze pubblico-private. Mazzucato insiste nel imporre più condizioni alle aziende e nell’aggiungere meccanismi di controllo pubblico. Henderson punta a realizzare accordi etici fra gli investitori, gli azionisti e le aziende, in modo che l’imperativo del profitto non derivi in un saccheggio dei beni pubblici. Se c’è qualcosa che stupisce in questi approcci è la loro timidezza politica. La capacita di trasformazione di programmi che non mettono in discussione le loro modalità di controllo politico, i loro modelli di finanziamento e i sistemi di proprietà è tra dubbia e nulla. Se quello che si vuole è fare riforme, un’altra possibilità sarebbe salire di un gradino nell’ambizione e che coloro che si definiscono come difensori della socialdemocrazia prendano la questione un po’ più sul serio.
Oltre al New Deal degli anni Trenta, esistono altri punti di riferimento nella storia europea che appaiono ormai completamente dimenticati. Fra gli altri, i fondi di investimento dei salariati, un meccanismo che permetteva a sindacati e ad altre associazioni della società civile di ottenere un controllo sostanziale sul funzionamento delle grandi aziende. Davano diritto a ricevere profitti, al voto per l’elezione del consiglio di amministrazione e a decidere sulle politiche delle compagnie. Queste istituzioni di democrazia economica, disegnate da Rudolf Meidner negli anni Settanta, non solo sono utili per contrastare il potere concentrato del capitale, ma possono essere anche la base materiale per un’organizzazione sociale della produzione e del consumo legato al territorio. Oggi, sebbene le condizioni materiali degli anni Settanta siano irreproducibili, lo spirito di trasformazione del piano Meidner dovrebbe essere una fonte di ispirazione.
Un’agenda politica di emancipazione dovrebbe prendere come uno dei suoi principali obbiettivi il trasferimento della proprietà degli asset produttivi combinato con la democratizzazione delle decisioni ambientali. Sotto l’European Green Deal è prevista l’intesificazione dell’investimento in infrastrutture verdi e in energie rinnovabili, nella ristrutturazione di edifici e case con criteri di efficienza energetica o nelle industrie legate alla mobilità a basso consumo di carbonio. Quello che sarebbe giusto ed efficiente da un punto di vista tanto sociale quanto ecologico sarebbe che, propoporzionalmente all’investimento pubblico iniettato, venga applicata la socializzazione dei diritti di uso e di usufrutto alle infrastrutture e beni legati a quei settori. Sarebbe qualcosa di più ambizioso rispetto alle proposte attuali, ispirato a comunità di energia rinnovabile con diritto di generazione, di immagazzinamento, di consumo (includendo l’autoconsumo) e di vendita di energia rinnovabile. Queste forme di proprietà collettiva decentralizzata non sono affatto la soluzione a tutto il pasticcio sistemico, ma possono rappresentare una tattica di rottura con i rapporti di produzione e di consumo dominanti. Potremmo iniziare a definire qualcosa come “fondi azionari di cittadinanza” riguardo beni e infrastrutture, con l’obiettivo di decarbonizzare la matrice energetica e aumentare la sua efficienza. Servirebbero istituzioni pubblico-comunitarie che riescano a erodere il potere concentrato degli oligopoli e del capitale finanziario, a redistribuire risorse e a darci potere di organizzazione e di decisione, in modo da essere in grado di spingere per una transizione desiderabile.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.