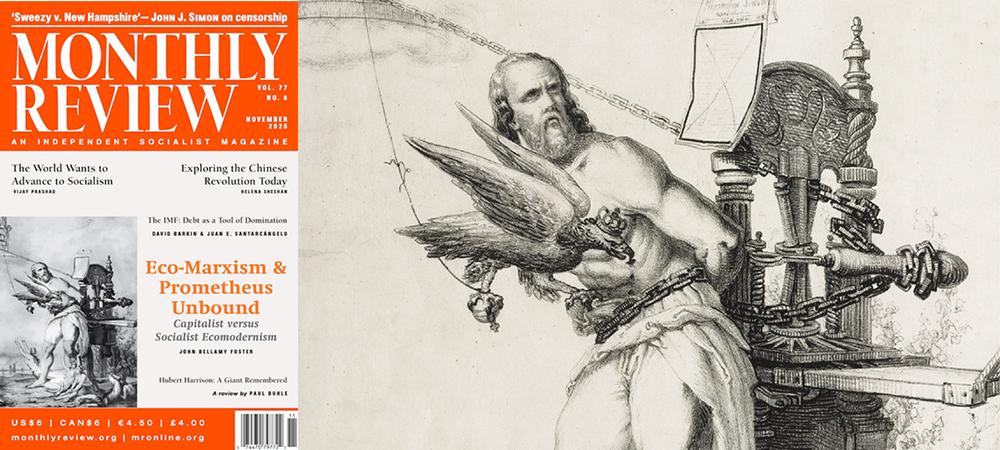Cina: la fine di un’illusione

Molti credevano che la Cina avesse scoperto il segreto della crescita perpetua. Ma gli esempi del passato avrebbero dovuto suggerire prudenza
Quiz: qual è stato il primo paese al mondo a vantare un tasso di cre- scita economica a due cifre? La Cina? Risposta sbagliata. Il Giappone faceva registrare già nel 1948 un tasso di crescita del 15 per cento, e il suo miracolo economico è durato trent’anni. Nei primi anni settanta il record del Giappone è stato battuto dalla Corea del Sud, e qualche tem- po dopo Taiwan ha toccato il 14 per cento.
Ma solo nelle fiabe si vive per sempre felici e contenti. Dall’inizio del nuovo millennio il tasso di crescita dell’economia giapponese langue sotto l’un per cento. Negli ultimi dieci anni la Corea del Sud ha superato di poco il 3 per cento e Taiwan non è andata oltre il 4 per cento. Il miracolo dei “piccoli draghi” è già finito. Cosa ha a che fare tutto questo con la Cina, il grande drago che ora versa in una crisi finanziaria mortale e ha svalutato la sua moneta per la prima volta in dieci anni? La Cina è stata per decenni un motore dell’economia mondiale. Ma ora il miracolo economico più lungo di tutti i tempi sta sfumando. Vent’anni fa il tasso di crescita cinese aumentava all’incredibile ritmo del 15 per cento all’anno. Oggi si è ridotto di oltre la metà.
Il clamore suscitato dall’economia cinese è stato ancora più forte della sua crescita. Nel 2003 un gruppo di economisti della banca d’investimento Goldman Sachs pubblicò il rapporto Dreaming with Brics, secondo cui il futuro apparteneva al Brasile, alla Russia, all’India e soprattutto alla Cina, che stando ai loro pronostici nel 2040 avrebbe spodestato gli Stati Uniti diventando la prima economia del mondo. Altri studiosi hanno raddoppiato la scommessa: la Cina sarebbe diventata il numero uno già nel 2020. Nel 2009, in un libro intitolato When China rules the world, un autore britannico annunciava la “fine del mondo occidentale”.
Nel 2015 è arrivata la doccia fredda: la Russia ha perso il 4,6 per cento, il Brasile l’1,6. La recessione ha preso il posto della crescita. I fan dei Bric sono caduti nel tranello che da sempre insidia i profeti: hanno proiettato il passato sul futuro. Se ieri è andata così, anche domani andrà così. Ma la storia non procede in linea retta.
La storia si ripete
Gli adoratori della Cina avrebbero dovuto leggere meglio la storia economica dell’Asia orientale. Quando uscì Dreaming with Brics i piccoli draghi erano da tempo in calo verticale. L’analogia con la Cina era chiara: a tutti quei paesi era imposto dall’alto lo stesso modello di crescita. La formula magica era “primo esportare”, e le regole dicevano: più investimenti, meno consumi, svalutare la moneta e aumentare il protezionismo.
Dal 1980 al 2010 in Cina la spesa per gli investimenti ha raggiunto il 50 per cento della produzione, mentre ai consumi era destinato il 40 per cento. Per fare un confronto, la Germania spendeva il 18 per cento in investimenti e il 57 per cento in consumi. Così la Cina è diventata un gigante che ha schiacciato i nani dell’occidente.
Ma neanche il più accorto capitalismo di stato riesce a contraddire la legge dei rendimenti decrescenti: se compri un trattore, il raccolto per ettaro di terra aumenta di colpo. Se di trattori ne compri cinque, a partire dal secondo gli utili crescono sempre meno. Nel caso della Cina, negli anni novanta cento milioni di yuan investiti facevano aumentare il pil di 66 milioni. Dieci anni dopo lo stesso investimento ha generato un incremento pari alla metà.
A ciò si è aggiunta la maledizione del nuovo benessere che ha colpito anche i piccoli draghi: più si arricchivano, più la loro crescita rallentava. Taiwan ha raggiunto il punto critico nel 1980, la Corea del Sud dieci anni dopo. Sulla Cina la maledizione si è abbattuta solo in questo decennio. Il motivo è l’altra faccia della crescita: l’esplosione dei salari. Nel 1976, quando Deng Xiaoping annunciò le “quattro modernizzazioni”, il salario annuo medio dei lavoratori cinesi era di 615 yuan. Oggi supera i 50mila, pari a circa settemila euro. Naturalmente c’è stato un enorme aumento della produttività, ma secondo uno studio del Boston consulting group i salari degli operai cinesi sono aumentati a una velocità doppia rispetto alla produttività. Confrontando salario e produttività, dieci anni fa un lavoratore statunitense guadagnava cinque volte più di un cinese. Oggi il vantaggio dell’industria cinese in termini di costi è sceso al 15 per cento, perché i salari sono aumentati quasi cinque volte più velocemente di quelli statunitensi, mentre il divario di produttività sussiste. Calcolando i costi dei trasporti e degli approvvigionamenti, esternalizzare la produzione in Cina conviene sempre meno.
Di conseguenza la produzione si sposta dalla Cina verso paesi meno cari come il Vietnam, oppure torna negli Stati Uniti. È la stessa cosa che è successa al Giappone, a Taiwan e alla Corea del Sud. Aveva ragione Karl Marx: il capitale non ha patria.
Maledizione demografica
Qualcuno dirà che non si può confrontare la Cina con i piccoli paesi asiatici, che hanno esaurito rapidamente il loro esercito industriale di riserva, cioè i contadini poveri che si sono trasferiti nelle città e hanno tenuto bassi i salari per anni. La Cina invece può ancora contare su centinaia di milioni di agricoltori. Ma questa spiegazione non funziona, e l’aumento esplosivo dei salari cinesi basta a dimostrarlo. La ragione è una maledizione demografica senza precedenti. Anche per effetto della politica del figlio unico, il tasso di fecondità dei cinesi è crollato a livelli europei (circa 1,4 figli per ogni donna in età fertile), mentre negli ultimi cinquant’anni l’aspettativa di vita è quasi raddoppiata. La statistica suggerisce che la Cina invecchierà prima di diventare ricca.
Cifre del genere dovrebbero far ricredere chi pensa che il miracolo economico cinese possa durare in eterno perché il governo è in grado di attingere a una fonte inesauribile di manodopera. Quest’anno in Cina la forza lavoro si è ridotta per la prima volta, mentre aumenta l’esercito dei pen- sionati. Lo confermano le proiezioni delle Nazioni Unite, secondo cui nel 2025 la Cina avrà un quinto della popolazione mondiale e un quarto degli anziani. Perché questi dati dovrebbero frenare la crescita? Primo, perché nonostante i robot la produzione richiede sempre più lavoratori. Secondo, perché una popolazione che invecchia sottrae risorse, che vengono spese per la sanità e le pensioni. E il modello di crescita della Cina esige investimenti sempre maggiori per ogni posto di lavoro.
Ma il disastro demografico agisce sul lungo periodo, mentre la crisi del capitalismo di stato sta avvenendo oggi. Il problema è che le risorse sono mal distribuite. Pechino s’illude di aver trovato la quadratura del cerchio: capitalismo più potere assoluto. Effettivamente, soprattutto da quando Xi Jinping è diventato presidente, la Cina obbedisce alla tesi di Lenin secondo cui il partito deve occupare le “posizioni di comando dell’economia”, ovvero le imprese di stato. Il loro numero è in calo, il che dovrebbe lasciare più spazio ai privati. Al tempo stesso, però, le loro dimensioni sono aumentate esponenzialmente.
Il problema lo svela l’istituto Tianze di Pechino. Gli utili dichiarati provengono soprattutto dagli sgravi fiscali, dai crediti delle banche di stato e da altre sovvenzioni. Negli ultimi dieci anni i sussidi hanno raggiunto gli 820 miliardi di dollari, ma gli utili sono stati 670 miliardi, quindi il saldo è negativo. Insomma, lo stato si regala soldi da solo, proprio come hanno fatto i piccoli draghi urante la loro modernizzazione pilotata. Inoltre, il capitalismo ha bisogno di mercati dei capitali aperti, liberi e vasti, di cui la Cina non dispone. In mancanza di alternative, i cinesi stanno buttando in massa i loro risparmi in investimenti immobiliari, come dimostrano i milioni di alloggi vuoti. La conseguenza è la crisi finanziaria di questi giorni. Il modello cinese di modernizzazione autoritaria si sta esaurendo. Il motto del partito comunista (“Arricchitevi, ma scordatevi il potere”) si scontra con la realtà.
I regimi dittatoriali di Taiwan e della Corea del Sud hanno dovuto democratizzarsi di fronte all’aumento del benessere, e lo stesso ha dovuto fare il Giappone, abbandonando il suo sistema a partito unico. Man mano che si arricchiscono, i cittadini chiedono partecipazione. Invece in Cina cresce la repressione: il partito teme che dietro ogni richiesta di libertà ci sia una nuova Tiananmen. Quel trauma ha insegnato al partito che il potere va conservato a ogni costo, tanto più che nel 1989 l’economia subì una contrazione del sette per cento. Senza la ricchezza, come farà il partito comunista a conservare la sua legittimità?
Il regime autorizzerà alcune riforme, ma non si rinnoverà come hanno fatto i piccoli draghi. Al confronto con l’occidente, una crescita del 7 per cento è ancora favolosa. Ma i tempi in cui la Cina suscitava scalpore e ammirazione con il suo 15 per cento di crescita all’anno sono finiti. Ecco perché la stagnante economia mondiale non può aspettarsi la salvezza dalla Cina.
Josef Joffe, Die Zeit, Germania (traduzione a cura di Internazionale)
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.