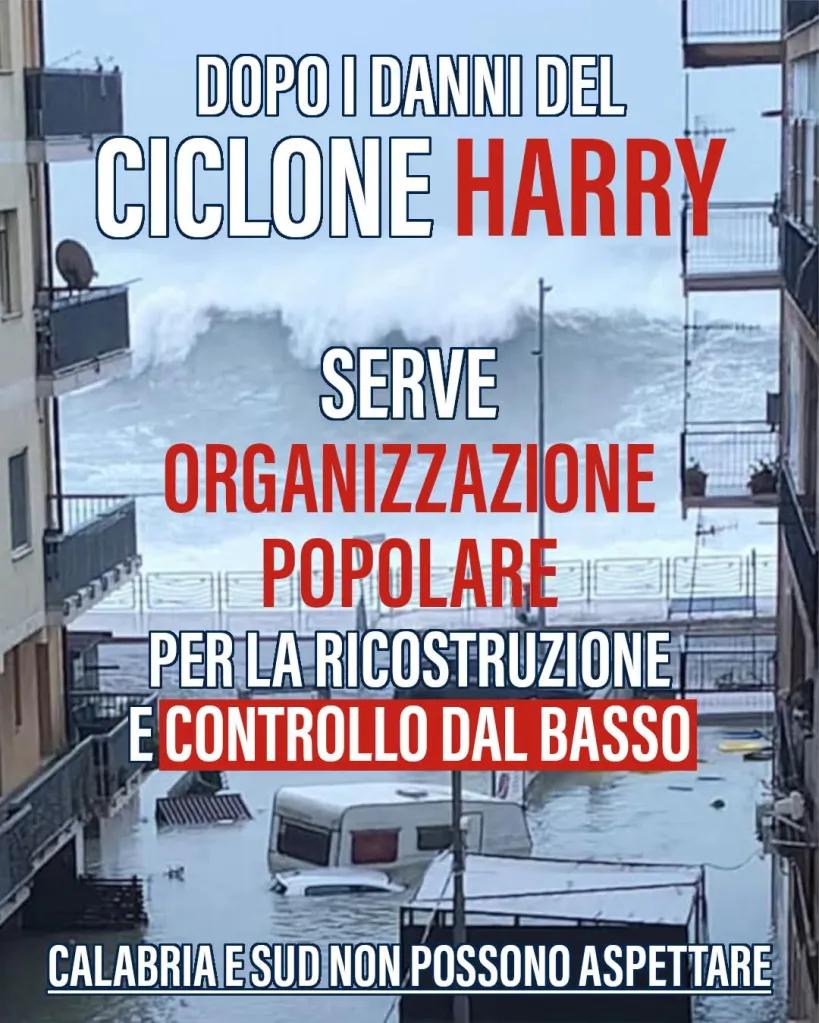Il paradigma ‘grandi opere’ e il caso MOSE

Ne abbiamo parlato con Paolo Cacciari, giornalista free-lance veneto, autore di un commento sul Manifesto di oggi:
{mp3remote}http://www.infoaut.org/images/paolo_cacciari_mose.mp3{/mp3remote}
Qui di seguito, l’articolo di Paolo Cacciari uscito oggi sul Manifesto
Mose bipartisan, ecco l’origine perversa del «partito del fare»
l progetto della chiusura delle bocche di porto della Laguna di Venezia, il più grande intervento di ingegneria civile mai costruito in Italia, è stato il prototipo delle «grandi opere». In tutto. Nella filosofia emergenzialista che lo presiede — la grande alluvione del 4 novembre 1966 sembrava giustificare una decisione rapida e rassicurante, in barba ad ogni esigenza di approfondimento degli studi scientifici.
Nella delega concessa al sistema delle imprese private giudicato dai decisori politici il più competente ed efficiente non solo nella realizzazione delle opere, ma anche nella loro ideazione e progettazione – condannando le università, il Cnr e gli organi tecnici dello stato a fare da supporto servente alle imprese. Nella deroga alle procedure ordinarie di affidamento, verifica e controllo delle opere pubbliche – date in concessione ad un unico soggetto, anticipando il meccanismo del general contract. Nel generoso ricorso al credito bancario (a proposito dei motivi che hanno generato il debito pubblico!) – procedura che poi sarà perfezionata con il project financing.
Il Consorzio Venezia Nuova nasce nel 1982 sotto gli auspici di De Michelis (Partecipazioni Statali), Nicolazzi (Lavori Pubblici) e Fanfani (presidente del Consiglio). Comprende tutte le maggiori società di engineering pubbliche e private, dalla Impresit della Fiat (a cui subentrerà la Mantovani) alle Condotte d’acqua dell’Iri. E poi: Lodigiani, Maltauro, Impregilo fino alle cooperative emiliane CCC. Primo presidente del CVN è Luigi Zanda, proveniente dalla segreteria del ministro Cossiga.
Negli stessi anni nasce anche il Tav e il Ponte dello Stretto di Messina. L’Italia del «fare» — per chi ha perso la memoria — nasce allora.
Ma per superare gli evidenti vizi giuridici di un’opera affidata in concessione a trattativa privata e per di più su un «progetto preliminare di massima» mai approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ci fu bisogno di una legge speciale (legge 798 del 29 novembre del 1984). Ad opporsi fu solo il Pri con il ministro Bruno Visentini, come io stesso riconoscevo in un saggio di tanti anni fa, Appunti per una storia del Progettone («Oltre il ponte», n. 17, 1987), in cui definivo l’oggetto della convenzione tra Stato e CVN: «un insieme di opere ancora indeterminate, tutte comunque assicurate da una forma di pagamento a piè di lista».
Nasce così lo strapotere del CVN in città e non solo. Crocevia di smistamento di ogni genere di appalti, anche quelli non direttamente afferenti al Mose. Punto di equilibrio degli interessi bipartisan.
A dire il vero un ripensamento ci fù all’epoca di Tangentopoli. Con una legge del 1993 (n.527, art. 12, comma 11) si dava mandato al Governo di «razionalizzare» le procedure di intervento a Venezia così da «separare i soggetti incaricati della progettazione dai soggetti cui è affidata la realizzazione» e costituire una agenzia pubblica. Inutile dire che nulla sostanzialmente fu fatto per mutare la situazione. Nemmeno quando nel 1998 la Commissione nazionale per la Valutazione dell’Impatto Ambientale dette un parere sostanzialmente negativo al progetto.
In soccorso del Mose giunse la nuova Legge Obiettivo di Lunardi-Berlusconi (2002) che ha consentito ai vari governi, da ultimo quello Prodi con Di Pietro ministro ai Lavori Pubblici (con un voto a maggioranza nel Consiglio dei ministri), di avocare a sé le decisioni tecnico-progettuali e di approvare definitivamente il Mose nel 2006. Fu il colpo di grazia anche per i movimenti ambientalisti e l’assemblea permanente contro il Mose. Da allora una valanga di massi, cemento e ferro è stata scaricata sulle bocche di porto. Il Consorzio Venezia Nuova aveva vinto. Ora sappiamo che sei miliardi di finanziamenti diretti, più tutti quelli per le opere complementari di difesa a mare del litorale, di consolidamento delle rive e delle fondamenta, di restauri vari, sono il prezzo con cui il «partito del fare» (e del rubare) si è comprato la città.
Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.